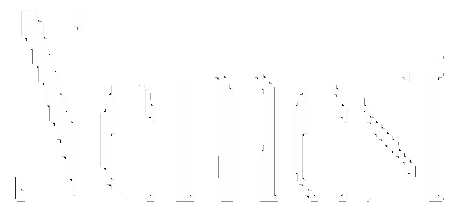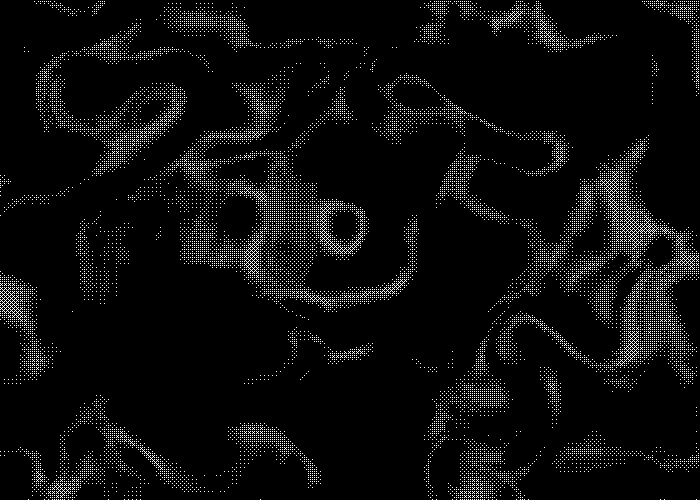Nel Saggio sulla cecità, Saramago immagina che l’intera popolazione smetta di vedere. All’epoca sembrava un incubo; oggi potrebbe essere una salvezza. Questo periodo storico è ossessionato dallo sguardo e tutto viene immediatamente registrato e diffuso. L’atto stesso di vedere è diventato consumo.
Il minuto di silenzio, nato all’inizio del Novecento in Portogallo, come un momento di raccoglimento è stato uno degli strumenti moderni utili a trasformare un dolore in memoria pubblica. La collettività sincronizzata nel tempo e nel corpo, finanche nel respiro. In quel vuoto, che non sospende soltanto la parola ma l’intero ordine simbolico, si rivelava la forza di ciò che non si dice e che, proprio nel non dirsi, si manifesta.
Adesso il minuto di silenzio avrebbe bisogno di essere accompagnato da un minuto di cecità. Da un tempo nel quale si interrompe il flusso delle immagini, in cui non fotografiamo né registriamo, in cui smettiamo di consegnare ogni gesto ai dispositivi che trasformano l’ideologia e la vita stessa in contenuto.
Come nel film Un cane andaluso, bisogna perforare l’occhio, dissolvere l’economia dell’immagine e lasciare spazio a un’esperienza non immediatamente mediabile.
Basta osservare una scena: Piazza Duomo, Milano, una protesta contro l’assalto israeliano alla flottiglia. Un minuto di silenzio. Tutti con lo smartphone acceso. Registrano, postano. Nulla di illegittimo, documentare significa mostrare la compattezza di un popolo, rendere visibile la sua presenza, il suo corpo sociale, la sua voce comune. Ma in quell’istante una contraddizione esplode: il silenzio, nato come sottrazione o meglio, come sospensione, diventa contenuto. Non siamo fermi, non contempliamo, continuiamo a produrre, quindi a lavorare.
Lutto, rabbia, indignazione sono immediatamente assorbiti dal meccanismo che li rilancia come surplus di visibilità.
In questi giorni il dibattito italiano si sta polarizzando; tutti si chiedono se la piazza serva o no. Ma è la domanda corretta?
I più ingenui, gli esseri più vergognosi e ripugnanti, diranno che disturbare il traffico, rallentare i lavoratori, bloccare un camionista sia sbagliato. Obiezioni bieche riflesso di un’ideologia servile. È chiaro che bisogna organizzarsi con intelligenza, garantire corridoi per i servizi essenziali in modo da non colpire i fragili. Ma il prezzo di un ritardo al lavoro, di un turno saltato, di un disagio temporaneo è minimo rispetto alla posta in gioco. Chi pretende che non si debba disturbare nessuno difende in realtà solo l’inerzia della propria vita ridotta a ingranaggio. Ogni lotta ha un prezzo, e quel prezzo va pagato.
Scendere in piazza è giusto e non bisogna sprecare nemmeno un attimo per convincere chi si macchia di un pensiero tanto malsano da credere tra un impiegato-zombie e civili uccisi in un genocidio, sia più urgente il primo. Queste persone non hanno cuore e non hanno ideali, sono schiave e non dobbiamo averne cura.
Ma il nodo della questione è un altro: sempre più spesso, assediare le piazze e le vie principali delle città significa, attraverso uno strano bisogno di scopica autorappresentazione, alimentare piattaforme che monetizzano ogni immagine, ogni parola, trasformando il dissenso in flusso di valore per gli stessi circuiti che alimentano le guerre e ne gestiscono la rappresentazione.
L’infrastruttura che assorbe le proteste è la stessa che sostiene l’economia bellica. I grandi contractor — Lockheed, RTX, Northrop, General Dynamics, BAE, Leonardo (finanziata da molte delle nostre università pubbliche) — registrano ricavi record, perché la domanda è una struttura permanente, non eccezionale né tanto meno emergenziale. In parallelo, Palantir e Anduril vendono sistemi di comando e di visione predittiva, accumulando contratti miliardari con USA e NATO. Google e Amazon offrono i loro cloud all’esercito israeliano. Il conflitto si gioca anche lì: nello spazio dei dati, nell’integrazione fra guerra e informazione.
E mentre in piazza alziamo i telefoni, trasferiamo valore a piattaforme che appartengono a questi stessi circuiti o ne dipendono: X orbitata da Musk, Meta con Facebook e Instagram, YouTube in mano ad Alphabet. Ogni abbonamento Premium, ogni moneta virtuale, ogni post, ogni reel, rovesciano la retorica della visibilità come emancipazione e divulgazione.
Ci illudiamo di accumulare forza e consenso, ma ciò che realmente facciamo è accumulare fonti di reddito per chi arma i conflitti.
Il minuto di cecità è una provocazione utile a spezzare questa catena perché se continuiamo a offrire i nostri volti alle piattaforme, a fornire dati che addestrano gli algoritmi, a consegnare perfino le immagini dei nostri figli, allora cosa resta della protesta? Nulla, se non un’immensa banca dati utile alle stesse macchine che organizzano la guerra. Negli anni Settanta i fogli, la carta e le riviste militanti erano anch’essi tecnologia, ma una tecnologia che, una volta prodotta, non apparteneva a nessuno. Le piattaforme non funzionano così, bensì sono proprietà privata, recinti che fingono democraticità e apertura a un pubblico vasto, ma concentrano tutto il potere in un centro.
Il punto è che la tecnologia non è neutra, ma è un dispositivo giuridico e politico che cattura la cooperazione sociale e la privatizza. Ogni atto collettivo, per esistere, deve superarla, non attraversarla. E allora la domanda diventa semplice: siamo disposti a pagare il prezzo di rinunciare? non per tornare indietro, ma per creare spazi non mediati, spazi nuovi.
I social sono il campo del nemico. Non si combatte con le sue armi. Non si combatte nei suoi palazzi. Asserire che le piattaforme sono il nostro campo di battaglia è un errore di prospettiva, sono spazi con regole unilaterali. E mentre condiviamo l’ennesimo post strappalacrime di Tlon o de IlNemico fornendo like e condivisioni, forniamo dati, aumentiamo il valore della pubblicità e di tutta l’infrastruttura da cui pretendiamo di liberarci.
Il cinema distopico lo ha capito. In The Lobster, i solitari si rifugiano nei boschi. In Children of Men, la resistenza vive nelle rovine, lontano dalla città. In The Hunger Games, i distretti marginali diventano il nucleo dell’insurrezione. La periferia è il luogo dove il potere non può convertire il esto in spettacolo, ma con le piattaforme, la periferia e il margine si sposta verso il centro e ritorna dov’era velocemente, senza incidere. Forse i margini non esistono nemmeno più, abitiamo i centri ipercontrollati di Instagram, TikTok, Facebook, Substack. Non siamo dissidenti, siamo sudditi. Per questo bisogna disertare. Spegnere i social. Smontare il corpo digitale. Non più sciopero della fame, ma sciopero dell’immagine. Non più sacrificio del corpo fisico, ma distruzione del corpo visivo che abbiamo consegnato alle piattaforme. Non abbiamo bisogno di dire “guardate quanti siamo”: dobbiamo solo esserci. Riconoscerci senza specchio, senza feed, senza contatori.
L’altro snodo è forse quello più ostico da trattare: un popolo che non sa difendere sé stesso non può difendere nessun altro. Un popolo che protesta per i diritti altrui ma non conquista i propri, che scende in piazza un giorno e il giorno dopo torna alla precarietà, che non lotta per il lavoro o la sanità, è un popolo già svuotato. La solidarietà senza radici interne diventa un surrogato della propria impotenza. Senza istituzioni che lo rappresentano negli ideali e negli intenti, senza organizzazione, senza rappresentanza reale, ogni energia si disperde e la protesta diventa l’ennesima mobilitazione senza conseguenze reali.
Se in Spagna Sánchez ha potuto introdurre misure concrete che incidono sul rapporto con Israele, bisogna domandarsi perché qui non abbiamo la stessa forza. Forse con la stessa foga dovremmo saper ottenere i nostri diritti, non per mettere da parte le altre lotte, ma per costruire un terreno fertile fatto da rappresentanze politiche reali, governi che sposino ideali capaci di tradursi in azione. Perché un popolo che non riesce a difendere i propri contratti, la propria sanità, la propria casa, che si alza un giorno per scendere in piazza e il giorno dopo torna alla precarietà, non ha la forza di difendere nessun altro.