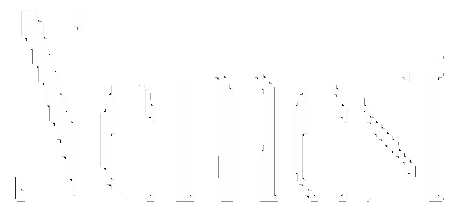“L’anima è morta, ma mangiamo bene”
Ci sono libri che non si leggono: ti denudano. Ti fanno a pezzi, senza nemmeno toccarti. De Profundis non è un libro: è un uomo in ginocchio, con il viso nella polvere, che prega – non Dio, ma il nulla. Non c’è finzione. Non c’è arte. Nemmeno bellezza, se non quella tragica che sgorga come sangue dalle costole rotte di chi non sa più a chi chiedere pietà.
Oscar Wilde non scrive per essere salvato: scrive per non scomparire, per non essere sepolto vivo sotto l’indifferenza del tempo. Scrive per restare carne, piaga, presenza. Non ha più nulla, se non la sua disfatta: e proprio quella ci offre, come pane nero. Ma noi, oggi, pieni di psicologia, di benessere, di tecniche per non sentire, non reggiamo nemmeno una pagina senza voltare lo sguardo, come bambini viziati davanti al dolore.
Perché De Profundis è più nostro oggi di quanto non lo fosse allora. Noi siamo Wilde, ma senza la sua coscienza. Cacciati fuori dalla festa, ma con un sorriso stampato in faccia. Fingiamo felicità, salute, libertà. E invece viviamo ancora, come lui dice – con una crudeltà che è anche misericordia – per l’amore degli altri, per la loro ammirazione, come cani ammaestrati. Ma non l’amore vero, quello che ti strappa e ti lacera. No: quello che si conquista, che si esibisce, che si usa per riempire il vuoto. L’amore come rendita. Come ruolo. Come status.
Ed è qui che inizia la nostra catastrofe. Wilde lo sapeva: l’amore che domanda è già venduto. L’ammirazione che si attende è già puttana. Il sentimento che serve a qualcosa non è sentimento: è merce. Il vero sentimento – quello puro – non salva, non migliora: consuma. Eppure è l’unica cosa che può ancora risvegliare, dentro di noi, il morto.
Wilde non chiede perdono. Si offre. Si espone. Racconta il dolore non come un contenuto da condividere, ma come un calvario. Scrive: “C’erano giorni in cui mi rallegravo all’idea che il mio dolore non avrebbe mai avuto fine, ma non potevo sopportare che non avesse un significato.” Parole che oggi non si potrebbero nemmeno pronunciare. Perché il dolore è diventato un errore. Un bug. Un’infrazione al codice della felicità permanente. La società contemporanea non ci chiede più di soffrire in silenzio, come quella vittoriana: ci chiede di non soffrire affatto. Ci vuole efficienti, risolti, performanti.
Ma che cos’è l’uomo, se non una crepa nel disegno divino? Se non un’interruzione del senso? Wilde, nel suo inferno privato, intuisce che la salvezza non sta nella guarigione, ma nella forma data alla ferita. Nell’architettura spirituale del dolore. E noi, che cadiamo e subito invochiamo un rimedio – un terapeuta, un algoritmo, una pillola – siamo il contrario della profondità. Perché la profondità oggi è troppo costosa. Troppo lenta. Troppo inutile.
La nostra tristezza ha un inizio e una fine, come una serie da guardare compulsivamente, in binge-watching. Wilde invece la guarda in faccia e le dice: “dimmi chi sono, ora che non ho più nulla.”
C’è una frase in De Profundis che è una bestemmia contro il nostro tempo anestetizzato. Una frase che fa male solo a leggerla: “Una natura priva di immaginazione, se non si fa qualcosa per risvegliarla, si pietrifica nella più assoluta mancanza di sensibilità, cosicché, mentre il corpo si nutre, si disseta e gode dei suoi piaceri, l’anima che lo abita può, come l’anima di Branca d’Oria, essere completamente morta.”
Questa non è una frase. È un atto d’accusa. Contro di noi. Perché noi oggi abbiamo tutto: cibo, sesso, intrattenimento, connessione. Ma l’anima — quella parte che non serve a nulla e proprio per questo era sacra — è morta. Pietrificata. E non lo sappiamo nemmeno.
Siamo come Branca d’Oria: dannati vivi. Il corpo consuma. L’identità si mostra. Ma dentro è tutto fermo. L’immaginazione è spenta. La sensibilità atrofizzata. Siamo sopravvissuti all’umano.
Wilde, nella sua cella, ci guarda. Non ci giudica: ci rivela. E ci dice che si può essere vivi, e già nell’inferno. Il dannato di oggi non è chi ama troppo: è chi non sente più niente. Chi ha barattato la sensibilità con la funzione. Il sogno con l’algoritmo. L’anima con l’identità.
Eppure Wilde poteva salvarsi: poteva tacere, farsi piccolo, accettare il compromesso. Invece ha amato. Ha sofferto. Ha scritto. Ha fatto della sua rovina un vangelo laico. Perché solo chi è stato distrutto può dire la verità. Non la verità teorica, filosofica, accademica. Ma quella che viene fuori quando si è senza più ruolo, senza più volto, senza più scampo.
De Profundis non è solo il suo grido. È il nostro. È il grido che non possiamo più gridare. Quello che ci resta strozzato in gola, perché non c’è più tempo, non c’è più lingua, non c’è più coraggio. Perché oggi ogni crepa va coperta, ogni lacrima deve valere qualcosa, ogni dolore va convertito in contenuto.
Ma Wilde è ancora lì. Ci guarda. Non ci consola. Non ci salva. Ci espone. Come un testimone: “Io ci sono passato. Tu ci stai annegando dentro. Solo che fai finta di nuotare.