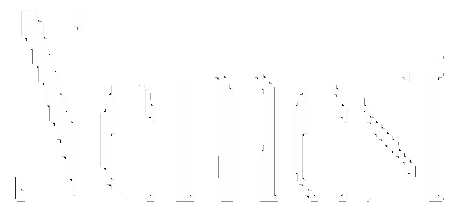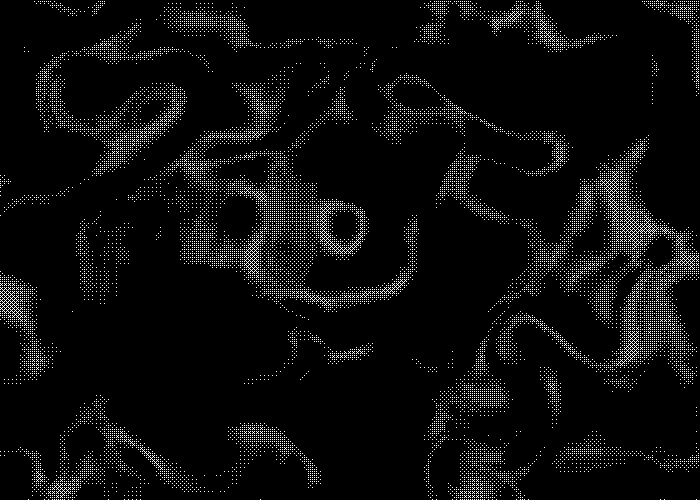Che il mio rapporto con il true crime fosse degenerato in qualcosa di patologico è stata una diagnosi tardiva, maturata dopo anni di negazione, come accade per ogni forma di dipendenza. Ne ha seguito il decorso classico: l’immediata curiosità, poi l’illusione del controllo, quindi la sottovalutazione degli effetti collaterali, infine l’abuso.
La cronaca criminale ha abitato la mia esistenza come una presenza silenziosa, una palestra morale per allenarsi all’esercizio del giudizio, un pretesto per difendere tesi senza alcuna legittimità, purché con grande convinzione. Il male offre spesso un appiglio sicuro: indiscutibilmente inaccettabile, quindi a suo modo rassicurante.
La familiarità di questa narrativa ha fatto sì che una lucida riflessione sulle ragioni della mia ossessione rimanesse per anni sospesa, incagliata in una sorta di alibi informativo. Mi stavo comunque informando di accadimenti concreti, tangibili. Se il mondo è ciò che accade ed è costituito dai fatti, informarsi dei suddetti significava informarsi di ciò che accadeva, quindi del mondo. La realtà mi assolveva dalla morbosità, rendendo il perverso più accettabile, concedendomi il privilegio di indagarlo senza conseguenze. Nell’analisi maniacale dei delitti più efferati ho a lungo creduto di scavare per comprendere, ritrovandomi invece a franare nella fossa che avevo aperto. È stata la deriva naturale di un sistema che scambia la conoscenza con l’assuefazione, che ha trasformato la violenza in narrazione e la tragedia in routine emotiva, fino a rendere il consumo del dolore un gesto quotidiano quasi virtuoso.
Il true crime si è espanso come pianta infestante e pervasiva, diventando un’ossessione collettiva che occupa stabilmente le classifiche dei prodotti d’intrattenimento più popolari, saturando lo spazio del racconto.