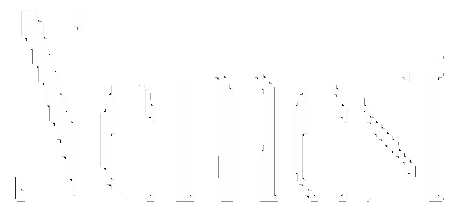Ieri sera ho visto La Voce di Hind Rajab con un amico.
In auto, durante il tragitto di ritorno, non abbiamo detto nulla: non una parola sul film, non un’opinione sulla regia o sulla sceneggiatura; niente, non avevamo il coraggio di dire niente.
La città era ancora accesa nonostante fosse piuttosto tardi; le luci dei semafori – molto verdi – sembravano star così da un po’, quasi in attesa che arrivassimo noi, consapevoli dell’imbarazzo che stavamo vivendo chiusi in quella macchina. Per il tragitto avevamo chiesto aiuto al navigatore, proprio come all’andata; solo che noi, giuro, non lo ricordavamo, e anche se lo avessimo ricordato non avremmo potuto fare granché, perché il navigatore è digitale, non conosce La Voce di Hind Rajab, o meglio, non può conoscerla, lui è costretto a ignorarla, ma non è colpa sua. Non si potrebbe mai accusare un navigatore d’ignoranza.
Nostro malgrado distavamo 8 minuti: gli stessi 8 minuti che avrebbe dovuto percorrere l’ambulanza nel film. E se avesse dovuto percorrerli nel film, li avrebbe dovuti percorrere anche lì, a Gaza, nella vita reale, il 29 gennaio 2024, per salvare Hind Rajab.
Se il navigatore avesse detto nove, dieci – qualsiasi numero – forse ci saremmo comportati diversamente, chissà. Magari avremmo scambiato qualche opinione su quello che avevamo appena guardato – espandendo i confini della tolleranza, data la delicatezza dell’argomento – o forse non sarebbe cambiato nulla. Ripensandoci, alla luce di quel profondo dolore che avevamo ascoltato lì dentro, avremmo trovato il coraggio di esprimerlo? Se sì, chi dei due avrebbe parlato per primo? Sono abbastanza sicuro che ce lo saremmo stretti in pancia fino ai crampi piuttosto che sibilare un pensiero.
Tuttavia, le supposizioni rimangono tali, perché proprio mentre ragionavamo se dire qualcosa, cosa dire e come dirlo, la voce automatica ha pronunciato «Avvio itinerario. 8 minuti.» Ci siamo ricordati di quanto non volessimo sentire quel numero; e pur non aprendo bocca sapevamo che avremmo voluto allungare il percorso; pur di scongiurare quel numero avremmo barattato qualsiasi cifra di tempo, anche al costo di perderci. Saremmo finiti in mare se necessario. Noi del nord che del mare sappiamo più o meno nulla.
Il Rumore
Il film è iniziato puntualissimo. Noi siamo entrati poco prima; la sala era tutta rossa e i due portelloni di sicurezza che davano sulla strada erano spalancati, il che avrebbe arrecato un leggero fastidio data l’intensità acustica di un cocktail bar e un minimarket con musica indiana dall’altra parte del marciapiede. Emergenza rientrata rapidamente grazie all’impeccabile intervento di un bigliettaio qualsiasi. Ci siamo seduti accanto ad altre persone. Alla nostra destra una coppia di giovani: lei, con una coppola rosacea e delle ciocche bionde che si snodavano intorno alle gote, stringeva con una mano un pacco di fazzoletti causandone il tipico scricchiolio di plastica, e con l’altra ondulava – utilizzando accuratamente il dorso – delle dolci carezze sul collo del fidanzato, che ripiegava le labbra in un sorriso compiaciuto, che era più o meno la definizione di tranquillità. La fila dopo era occupata da un gruppetto che tossicchiava per via di una popolarissima influenza stagionale; alcuni di loro testimoniavano d’esserne usciti illesi, ma ne portavano ancora un po’ le scorie. Il telo era insolitamente freddo e nero, personalmente non mi era mai capitato; per la prima volta era muto da qualunque pubblicità. Nessun manifesto locale, nessuna sagra di paese, non un singolo modello di automobile sostenibile con attori hollywoodiani al volante; solo il nostro riflesso: una dozzina di persone racimolate nel cuore della sala a chiacchierare d’insulsaggini nell’attesa che il film iniziasse.
Poi sono arrivate le 21:30.
È davvero faticoso rispondere a ciò che è avvenuto. Ogni ostinata stesura di riscrittura trascina inevitabilmente alla radice del problema. Quindi, nella più tacita e assoluta umiliazione deontologica – non può essere che così a questo punto -, scriverò cosa è successo mentre il proiettore s’illuminava e le luci si buttavano a terra, senza teatralità, senza manierismi. Io sentivo il silenzio più abissale della mia vita.
Sapevo – come tutti – perché mi trovavo lì, che cosa avrei visto, a che cosa avrei assistito; ero in qualche modo preparato. Ma la feroce rapidità con la quale ogni bocca si è serrata – un lasso di tempo assolutamente infinitesimale – ha di lunga misura elevato l’esperienza, alzato la posta in gioco. Le mani della ragazza avevano smesso di funzionare, le tossi si erano deglutite d’un tratto. Eravamo tutti completamente scomparsi.
Assurdo
Alcuni termini sono diventati inutilizzabili, svuotati della loro semantica a causa del massiccio e pedestre utilizzo dei social network. Alcune specifiche parole – da sempre considerate ragionevolmente quotidiane – hanno rinunciato al loro fascino e ne è stata abiurata la serietà. Un po’ come quella storia che a furia di ripetere meccanicamente qualcosa, essa diventa piatta. Ecco; in questi anni è toccato ad assurdo. Alla ricezione di un reel su Instagram, si risponde: assurdo, qualsiasi esso sia. È valido per qualsiasi contenuto. Reazione e stupore per un gatto minuscolo? C’è sdegno perché il mondo impazzisce? Una festa è degenerata in una guerriglia urbana? Assurdo. Pronunciarla attivamente ha ormai deflazionato l’affascinante rischio che si portava appresso; ora a dirla è di passaggio, incentiva una risata, attiva il cerchio del criceto.
Ed ecco che il cattivo presagio si rendeva manifesto vocale quando l’usciere, mentre apriva delicatamente i portelloni d’emergenza – con una manovra di polso fantastica e naturale – era riuscito a dire solamente «Assurdo, vero?»
Prima nota: Quel vero superfluo. Sempre nutrito la verace convinzione – vittima dell’idealismo che persevera in me – che le parole sono come proiettili; occorre assumersene la responsabilità. Non si accosta un’allusione così perentoria per poi richiedere una vergognosa conferma, non si spara per poi domandare timorosamente “Ho fatto bene a sparare?”
Comunque abbiamo sorriso sommariamente, quasi tutti nello stesso momento; anche chi aveva pianto si è concesso una pausa. Non ci rimaneva null’altro da fare; quanto avevamo visto era assurdo, l’usciere aveva ragione. Solo è stato un peccato non poterne accusarne il peso della parola in purezza, come anni fa.
La stessa Barca
Verso metà film ho intravisto qualcuno piangere, forse era la ragazza con la coppola rosa, non saprei. O forse sarà il caso di levare le maschere una volta per tutte: era sicuramente la ragazza con la coppola rosa. Lo scrivo perché non l’ho intravista, l’ho guardata. Ho da sempre questa pessima abitudine – vezzo dei bugiardi – di fingere l’allungamento del collo verso destra e sinistra per poter curiosare l’ambiente circostante sperando di non dar troppo nell’occhio, così l’ho fatto, e l’ho vista piangere. Era un pianto sobrio, scivolava – una sorta di sincerità fluida -; le sue gambe tremavano leggermente. Ho immaginato di accarezzarla, di tranquillizzarla dicendole che era solo un film, che gli sceneggiatori avevano fatto un buon lavoro, ma là dentro tutti sapevamo la verità.
L’ho lasciata nella sua sofferenza, che era un po’ anche la mia. Non mi sono più girato verso di lei.