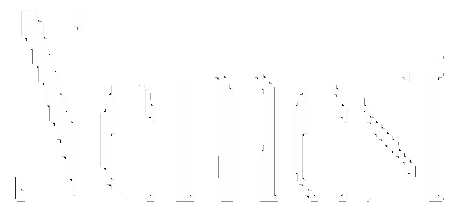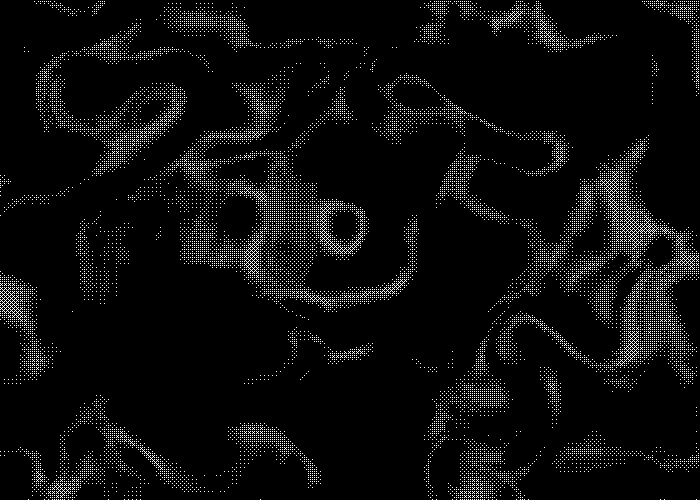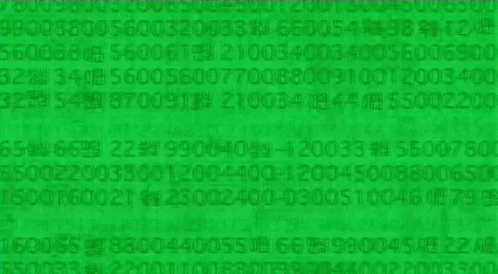Negli ultimi anni, e in particolare oggi, nel 2025, le piazze dei giovani sembrano vive, piene, animate. Manifestazioni per il clima, contro la guerra, contro le diseguaglianze sociali: temi seri, globali, universali. Eppure, osservandole con un minimo di distacco, si ha la sensazione che queste stesse piazze siano meno rivoluzionarie di quanto appaiano, meno autentiche di quanto si proclami. In altre parole, il problema non è che i giovani manifestino, ma come e perché lo facciano.
Un tempo, la manifestazione politica aveva un carattere drammatico. Chi scendeva in piazza sapeva di rischiare conseguenze personali: violenza, arresti, perdita di lavoro. La manifestazione era, in sostanza, un atto politico perché comportava un rischio reale. Oggi, invece, manifestare non comporta più alcun rischio concreto. È un’attività tollerata, quasi prevista, persino incoraggiata dal sistema. Ne consegue che la protesta ha perso il suo carattere originario di rottura e si è trasformata in un rito collettivo, ripetitivo e, in fondo, rassicurante.
Il paradosso è evidente: i giovani credono di ribellarsi, ma in realtà obbediscono. Obbediscono al nuovo imperativo del conformismo di massa: trasgredire. Un conformismo rovesciato, ma pur sempre conformismo. Lo dimostrano i modi stessi della protesta: slogan facili da ricordare, cartelli pensati per essere fotografati, cortei che diventano eventi condivisibili sui social. L’atto politico si riduce a immagine estetica. E un’immagine, per definizione, non cambia la realtà: la rappresenta e la consuma.
In questo senso, la protesta contemporanea è figlia diretta della società dei consumi. Come ogni altra merce, anche la ribellione viene prodotta, distribuita e consumata. Il capitalismo non reprime più le voci dissenzienti, come accadeva in passato: le ingloba, le neutralizza, le rivende. Una manifestazione diventa un hashtag, un evento mediatico, un prodotto culturale. E come ogni prodotto, anche questo ha un ciclo di vita breve: viene lanciato, consumato, dimenticato, sostituito da un altro.
Un esempio storico chiarisce la differenza. Nel Sessantotto o nel ’77, scendere in piazza significava porsi in opposizione frontale a un potere che reagiva con forza. La protesta era un atto di scontro e, in quanto tale, trasformava chi vi partecipava: l’esperienza era irreversibile. Oggi, al contrario, scendere in piazza è un’esperienza reversibile, leggera, persino piacevole. Non lascia cicatrici, non incide realmente sul percorso personale. Si manifesta il sabato, e la domenica si torna a casa a consumare come sempre.
È chiaro, dunque, che il problema non riguarda soltanto i giovani, ma il sistema in cui essi si muovono. Una società che trasforma tutto in spettacolo non può che trasformare in spettacolo anche la ribellione. I ragazzi partecipano, certo; ma spesso partecipano come si partecipa a un concerto o a un festival: per esserci, per sentirsi parte di un rito collettivo, per provare un’emozione condivisa. Il contenuto politico della manifestazione si riduce a contorno dell’esperienza emotiva.
Non bisogna però confondere questa critica con un disprezzo per i giovani. La loro energia, la loro indignazione, la loro voglia di dire no, sono autentiche. Ma ciò che manca è la traduzione di questa energia in azione politica concreta e rischiosa. Una manifestazione che non mette in gioco nulla di personale resta inevitabilmente inefficace. È un gesto che consola più che cambiare.
Il rischio, dunque, è duplice. Da un lato, i giovani si illudono di agire quando in realtà stanno soltanto partecipando a un rito innocuo. Dall’altro, il sistema trova in queste manifestazioni una valvola di sfogo: lascia che si gridi, purché quel grido non diventi azione. In questo modo, la protesta non solo non minaccia l’ordine esistente, ma finisce per rafforzarlo.
La domanda cruciale, allora, è semplice e insieme terribile: fino a che punto i giovani sono disposti ad andare? Finché la protesta resta una pratica comoda, un atto estetico, un’esperienza collettiva ma indolore, non produrrà alcun cambiamento reale. Solo quando si accetterà il rischio – rischio di perdere sicurezza, privilegi, tempo, lavoro – la protesta potrà tornare ad avere la forza che aveva in passato.
In definitiva, la ribellione di oggi non manca di passione, ma manca di serietà. Non manca di entusiasmo, ma manca di sacrificio. Non manca di numeri, ma manca di rischio. Finché queste mancanze persisteranno, la manifestazione sarà un conformismo travestito da ribellione: un rito collettivo che rassicura chi vi partecipa e chi lo osserva, senza intaccare davvero le strutture del potere.
La vera ribellione, in una società che trasforma tutto in merce e spettacolo, consisterebbe forse nel rifiutare di partecipare allo spettacolo stesso. Nel sottrarsi alla logica dell’immagine, nel rinunciare alla scena. Ma questo, evidentemente, è il passo più difficile. Perché richiede ciò che manca: il coraggio di perdere qualcosa.