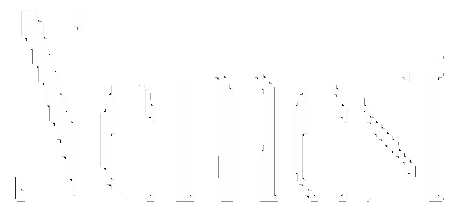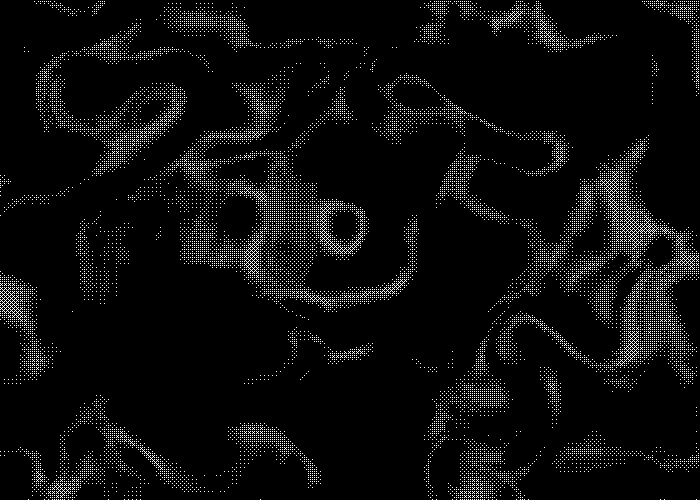Entrate in una qualsiasi libreria, superate la sezione sui romanzi cosiddetti rosa, circumnavigate i libri di cucina, lasciatevi meravigliare di trovare Erri de Luca proprio in quest’ultimo scaffale. I topoi urbanistici delle librerie sono parte di un gigantesco inconscio collettivo, si riproducono all’infinito mostrando spesso una disposizione simile.
Ovunque adesso sarete, è verosimile vi si ponga davanti un bivio. A destra lo stantio corridoio con saggistica-manuali di scienze politiche – trashate new age varie intervallati dai libri dei parlamentari/sindaci dalle copertine dal gusto minimal. A sinistra, accanto, o forse proprio davanti la sezione di psicologia. La sezione di psicologia vi attrae come un magnete, atavica risposta alla più umana delle questioni: cosa pensano gli altri? Come si muovono nelle loro storie? Esiste l’alterità o siamo tutti condannati a vivere con la sindrome del protagonista?
Tra gli scaffali in compensato cominciate così a leggere i nomi di autori e autrici che han fatto la storia della disciplina: Freud, Jung, Wilhelm, Williams, Miller, Lowen, Lacan, Recalcati che parla di Lacan, Fadini che parla di Recalcati che parla di Lacan. Ben piazzati al centro ci sono loro, gli onnipresenti terapeuti da salotto televisivo, Morelli e Crepet, vere e proprie catene di montaggio tayloriste di manuali per vivere felici, anzi felicissimi.
Ecco che però il vostro cervello limbico si attiva improvvisamente. In un attimo l’evoluzione vi porta a riconoscere un pattern, abilità sempre più necessaria e attuale nella società del semio-abuso. Tutti o quasi i nomi susseguenti all’interno degli scaffali possiedono qualcosa in comune. Ad un occhio superficiale si potrebbe notare un divario di genere apparentemente incolmabile: sono quasi tutti uomini.
La sensazione di essere arrivati lascia spazio ad un forte déjà-vu, come se questa spiegazione fosse in realtà sommaria, insufficiente. No, non può esser unicamente una questione di genere, dev’esserci qualcos’altro, un altro pattern, stavolta più sotteso, ermetico. I nomi scorrono un dopo l’altro. Freud, Jung, Reich, Lowen, Lacan. Sigmund, Carl Gustav, William, Alexander.
Le libere associazioni fluiscono oramai ineluttabili all’interno della neocorteccia. La parte più evoluta, più profondamente umana del cervello mette in ordine tutti i vostri ricordi mischiandoli e contaminandoli col senso comune delle cose. Notate una continuità storica, una linea del tempo viaggiante dalla nascita della psicoanalisi fino a giorni nostri. Il quadro si fa sempre più nitido, i nomi vengono scanditi ancora un’ultima volta prima di esclamare “eureka!”.
L’inconscio, la psicoanalisi, la libido, i sogni, le metafore si rifanno tutte ad un preciso frame teorico. Sono tutti terapeuti psicodinamici.
Vi chiedete ora com’è possibile, la vostra mente proverà a tornare congrua, ad integrare i nuovi dati nelle vostre conoscenze già consolidate. Non è possibile, probabilmente siete nevrotici o addirittura psicotici. Ve la raccontate, trovate le vie di fuga più consone e adeguate alla situazione. Del resto, negli scaffali in basso ci sono Paul Waklawick, proprio lui, scuola di Palo Alto, George Kelly, qualche manuale di self help dal titolo grottesco e un paio di autori della terapia strategica. Relegati negli inferi, troppo in basso per esser notati dallo sguardo baldanzoso dell’utente medio di una libreria, le quote paloaltiane riemergono talvolta dal sottosuolo con energia ctonia, come a volerci ricordare che ci sono anche loro.
Il fatto che siano lì sotto può benissimo essere un caso, forse dovuto alle iniziali. W, K, lettere così distanti dalla F, dalla J., dalla M. Un simpatico scherzo della storia, una differenza puramente relegata ai cognomi e a due idiomi lontani cugini. Ma a forza di inseguire coincidenze, casualità e strane geometrie alfabetiche, forse si rischia di scivolare nel primo dei sintomi: credere che tutto abbia, in fondo, un disegno.
Ulteriori razionalizzazioni non vi serviranno, i meccanismi di difesa crollano uno ad uno come un domino. Non potete più raccontarvela. Oramai tremanti notate il faccione stilizzato dell’ennesima ristampa economica dell’interpretazione dei sogni. Il viennese vi fissa coi suoi occhi severi e il suo sguardo cupo. Siete in trappola. Siete appena caduti nel rabbit hole della psicoanalisi freudiana.
Vero fantasma del nostro tempo, Freud ha creato la più grande fanfiction della storia. Un insieme di narrazioni bastanti a sé stesse, tautologiche quanto non passibili di falsificazione. Tramite una costruzione narrativa retroattiva (ovvero creata analizzando fatti di ieri con schemi interpretativi di oggi) Freud prende elementi sparsi della tua storia personale, ne enfatizza alcuni, ne omette altri e li riorganizza in una macro-narrazione coerente capace di spiegare tutto l’orizzonte del visibile. Presupposti discutibili, problemi personali dello stesso autore ed una concezione epistemologica del secolo scorso fanno da sfondo a una serie di congetture e castelli mentali con l’empio compito di decodificare gli abissi più reconditi dell’animo umano.
La chiara stele di rosetta della vita adulta è proprio l’infanzia. Su un letto di Procuste abbastanza angusto è possibile far rientrare in un copione predefinito qualsiasi tipo di comportamento. Non importa quanto i tuoi rapporti familiari siano stati, per te, vissuti nella maniera più allegra e propositiva possibile: nella migliore delle ipotesi hai sognato di scoparti tua madre o tuo padre, di uccidere l’altro caregiver e, nel caso tu fossi una femmina, guardarti il clitoride con gli occhi di un reduce della grande guerra al quale hanno amputato una gamba.
Decisamente lillipuziano per surrogare il fallo, perpetuo topos della psicoanalisi. Le nuove costole di Adamo, macchiate in eterno dal peccato originale e destinate perciò a sanguinare per tutta la vita, non potranno mai possedere un pene, perlomeno a livello fantasmatico. E non importa quanto portarsi dietro un inutile affare penzolante e molliccio non sia probabilmente la maggiore velleità di una persona socializzata donna. Quel bisogno, atavico fino alle viscere, è iscritto come un suggello nell’anima o, se preferite, nel DNA.
E poi c’è l’inconscio, eterno burattinaio della tua esistenza nonché emporio di stoccaggio delle tue pulsioni più recondite. Non ti riconosci nella coazione a ripetere? Non hai voglia di risalire la linea del tempo fino al momento del parto? Hai la convinzione terribilmente positivista che aver sognato una vacanza caraibica dopo aver litigato col padrone per le ferie di agosto non indichi in maniera chiara una segreta volontà di maternità? L’acqua? Il liquido amniotico? Il parto? Ritornare all’utero?
Continui a non riconoscerti in questo schema? È una resistenza. È palese. Chi ammetterebbe di sognare di fare sesso con la propria madre? È chiaro che il tuo inconscio ti sta proteggendo da un pensiero per te inaccettabile, perturbante, Das Unheimliche. Nega l’eterna cospirazione del tuo inconscio e finirai solo a confermarla. Se credi di non aver vissuto il complesso di Edipo è perché lo hai rimosso. Ancora, nessun trauma infantile evidente? Il trauma ha operato e continua a farlo sottotraccia, ad un livello di coscienza inaccessibile.
Nel panorama gotico e borghese del tardo Ottocento, la repressione sessuale e i cosiddetti “sintomi isterici” di giovani fanciulle immerse in librerie kitsch e sedie di velluto hanno contribuito a plasmare l’immaginario mondo “fantasmatico” fatto di mostri interiori, pulsioni sepolte e figure paterne spesso ipotrofiche, esperite in un lapsus o un atto mancato. I monumentali studi di Marie Bonaparte sul poeta gotico Edgard Allan Poe o gli stessi freudiani sulla presunta omosessualità di Leonardo da Vinci continuano, nonostante la loro natura fortemente speculativa, a plasmare il modus operandi dell’analisi freudiana.
E come ogni fanfiction anche i personaggi abitanti il mondo dell’inconscio sono stereotipici (o forse archetipici?). La madre castrante, il padre padrone, il bambino represso fanno capolino nelle narrazioni pronti a recitare battute scritte da qualcun altro, in un copione antico quanto chi lo ha applaudito per primo. Figure bidimensionali imprigionate nel loro teatro dell’assurdo dove ogni desiderio è un tabù e ogni sintomo un criptico messaggio da decifrare secondo il prontuario freudiano.
Definito dal turbinio di etichette, il paziente smette di essere un individuo con una sua storia biografica divenendo così un personaggio, un NPC inserito in un contesto generico e metaforico di cui solo i più zeloti adepti della IPA (International Psychoanalytical Association) possono carpirne i segreti. O perlomeno, quelli sopravvissuti alle grandi purghe dirette dallo stesso Freud. Ben pochi.
La presunta profondità psichica, l’onnipresente iceberg dell’inconscio fa capolino in tutti i manuali di psicologia insieme alla cosiddetta Seconda Topica, diviene così una questione in primis epistemologica.
Quando e come ci si rende conto che l’osservato non è il dato di realtà ma il prodotto della nostra visione, degli innesti culturali e delle categorie conoscitive che utilizziamo per inferire ciò che osserviamo? Quanta di quell’osservazione è dovuta ad un reale legame col fenomeno e quanto è invece frutto di un cocktail letale di aspettative e bias di conferma? La storia delle civiltà umane è prima di tutto la storia dei costrutti e delle sovrastrutture, codificate poi attraverso il linguaggio e le immagini, che hanno definito e che continuano a definire oggi la patologia mentale, la nevrosi da scacco o l’investimento libidico sui piedi. Freud, complice il suo stile di vita boemo, è morto troppo presto per poter conoscere Karl Popper.
Sarebbe stato bello porre una semplice questione allo psicoanalista viennese. Cosa avrebbe dovuto dire o fare “l’uomo dei topi”, celebre paziente di Freud, per convincerlo che i suoi disturbi ossessivi non fossero dovuti ad una forma di erotismo anale causata dal padre?
Nelle narrazioni autoesplicative il rischio di chiudersi in strutture a tenuta stagna è quello di piegare la realtà alla narrazione e non viceversa. Trovare escamotage retorici, speculazioni e una visione totalizzante fanno sì che, qualsiasi dato, torturato abbastanza, dirà quello che vogliamo sentirgli dire.
Alla fine, la psicoanalisi è forse la più riuscita delle fanfiction collettive del secolo scorso: un’epopea gotica fatta di madri spaventose, padri onnipotenti, desideri rimossi e traumi taciuti. Come in un romanzo, i suoi protagonisti sono prima di tutto icone che persone, simboli prima di individui. Più che l’inconscio, ciò che Freud ha davvero scoperto è la nostra fame inestinguibile di storie: storie che ci descrivono, che ci giustifichino, che ci illudano di mettere in ordine il caos del turbinio di emozioni, vissuti, chiavi di lettura, strumenti interpretativi, quasi esistesse davvero un cifrario universale della psiche umana.