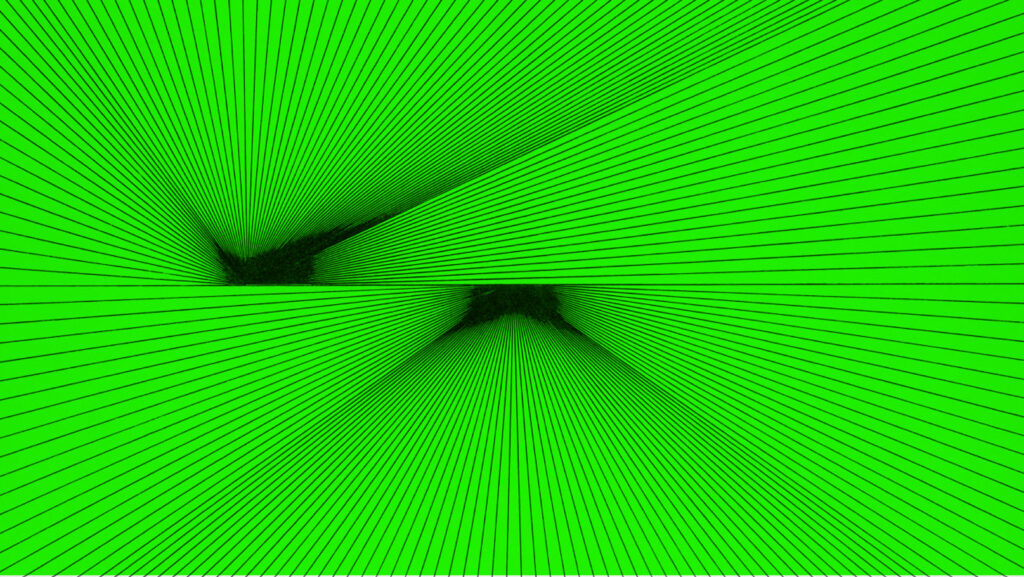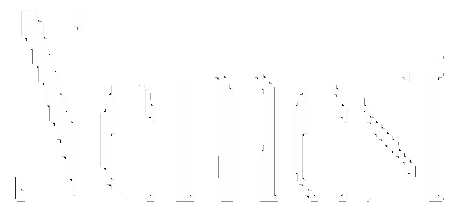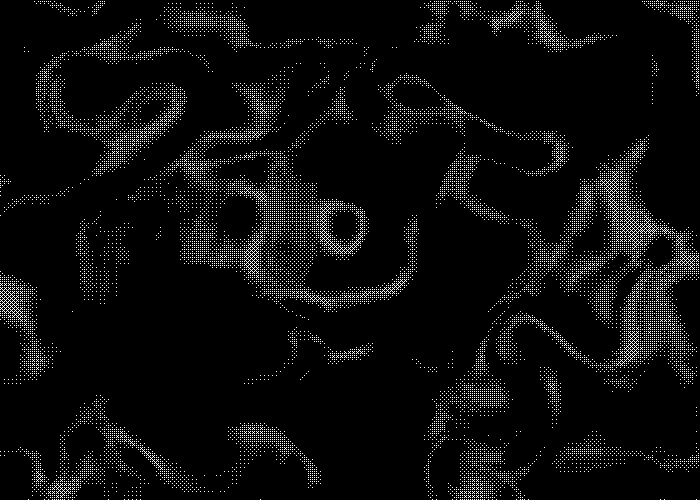Gian Maria Tosatti è una figura che sfugge alle categorie semplici dello stereotipo dell’artista naïf e maledetto, ed è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di intervistarlo. Nato a Roma nel 1980, ha attraversato la scena artistica italiana con la grazia spigolosa di chi non si limita a produrre opere, ma pretende di ridisegnare la cornice stessa in cui l’arte si muove. Artista, sì, ma anche scrittore, direttore d’istituzioni, voce pubblica, guastatore di conformismi e, volente o nolente, abile frequentatore delle zone grigie dove il sistema si mostra per quello che è: un intreccio di poetiche, politiche e capitali relazionali.
C’è chi lo ama per la radicalità quasi etica con cui chiama le cose col loro nome, chi lo odia accusandolo di egocentrismo messianico, fino al boicottaggio; chi ne riconosce la lucidità, chi ne teme l’ingombranza o lo accusa di inconsistenza poetica.
Nel 2022 ha rappresentato l’Italia alla Biennale di Venezia con Storia della notte e destino delle comete, un progetto monumentale sostenuto da Valentino e altri colossi privati — un dettaglio che, nel nostro Paese, costituisce colpa ed è spesso più discusso dei contenuti stessi delle opere, e che costituirebbe reato di corruzione ai principi artistici di non si sa bene cosa.
Tosatti dice di non avere “conflitti d’interesse”, ma la sua traiettoria — Biennale, Quadriennale, scrittura militante e consolidamento prestigioso — sembra smentire la rassicurante distinzione fra chi fa e chi organizza, fra chi crea e chi amministra.
Ed è forse proprio in questa ambiguità fertile che risiede la sua forza: Tosatti non si limita a navigare il mercato, lo attraversa con la consapevolezza di chi sa che ogni opera è anche un atto politico, ogni spazio espositivo una costruzione ideologica, ogni sponsor un gesto culturale che può subire una rivalutazione etica prima che economica.
In questo dialogo spietatamente serio, proviamo a smontare il dispositivo Tosatti con la delicatezza di un chirurgo e la curiosità di un bambino che infila le dita nella presa. Gli chiediamo dei confini poetici e dei codici mancanti, del mercato e dei suoi sponsor, della costruzione dei contesti e delle traiettorie relazionali.
In altre parole, gli chiediamo non solo cosa fa, ma come ci è arrivato, e come si fa.

Vincenzo Profeta: Parte della tua critica alla scena artistica italiana degli ultimi vent’anni è un atto d’accusa: gli artisti non hanno prodotto “massa critica”, “movimento” o “manifesto”. Quali condizioni strutturali, oltre agli artisti, ritieni siano responsabili di questo stallo?
Gian Maria Tosatti: La definizione “arte italiana” si applica a una dimensione geografica o culturale. Non ha connotazioni poetiche. È quella degli artisti italiani o quella che si fa in Italia, dove risiedono anche alcuni stranieri come Adrian Paci. Altri artisti, come Petrit Halilaj o Ian Tweedy, pur essendo stranieri, appartengono a questa galassia allargata.
Se c’è qualche peculiarità poetica o di contenuto rispetto ad altre scene, queste risiedono in una sensibilità culturale, radicata nella nostra storia e ancora percepibile nel presente
Gli italiani e i tedeschi, ad esempio, partecipano meno alle poetiche post-coloniali perché i nostri drammi storici recenti sono stati principalmente il fascismo e il nazismo, e ci hanno imposto prospettive diverse, complementari rispetto a quelle coloniali di inglesi, francesi, belga o americani.
In questo senso l’arte italiana si inserisce in un discorso globale, contribuendo con punti di vista specifici.
VP: Questa visione non rischia di svalutare forme d’arte locali o marginali?
GMT: No. Artisti che lavorano su temi qui marginali possono trovare risonanza altrove, dove ci sono artisti con le stesse urgenze e visioni.
In una mostra internazionale, riportare il luogo di nascita o di lavoro accanto al nome di un artista mostra come temi simili possano essere elaborati in contesti diversi, arricchendo l’analisi grazie alle differenti sensibilità culturali, di sesso, ideologia e patrimonio identitario.
VP: Non è una contraddizione elegante: da un lato denunci l’assenza di “massa critica”, dall’altro definisci “arte italiana” in maniera liquida e inclusiva.
GMT: Come dicevo, il fraintendimento di base sta nel fatto che “arte italiana” non può essere una definizione poetica, ma al massimo la definizione di una comunità.
E questa comunità la critico per non aver, in questi anni, promosso discussioni attraverso cui far emergere delle identità estetiche.
Due atteggiamenti poetici sono emersi, a dire il vero: un approccio novorealista sull’impronta filosofica di Maurizio Ferraris e la tematica del corpo.
Sono, tra l’altro, temi condivisi a livello globale, su cui gli italiani avrebbero potuto strutturare una prospettiva ulteriore e complementare. Ma non ci sono stati dibattiti reali, quindi quegli “atteggiamenti” estetici non si sono trasformati in vere e solide “poetiche”.
VP: Vuoi una nuova Transavanguardia o una nuova Wikipedia?
GMT: Non sono mai stato fan di un movimento come la Transavanguardia che fu pilotato da un critico. Ho avuto sempre più simpatia per le avanguardie storiche, che nascevano dal confronto tra artisti.
Ma non c’è neppure bisogno di arrivare a “serrare” così tanto i ranghi. Oggi basterebbe solo un po’ di passione: la volontà di incontrarsi, parlarsi.
Nella Vienna di fine impero asburgico, scrittori, artisti, matematici, filosofi si frequentavano in modo molto libero, ma molto profondo. Il loro costante confronto ha posto le basi per l’arte, il teatro, la danza e anche la fisica moderna.
Anche oggi si potrebbe partire dai vicini e poi allargare il discorso alle latitudini internazionali.
VP: Se i confini poetici contano poco, su cosa dovrebbe costruirsi la massa critica?
GMT: I confini poetici contano, ma vanno intesi in senso relativo. Per definirli bisogna parlarsi, riconoscere specificità e valore nella ricerca altrui.
La massa critica nasce dal confronto, non dall’individualismo. È da quei valori e da quelle specificità che si può prendere una distanza o definire la nostra posizione.
Chi non ha un’idea di ciò che gli sta intorno non può nemmeno avere un’idea chiara di dove collocare se stesso, e gli artisti che non trovano interesse nel lavoro degli altri dimostrano un comportamento miope.
E, oltretutto, è anche ingiustificato, perché nella scena italiana, ad esempio, ci sono molti percorsi di valore.
VP: Il sistema stabilisce canoni e meriti. Come concili il ruolo di artista, curatore ed abile promotore con la tua partecipazione al circuito?
GMT: Non sono un curatore, resto un artista. Partecipare a discussioni non mi trasforma in altro. Duchamp, quando si occupava delle mostre degli altri, non diventava mica un curatore.
Mentre la definizione di “abile promotore” è offensiva: non promuovo nulla, faccio il mio lavoro. Cerco di farlo bene, anche per gli altri. Altrimenti perderei il mio tempo.
Talvolta subisco forti opposizioni, come fu al mio arrivo in Quadriennale: cinquecento professionisti del nostro settore firmarono una petizione contro di me. Poi ho decuplicato le attività dell’istituzione già nel primo anno.
Molti “firmatari” ne furono coinvolti. Pochi, però, si sono preoccupati di rivedere la propria posizione con altrettanto pubblico zelo. Ma non fa niente.
I numeri parlano più eloquentemente delle opinioni. E i buoni risultati arrivano, perché conosco bene il sistema. Ci vivo dentro, non ho conflitti d’interesse.
VP: Faccio una premessa: rispondendoti pure io, mi spiace tu intenda offensiva la parola “promotore”, non era mia intenzione offenderti. Era inteso come il gesto di organizzare, chiamare a raccolta, costruire cornici e codici comuni raccogliendo anche contatti umani, come tu stesso sostieni.
Può anche essere un atto minore, collaterale, contaminante. La storia dell’arte è letteralmente fondata su figure che hanno saputo coniugare la pratica poetica con la capacità di farsi molto di più che promotori, ma veri PR: penso a Marinetti, a Giorgio Vasari che arriva al limite del gossip, ad André Breton con i manifesti surrealisti: hanno agito più da direttori editoriali e polemisti che da semplici artisti.
GMT: Ma sì, certo, la parola “promotore” — che comunque continua a suscitare in me una certa estraneità — può essere intesa in vari modi. E, se si vuol essere un po’ iperbolici, si può anche arrivare a definire Marinetti un “PR”.
Io, però, preferisco non farlo. Per Marinetti, la parola “artista” mi pare che funzioni più di “PR”. Per cui mi faccio andar bene quella.
VP: Tu affermi che per definire confini poetici bisogna “parlarsi” e uscire dall’individualismo contemporaneo. È una visione piuttosto assembleare, dove i codici estetici si costruiscono per convergenza dialogica. Ma davvero credi che basti “parlarsi” per far nascere un canone condiviso?
GMT: Per arrivare alla verticalità nelle discussioni e nelle intese bisogna prima di tutto muoversi orizzontalmente alla scoperta. Poi, raccolte abbastanza informazioni, si sceglie e si definiscono i percorsi in salita da fare coi veri “compagni di strada”, quelli con cui si affrontano le salite più dure e ambiziose.
Ma ora siamo indietro. Adesso manca ancora tutto il dialogo orizzontale. Gli artisti si evitano.
VP: Rivendichi di non avere conflitti d’interesse perché, pur avendo diretto istituzioni e firmato interventi critici, resti “un artista, non un promotore né un curatore”. Differenze, a mio avviso, che non sono mai esistite realmente.
Ma non è proprio questa tua dichiarata estraneità a fornirti una sorta di zona franca, da cui puoi criticare il sistema senza essere del tutto vincolato alle sue logiche di responsabilità?
GMT: Ogni atto umano è politico. Anche un’opera d’arte è sempre eminentemente politica se intende davvero relazionarsi alla realtà e non darsi come semplice automatismo di mercato.
Scrivere un editoriale su un quotidiano è politico, certo, perché prende una posizione. Ma anche parlare a tavola coi propri figli può essere politico.
Io sinceramente non credo di essere estraneo al sistema. Ne faccio parte, come faccio parte dello Stato Italiano, di cui sono cittadino e contribuente.
VP: Non è forse questa ambiguità la leva più potente (e rischiosa) del tuo discorso pubblico?
E perché poi farla? Non credi che il contesto sia fondamentale per un artista e coinvolga diversi ambiti della quotidianità?
E se sì, hai dei criteri su come creare un contesto, rispondente e sufficientemente sano, tra pubblico, mercato, artisti, società?
GMT: Io non trovo alcuna ambiguità. Ripeto, cerco solo di fare la mia parte. Se oltre a mettere in ordine il mio appartamento, ogni tanto innaffio anche le piante del palazzo, questo mi pare solo un modo civile di partecipare alla cosa pubblica.
Ripeto, se questo suona strano, credo che sia solo perché ormai siamo talmente tanto schiacciati su posizioni individuali da confondere un gesto di civiltà come innaffiare le piante del pianerottolo con qualcosa di rivoluzionario o sovversivo.
A me spiace se ci siamo ridotti così. Io appartengo all’Italia dei Pasolini, dei Testori, di gente che, pur avendo giocato su diversi tavoli, mi pare tutto tranne che ambigua.
VP: Sventiamo questa cosa della poetica inconsistente: qual è la tua ispirazione massima, i tuoi artisti di riferimento, e se per te le citazioni che fai all’interno dei tuoi progetti sono meri strumenti o appartengono al tuo reale subconscio immaginativo?
GMT: Ma questa è una cosa che non si può nemmeno prendere sul serio se si considera che tutti i miei progetti sono a lungo termine e hanno prodotto libri piuttosto corposi nel loro svolgersi.
Con Devozioni (2005–2011) ho dato inizio a una nuova linea nell’arte ambientale; con Sette Stagioni dello Spirito (2013–2016) ho costruito una circostanza in cui l’opera si sovrapponesse all’intera città di Napoli trasformandola in un dispositivo per un viaggio interiore.
Con Il mio cuore è vuoto come uno specchio ancora uso l’arte come strumento di confessione tra comunità che vivono in guerre o in dittature.
Io lavoro per fare in modo che l’arte trasformi la realtà. In modo molto concreto. Questa è la mia poetica.
Ma dirlo in tre parole è semplice. Il punto è che operazioni come quelle cui ho accennato, se non sono rette da poetiche solide, non riescono a tenere sviluppi tanto complessi. Né tantomeno finiscono per collaborare con te altri artisti di valore. Con gli artisti non puoi barare.
E devo dire che forse è per questo che quelli che un tempo vedevo come maestri sono, poi, diventati amici o, magari, hanno anche scritto cose fantastiche sul mio lavoro. Penso a Anselm Kiefer e a Gregor Schneider, in primo luogo. Col primo condivido proprio il forte legame con la letteratura.
Col secondo un percorso di ricerca nell’arte ambientale.