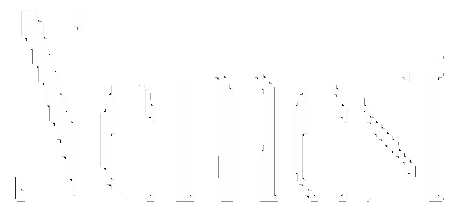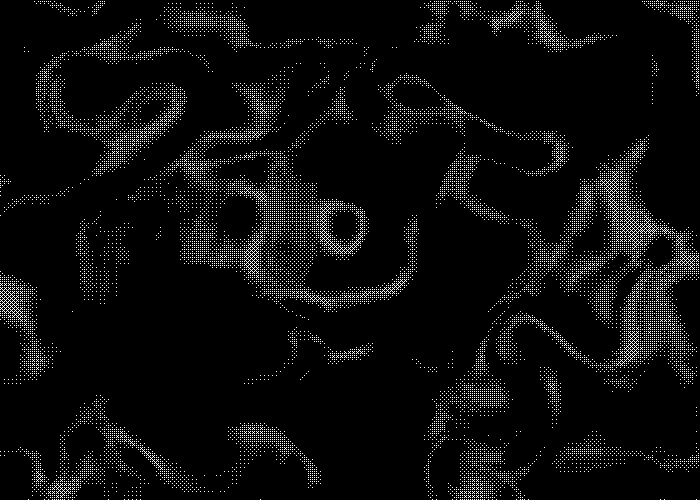1980. Shining di Stanley Kubrick arriva nelle sale. Il film ottiene un buon successo di pubblico, ma le critiche (che un tempo decretavano il destino di un’opera) risultano contrastanti. Lo stesso Stephen King, autore del romanzo da cui il film è tratto, lo definisce troppo “freddo”. Ci sono poche certezze al mondo, se non quella che Stanley Kubrick sia uno dei più grandi registi e autori che abbiano mai messo piede su questo pianeta. Il problema, però, è che Shining era un film horror. E l’horror, da sempre, è considerato un genere di serie B, qualcosa di poco serio, anche se oggi, paradossalmente, Shining è ritenuto uno dei capolavori assoluti del Maestro.
Poco importa se, volendo semplificare, l’intero genere affondi le proprie radici nella decadenza e nell’intimità di uno scrittore come Edgar Allan Poe (oggi celebrato, ieri ignorato). Poco importa che, al cinema, l’horror derivi da correnti “serie” come l’espressionismo tedesco, o che nei suoi archetipi (Frankenstein, Dracula, l’uomo lupo, gli zombie) fossero già presenti tematiche profonde come l’esistenzialismo, la dipendenza, la diversità e la sottomissione. L’horror ha sempre portato con sé lo stigma del genere “sporco” e minore, perché il suo successo è nato nei drive-in, con un pubblico di ragazzacci considerati violenti, rozzi e nemici di Dio e della morale. Eppure, proprio questa percezione di qualcosa di “proibito” ha alimentato il suo successo commerciale, alternando una produzione infinita di film sempre più inutili, brutti e spesso reazionari, a veri e propri capolavori come, tra i tanti, Rosemary’s Baby, L’Esorcista, Zombi, Nightmare, Videodrome, Suspiria o naturalmente Shining: opere che hanno elevato il genere, mettendolo al servizio di temi profondi e universali.

Il vero problema del genere horror al cinema è sempre stato quello di “viaggiare” su due binari: uno prettamente di exploitation (ossia di sfruttamento commerciale) e l’altro più “autoriale”, che utilizza il genere come metafora per affrontare tematiche “serie”. Dall’inizio degli anni 2000, con il successo di saghe come Saw, Insidious, The Conjuring e di tutti i titoli legati a esorcismi e presunte “storie vere”, l’horror di tipo exploitation si è ulteriormente cristallizzato, diventando un genere prevedibile, dominato da jump scare puerili e trame scontate. Tutti quegli elementi che un tempo erano “liberatori” e “politici” si sono trasformati in qualcosa di punitivo e di matrice cristiana. Questa deriva ha finito per cristallizzare anche gli spettatori stessi che, come tossicodipendenti in cerca della loro dose di paura sicura, si sono ritrovati rassicurati nel vedere sempre lo stesso film. È da questa necessità di scardinare tale cristallizzazione del genere che nasce il cosiddetto “elevated horror”. “La paura è il più antico sentimento dell’uomo e anche il più liberatorio”, diceva Lucio Fulci. Ma serve a liberarci da cosa? Forse dalla stessa idea che ciò che vediamo sullo schermo possa accadere davvero a noi. Per questo, per troppo tempo, ci si è ancorati alle buone vecchie paure delle possessioni e dei mostri conosciuti, invece di esplorare quelle nuove, più profonde e radicate nei turbamenti della società contemporanea.
In questo, l’elevated horror ha fatto la differenza: una naturale evoluzione del genere che prende come punto di partenza situazioni drammatiche o esistenziali, legate alle preoccupazioni dello spettatore del 2025. Così, il genere horror è stato finalmente rivalutato anche dalla critica istituzionale che, trovandosi spesso di fronte a imbarazzanti film d’autore contemporanei, ha trovato nell’elevated horror pane per i suoi denti: una messa in scena curata, ruoli e dialoghi che rendono gli attori parte essenziale dell’opera, una fotografia elegante al servizio dell’atmosfera, una musica capace di accompagnare o contrastare l’immagine, e un montaggio che lega le sequenze dando loro significato, non come semplice scansione ritmica del tempo filmico. L’elevated horror ha anche riportato la lentezza nel cinema del terrore, quella stessa lentezza che caratterizzava il cinema degli anni ’70 e che, negli anni ’90, era stata travolta dalla tecnica del videoclip, rendendo il genere più allineato ai ritmi frenetici e bulimici della vita contemporanea. Ha inoltre unito questa lentezza a immagini oniriche, debitrici del cinema sperimentale e hippie, quasi a voler ricollegare il film alla dimensione della psichedelia. Eggers, nel suo The Lighthouse, e Aster nel personalissimo Beau ha paura, mettono in scena i tormenti di un “Edgar Allan Poe qualunque”. Entrambi i film hanno il privilegio di potersi ancora permettere margini interpretativi, perché film horror e quindi legati alla connotazione fantastica del genere, che nell’attuale epoca di cinema d’intrattenimento puro (caratterizzato da incastri narrativi meticolosamente calcolati) non sono più concessi.
Se per ottenere ottimi film come quelli che si stanno producendo oggi è necessario dire che il cinema horror sia diverso dal “vecchio” cinema horror del passato, ben venga l’etichetta elevated horror, anche se è palesemente una forzatura nel definire i prodotti di qualità di un genere che spesso ha prodotto film di qualità. Sarebbe forse più opportuno concentrarsi sulla caratteristica più importante che questi film hanno portato: in un’epoca di “grande fratello” globalizzato, il cinema horror exploitation (ma in verità un po’ tutto il cinema in generale) è schiavo del “tratto da una storia vera”, riproponendo le solite, ridicole storie di esorcismi, possessioni e serial killer che sconfinano in qualcosa di lontano dalla realtà. L’elevated horror, invece, pur non dichiarandosi “tratto da una storia vera”, affonda a piene mani nella realtà, fino a sfiorare una sorta di nuovo neorealismo (come ha già osservato il critico Flavio De Bernardinis).
Si potrebbe considerare It Follows di Mitchell (2014) come il capostipite del genere, ma si tratta solo di un punto di riferimento cronologico, perché, come già detto, l’horror ha sempre avuto autori come Cronenberg, Romero o Carpenter, che hanno realizzato film d’autore travestiti da film horror. Va però ricordato che, all’inizio degli anni 2000, alcuni registi già affermati si sono cimentati con l’horror in modo personale, come l’Aronofsky de Il cigno nero o il Von Trier di Antichrist. È forse stata quella la scintilla che ha portato la critica istituzionale a riconsiderare le potenzialità del genere, poi pienamente espresse in pellicole come The Witch di Eggers o Hereditary di Aster, che ne hanno sancito la definitiva consacrazione.
Da quel momento, l’elevated horror è diventato un binario autonomo rispetto alle produzioni horror prettamente exploitation. Sono usciti molti film notevoli: tra i più importanti, Talk to Me dei fratelli Philippou (autori anche dello splendido Bring Her Back) e Longlegs di Oz Perkins, che già nel 2016 aveva intuito il potenziale di una prospettiva autoriale nell’horror con il lentissimo e affascinante Sono la bella creatura che vive in questa casa. È riduttivo definire Jordan Peele lo “Spike Lee dell’horror”, ma le sue trame utilizzano la discriminazione razziale come punto di partenza per orrori meno “afro” e più “americani” che mai, come nel seminale Get Out. E mentre Eggers, con Nosferatu, trasforma Dracula in una figura brutta, vecchia e oscura come un uomo nero, Ti West si diverte a mischiare, contraddire e reinventare tutti i cliché del genere, discostandosi (secondo molti) dall’elevated horror, ma risultando in realtà ancora più autoriale nel giocare con la macchina “cinema horror”, come fece prima di lui Wes Craven con Scream.
Il picco evolutivo dell’attuale elevated horror è forse Strange Darling di Mollner: un film “forse tratto da una storia vera”, “forse in sei capitoli”, “forse d’amore”, “forse sessista”, “forse su un serial killer”, “forse sulla libertà individuale”. Insomma, un film horror estremamente godibile e sostanzialmente indefinibile come nessun altro prima di lui, e come, in verità, dovrebbe essere ogni singolo film prodotto oggi, anche a discapito dell’intrattenimento.