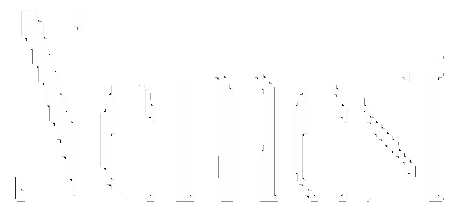È il primo novembre e piove, mi sono trasferito a Genova da due settimane e decido di passare il sabato sera in un locale fuori dal centro per vedere i P38 in concerto. Sul bus mi rendo conto di essere circondato da un gruppetto di miei coetanei che vanno nello stesso posto, mi immergo nelle loro conversazioni come se ne facessi parte e l’ansia di sembrare un maniaco solitario si dissolve gradualmente. Quando scendo dal bus riprende a piovere forte, c’è molta gente fuori al locale, si entra a gruppetti. Dopo una ventina di minuti è il mio turno. Prendo una birra media e siedo su un tavolino vista palco per godermi l’opening act. Sul palco campeggiano tre bandiere della Palestina attaccate con lo scotch, davanti alla console invece la parodia della bandiera rossa che è costata al gruppo un’indagine dalla procura di Torino per istigazione a delinquere e apologia di reato con l’aggravante di terrorismo: c’è scritto “Bravi Ragazzi”, accompagnato dalla discussa stella a cinque punte.
Sono al Crazy Bull, a Sampierdarena, quartiere popolare di Genova Ovest divenuto la casa di migliaia di migranti latino-americani e culla della nuova generazione di rapper di Zena: HelmiSa7bi, Jerry Sampi e il più noto Sayf. Il locale si riempie mentre i suoni hyperpop di Ganri si diffondono nell’aria. Il pubblico non è ancora caldo a sufficienza. Tra l’opening e l’inizio del concerto c’è spazio allora per qualche pezzo: Quello che non ho di Fabrizio De André fa centro, sembra il preludio perfetto all’ingresso del gruppo. Mi alzo e vado al centro della sala. Invece parte Dolcevita di Ketama 126: il pubblico incassa la delusione. A metà pezzo qualcuno intona il coro “tout le monde déteste la police”, noncurante delle ben diverse frequenze del brano: col passare dei secondi sempre più persone cantano, e più sale la voce più sale l’adrenalina.
Il dj spegne la musica, è il momento, dalla casse esce la voce registrata di Penthothal che legge il SECONDO COMUNICATO: «Milleduecentocinque giorni, mh, ne è passato di tempo, eh? È bastato dire “lotta armata” per diventare terrorismo». Se il PRIMO COMUNICATO, che apriva Nuove Br, colpiva per la spregiudicatezza –«la lotta armata è appena tornata di moda, adesso sono cazzi vostri», ma anche «non siete rapper, siete degli imprenditori del cazzo» – il secondo riesce ad essere ancor più tagliente: «e se è vero che il potere scaturisce dalla canna del fucile, a volte la fama scaturisce dalla procura di Torino. Certo, forse a questo punto tanto valeva sparare davvero».
Il pubblico si eccita e i tre sbucano dall’alto – il locale è sprovvisto di backstage – seguiti dal nuovo producer, subentrato quando Papa Dimitri ha deciso di lasciare il progetto per le vicende legali. Guardandoli scendere le scale che li portano sul palco, Yung Stalin, Astore e Jimmy Penthothal sono molto diversi da come me li ero immaginati ascoltandoli in cuffia. Avendo il viso coperto da un passamontagna bianco, finisco per soffermarmi sui loro corpi: nessuno dei tre è particolarmente in forma, ma è la sagoma sovrappeso di Jimmy Penthothal ad attrarre di più la mia attenzione. Inevitabilmente, quando ascolto i dischi delle band con più voci finisco per stabilire una mia personale gerarchia: Astore è il più bravo a rappare, e il live conferma questa impressione; Stalin il più iconico – dal nome alla rima sullo stato di Israele – ma è Penthothal il mio preferito, ed è per questo che scoprirlo grasso e poco adatto alla performance mi colpisce ancor di più.
Il pezzo che apre il concerto è il primo della band, del 2020: la maggior parte delle persone, me 2 compreso, non la cantano perché non la conoscono; subito dopo però arrivano i brani dall’ultimo album DITTATURA e dal precedente NUOVE BR, questi sì, cantati da quasi tutti i presenti. C’è comunque spazio per alcuni brani introvabili su Spotify e altri tratti dal disco di Astore, il più prolifico dei tre nonché quello specializzato nel tema del rapporto con le donne: «io non ho problemi con le donne perché il cazzo l’ho tagliato, stiamo pensando al cash cago sopra al patriarcato». In realtà, la narrazione del sesso che emerge da pezzi come COME ME COME TE o M(E)R(D)A è ben diversa da quella tipica del rap nostrano: «vengo a trovarti alle quattro di notte, devo vendicare Tiziana Cantone». Durante il concerto tre ragazze – inizialmente anche loro con un passamontagna – regalano acqua, birra e tequila al pubblico, «per sdebitarci del prezzo del biglietto» dice Penthothal, e non è una recita pensata per le prime file, l’alcool arriva anche dietro. Per il resto del tempo le tre sono sedute sulla scala alla mia destra e cantano i pezzi come fan accanite: sono pagate per recitare o sinceramente appassionate al gruppo?
Intorno a me ci sono persone molto diverse tra loro: oltre a molti miei coetanei, varie coppiette che slinguazzano sulle note di GHIACCIO SIBERIA – «trapper brigatista, bombe a Confindustria» – e diversi ragazzini, anche molto piccoli, che conoscono tutti i testi a memoria e li cantano con visibile emozione. Il pubblico adesso è veramente caldo, come il locale: molti seguono l’esempio di Yung Stalin e levano la maglietta. Quando è il momento di CIRCOTRIBUNALE, Penthothal non nasconde una certa insofferenza nell’indossare la toga da magistrato ma poi si diverte a ballare a braccetto con Astore vestito da clown.
Quelli come me, i 25-30enni, rinunciano al pogo violento che si scatena a partire dal terzo pezzo più o meno ininterrottamente nonostante le intimidazioni della Security, ma non disdegnano di alzare la mano facendo il segno della pistola come richiesto da Jimmy Penthothal. Il pogo, la pistola, gli insulti: più va avanti il concerto più diventa una seduta di catarsi collettiva. Gli insulti partono ripetutamente e contro bersagli diversi: Israele innanzitutto, Papa Dimitri, Vittorio Feltri, Lucio Corsi, Silvio Berlusconi, Giulio Andreotti, tutti i rapper italiani e alla fine nuovamente Israele. In alcuni momenti la catarsi la osservo, più che parteciparvi, turbato dall’impianto spacca timpani e dal sudore altrui che mi sfiora pericolosamente, in altri mi ritrovo ad alzare la mia P38 furiosamente al grido di Penthothal «viva la lotta armata».
Sulla P38 si sono spese tantissime parole: chi li ha etichettati come pericolosi, chi li ha sbeffeggiati per il loro anacronismo e chi li ha esaltati per la loro abilità nel mischiare il linguaggio della trap con quello del brigatismo anni ’70. Dopo cinque anni dall’inizio della loro carriera, tre dall’inizio del procedimento giudiziario che li ha resi famosi, fare un bilancio della loro traiettoria artistica è inutile, oltre che molto scivoloso. Per questo motivo, quando finisce il concerto e qualcuno avanti e dietro di me comincia a fare qualche considerazione sulla gravità di alcune loro affermazioni o su quanto i tre siano dei geni, recupero velocemente la giacca da un divanetto e scappo via.
Sul notturno per tornare ho intorno a me lo stesso gruppo dell’andata. La mia voce, bassa ma non impercettibile, si mischia a quella di una di loro cantando il ritornello di PARTITO DEL LAVORO con cui hanno chiuso il concerto: «le piace Stalin, ma quando è fatta dice che son l’anarchia, casa vacanze chiusi al centro di Pyongyang, con i miei fra siamo il partito del lavoro, ho una maglietta con la 3 faccia di Ho Chi Minh». Ci sorridiamo complici.