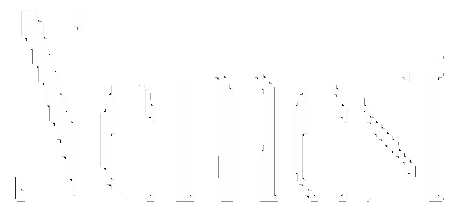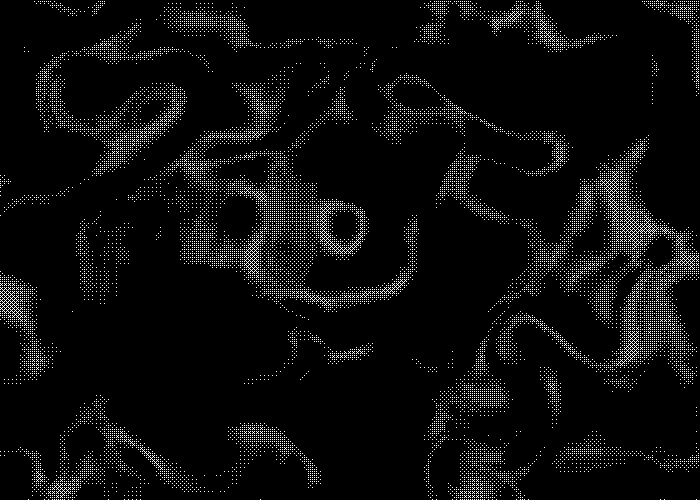Perché la fantascienza? Perché scegliere questo genere letterario, troppo spesso derubricato a frivolo intrattenimento, per veicolare una visione esistenziale dei destini umani? Beh, presto detto: appunto in quanto sottovalutata dall’accademia, è possibile esprimervi idee che difficilmente passerebbero al vaglio della critica mainstream. È possibile uscire indisturbati, a fari spenti, dagli schemi, con l’alibi della digressione fantascientifica. Certo, però esistono due modi di scrivere fantascienza. Da un lato c’è chi la adopera quale mero setting scenografico, uno sfondo suggestivo per porre in atto intrecci di trama che hanno vita indipendente rispetto alle implicazioni proprie dell’elemento fantascientifico. Dall’altro lato c’è poi la Fantascienza vera e propria, quella con la F maiuscola, che utilizza la costruzione, più o meno articolata, di un mondo alternativo, o la ricostruzione di alcuni suoi elementi, per dire qualcosa in più sul nostro. A questa seconda categoria appartiene senz’ombra di dubbio il capolavoro radiofonico e poi letterario di Douglas Adams (1952-2001): la pentalogia “Guida galattica per autostoppisti” (1979-1992).
Un passo tratto dalla “Guida galattica per autostoppisti” (non il romanzo di Adams ma il libro fittizio al suo interno, definito “un volume indispensabile a tutti coloro che sono ansiosi di capire la vita in questo Universo infinitamente complesso e caotico”) in particolare è esemplificativo della profondità di pensiero espressa da Adams dietro la maschera di delirante comicità, o forse proprio in virtù di essa. Un passo relegato ai margini del racconto (nell’ultima pagina del primo romanzo del ciclo), ma concettualmente pregno:
La storia di tutte le più grandi civiltà galattiche tende ad attraversare tre fasi distinte e ben riconoscibili, ovvero le fasi della Sopravvivenza, della Riflessione e della Decadenza, altrimenti dette fasi del Come, del Perché e del Dove.
La prima fase, per esempio, è caratterizzata dalla domanda “Come facciamo a procurarci da mangiare?”, la seconda dalla domanda “Perché mangiamo?” e la terza dalla domanda “In quale ristorante pranziamo oggi?”.
Tale passaggio non può che richiamare alla mente un’altra opera mastodontica, seppur di distante natura: il celeberrimo “Tramonto dell’Occidente” (1918-1923) scritto da Oswald Spengler (1880-1936) sull’onda del trauma collettivo europeo rappresentato dalla Grande Guerra, evento dal quale Spengler ricavò una profonda critica all’epoca moderna.
L’assunto concettuale di partenza del filosofo tedesco fu che la Nazione sarebbe stata da considerare al pari di un organismo vitale con tutte le conseguenze del caso e perciò che, come ogni altro ente biologico, avesse un proprio ciclo vitale e inevitabilmente sarebbe andata incontro ad un destino di declino e morte.
Le due parole cardine della weltanschauung spengleriana furono: Kultur, il soggetto, l’organismo vivente in forma di civiltà/nazione, e la Zivilisation, tradotto (male) con “incivilimento”, fase germogliante all’interno delle Kulturen, alle quali sarebbe finita per contrapporsi, inibendone lo slancio vitale. Per Spengler alla Zivilisation sarebbe corrisposto il progresso tecnico, inteso come limite alla capacità creativa esprimibile dalla Kultur, come fase di avvento del razionalismo utilitaristico, catapultante la Kultur nello stadio estremo, crepuscolare (nel tramonto appunto), del suo sviluppo. L’insorgere della Zivilisation avrebbe infatti innescato un momento conflittuale di forte opposizione allo spirito della Kultur, portando direttamente alla sua morte, alla quale avrebbe fatto seguito il ritorno ad uno stadio di natura, da cui una differente Kultur sarebbe poi sorta, come avvenuto (sette volte secondo Spengler) in passato.
Spengler collocò in tale momento di ineluttabile declino la civiltà europea interbellica, l’ultima espressione dell’ottava Kultur, quella appunto Occidentale, dominata dallo spirito faustiano. Segnale di tale destino di decadenza sarebbe stato il nietzschiano rovesciamento valoriale, con il venir meno delle tradizionali strutture gerarchiche in nome dell’avvento dei vari egualitarismi, razionalismi, individualismi, liberalismi, parlamentarismi e financo socialismi, tutti tasselli del (non così) lento sgretolamento delle identità nazionali [“Prussianesimo e socialismo” (1919)].
Spengler pose dunque in atto una diagnosi impietosa delle condizioni in cui, a suo avviso, versava la civiltà occidentale, divenendo un punto di riferimento imprescindibile per i pensatori afferenti al vasto ambito della “rivoluzione conservatrice”, ma non solo, restando, ad oltre 40 anni di distanza dalla sua morte, oltre il secondo conflitto mondiale, che mai vide, un riferimento fondamentale per chiunque volesse misurarsi con una critica dall’interno al modello occidentale, a partire dal secondo dopoguerra ormai pressoché completamente sovrappostosi all’american way of life.
Eccoci dunque ritrovare tutti questi elementi, dalla civiltà come organismo vivente, alla prospettiva ciclica, passando per le fasi di Decadenza, in un autore pur distante nel tempo e nello spazio (geografico e letterario), come Douglas Adams.
È facile immaginare come Spengler, se ancora fosse stato in vita negli anni ’50, avrebbe inserito nella nutrita lista di perversioni valoriali, sopra accennate, in qualità di estremo canto del cigno di una civiltà moribonda, ormai da un secolo abbondante, l’avvento del modello capitalista-consumista. Spengler non ebbe la possibilità di assistere all’inverarsi degli aspetti più deteriori di tale modello, ma Adams sì e non si sottrae al confronto aperto con essi, come nel passo che abbiamo visto. Certo, lo fa con il taglio che gli è proprio, quello satirico, paradossale e irriverente, agli antipodi del catastrofismo fatalista di Spengler, con una completa assenza di sistematicità all’opposto del determinismo storico spengleriano (fallace, altrimenti non saremmo ancora qui a discutere di decadenza), ma comunque con la volontà di porre in evidenza le storture prodotte dal consumismo, sintomo di una civiltà ormai esausta.
L’implicazione del passo tratto dalla “Guida galattica per autostoppisti” è chiara, siamo noi (occidentali di oggi, anzi ormai di ieri visto che Adams si riferiva agli anni ’70) a vivere nella società del Dove, della decadenza, del superfluo. Siamo noi a vivere nella società del consumo e dell’eterna distrazione. Siamo noi, dopo aver visto assicurati tutti i bisogni biologici, ad essere convinti di esserci ormai posti tutte le domande sull’esistenza (o addirittura talvolta di avervi trovato le risposte!). Siamo noi ad esserci convinti che altro non ci resta che consumare, consumare e ancora consumare all’infinito, al punto di diventare noi stessi dei prodotti, dei dati, delle statistiche.
Siamo noi ad avere l’illusione di essere consumatori.
Siamo noi i consumati.
Siamo noi l’ultima espressione della Zivilisation.
Requiem per la Kultur.