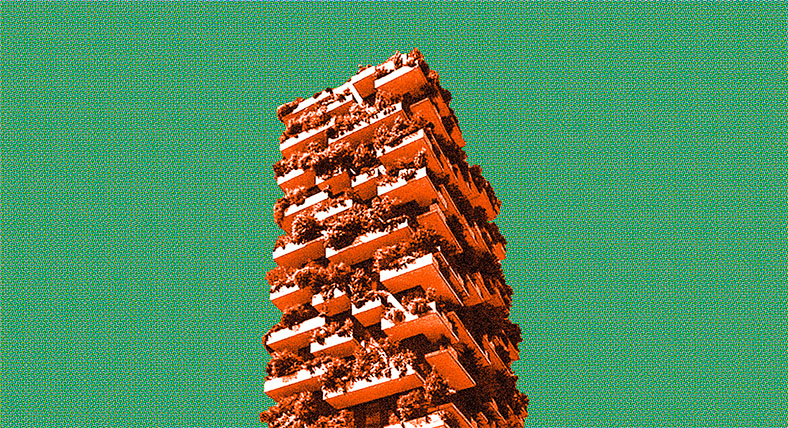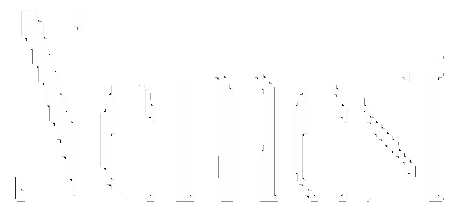David Adjaje è il genere di elegante archistar calzato morbido in giacche a kimono e colletti alla coreana, quella roba lì. La regina Elisabetta l’ha promosso baronetto e allora bisogna chiamarlo “sir”. Sir David Adjaye ha più stelle al petto di un ammiraglio in divisa. Barack Obama lo definisce “genio, puro e semplice”. Sir David Adjaye è un africano naturalizzato inglese, il più importante architetto nero della storia.
Il lavoro di sir David tende artisticamente all’etno-chic: piramidi spianate, trapezi rovesciati e tutto un vago ristagnare qua e là di ziqqurat e faraoni; ogni tanto una capannuccia di legno, per ricordarsi delle origini.
Se fosse possibile, a sir David piacerebbe girare la città su una biga, coi mozzi delle ruote istoriati di bronzo.
Nel corso della sua spettacolare ascesa alla fascia alta della bohème radicale, sir David si è dedicato con sentimentale fervore all’elegia della negritudine.
Il senso del suo lavoro si gioca intorno al tema del riscatto della razza.
A lui dobbiamo il tempio del Blaksonian, il Museo Nazionale di Storia e Cultura Afroamericane di Washington, un progetto da mezzo miliardo di dollari.
Nel 2023, un’inchiesta del Financial Times documenta una lunga serie di abusi e aggressioni sessuali che David Adjaye avrebbe commesso ai danni di dipendenti, collaboratrici o persone a lui collegate da rapporti di sudditanza psicologica, sottomissione gerarchica e dipendenza economica.
Per le testimoni sentite dal Financial Times, David Adjaye è un predatore sessuale, maschio nero etero cis, che sfrutta la propria posizione sociale, economica e politica per sottomettere sessualmente le sue vittime.
In un attimo, sir David Adjaye diventa il più grosso merdone mai pestato dall’internazionale progressista. Per questo manca ai posteri una critica di Natalia Aspesi alle sue irresistibili erezioni. Nessuno avrebbe mai sospettato che un architetto nero, avanguardia della lotta razziale, poteva essere un pluricinquantenne rattuso che deve scoparsi le stagiste sotto minaccia di licenziamento. L’inchiesta del FT riferisce una serie di strategie coercitive basate sull’offesa personale, sulla denigrazione e sull’insulto, tanto comuni quanto ancora più odiose se pensate in mano a un forte cavaliere delle battaglie per l’uguaglianza e i diritti dei deboli.
Nel classico copione #metoo, i ricchi avvocati del ricco Adjaye negano e contestano. I rapporti sono consenzienti, le conversazioni amichevoli, i licenziamenti motivati da processi di ristrutturazione aziendale e mai punitivi o, peggio, vendicativi.
La difesa di Adjaye è realismo capitalista in versione chatbot: non ci sono alternative.
Allo stato attuale, la vicenda pare debba risolversi con tanta segatura, nasi tappati, bocche cucite; sicuramente un mucchio di dollaroni persi dallo studio Adjaye in contratti non ratificati. A conferma della nobile tradizione garantista del paese, la pagina italiana di Wikipedia omette qualsiasi tipo di riferimento alle accuse di molestie mosse a sir David.
In Italia, Stefano Boeri è il genere di elegante archistar calzato morbido in camicia nera, giacca, trench e occhiali ton sur ton.
Stefano Boeri è acclamato dalla critica come l’artefice della definitiva trasformazione di Milano in metropoli globale. In altri termini, Boeri è il primatista italiano della gentrificazione urbana. Il suo lavoro tende artisticamente al minimalismo eco-chic: scatoloni di vetro e acciaio che sostituiscono la linearità geometrica, tipica dell’architettura modernista di Le Corbusier e Walter Gropius, con screzi ottici un po’ fru fru.
Nel caso di Boeri, resta agli atti il maquillage delle piantine da balcone nei render digitali dei suoi grattacieli a Porta Nuova.
Attualmente, Stefano Boeri, insieme a Cino Zucchi, altro peso massimo del cemento milanese, è al centro dell’inchiesta sulla gara d’appalto per la progettazione della BEIC, Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.
Boeri e Zucchi sono indagati per reati come turbativa d’asta e false attestazioni; per intendersi, il pane del capitalismo rampante dell’Italia stracciona.
Boeri sarà inoltre processato a settembre per altre imputazioni abbastanza gravi, lottizzazione abusiva e abuso edilizio nella realizzazione del progetto Bosconavigli – caserme di lusso e geometrica linearità screziata dalle solite piantine da balcone –nel triangolo del photo-shooting milanese: Tortona, Savona, Porta Genova.
Al di là di eventuali reati da assessore all’urbanistica nella provincia di Caserta, chiunque abbia avuto sentore dell’aria milanese nel secondo decennio dei duemila, sa che Stefano Boeri rappresenta il vertice di un’organizzazione intellettuale che prende il nome di “clan del postmoderno”.
Il clan del postmoderno tiene insieme squadracce di picchiatori bohème, folgorati sulla via del saggio più sopravvalutato nella storia di tutti i saggi, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, del benamato Benjamin.
Si intenda il tipo di personaggi obbligati a citare Otto Dix e i Dodo in una conversazione, solo perché si trovano sulla stessa pagina dell’enciclopedia.
Il clan del postmoderno legge la sua opportunità di esistenza nella diagnosi di una società di simulacri che trasforma il reale in tante deflagrazioni di pseudo-eventi.
Questi pseudo-eventi sono nient’altro che comunicazioni pubblicitarie, dove la produzione estetica si integra per esteso nella produzione di merce.
Come ha già capito la pubblicità cinquant’anni prima, la cultura postmoderna è un paradiso di pataccari che spaccia superfici e nasconde i contenuti.
Per questo Mark Fisher ha preferito cambiare nome al postmoderno e identificarlo come realismo capitalista. Il realismo capitalista è la teoria estetica del capitalismo, cioè l’esplosione dei principi del capitalismo nella sfera autonoma della cultura, e quindi nell’intero ambito della vita sociale, dal valore economico al potere statale, fino alle pratiche del pensiero e del comportamento.
Lo dimostrano le aggressioni di Adjaye e la manina di Boeri.
Come ha scritto Julien Benda, un intellettuale si tradisce quando scambia la sua autonomia per un investimento speculativo. Il clan del postmoderno ha imparato a ben dissimulare questo “tradimento” nelle contorsioni del conflitto benjaminiano tra realtà e rappresentazione.
Così passa la più grande devastazione urbana che la storia ricordi dai tempi del boom degli anni ’60. La turistificazione dell’identità storica delle città italiane e l’espulsione dai centri abitativi di interi segmenti di popolazione si comunicano nel nome della vivibilità, della resilienza, della virtuosità green e di tutto il sommo bene che una coscienza umana possa immaginare, nella più radiosa delle sue giornate.
Grazie alla filosofia della rappresentazione della cultura postmoderna, quindi del realismo capitalista, la superficie bidimensionale dei contenitori annulla la realtà dei fatti e delle cose, come una bottiglia in un quadro di Morandi.
In questo senso, il clan del postmoderno non ha avuto nessuno scrupolo a contrabbandare un evento così selettivo ed esclusivo come la brutale gentrificazione di Milano, sotto la bandiera dei valori positivi della sostenibilità e dell’inclusività.
In maniera concettualmente non dissimile, sir David Adjaye molestava le sue impiegate, chiedendo se fossero “abbastanza nere” da capire la sua visione dell’Africa e del suo lavoro.
In un paragrafo del saggio Approches du désarroi (Approcci al disordine), Houllebecq riassume così il programma dell’architettura contemporanea: construire les rayonnages de l’hypermarché social (costruire gli scaffali dell’ipermercato sociale). C’era appunto sfuggito che su quelle mensole, il prodotto prezzato e venduto eravamo noi.