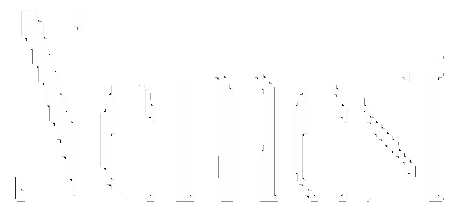“Mamma, si prendessero una margherita con capperi e una quattro formaggi e le dividiamo?”.
“Che t’avevo detto?”, guardando mio padre che intanto ha finito i grissini. “Vedi a non averlo mandato alla montessoriana? Le suore te li tirano su fertili ai ricatti trascendentali, ma l’autonomia, cristo di dio l’autonomia poi se la sognano”.
“No, mamma”, provo, “è che sono buone entrambe, lo so perché sono stato qui anche ieri sera, solo che non te l’ho detto perché poi mi dici sono sempre fuori, che è inutile vi chieda di coprire il finanziamento per il monopattino se poi gozzoviglio…”.
“Vedi?: timoroso, incapace di autoregolarsi, non ha neanche il coraggio di parlare. Colpa tua, con quei due giorni in più all’Alpe di Siusi e nel mentre le iscrizioni chiudevano, e il figliolo dalle suore a imparare l’Adeste fideles – male, per altro, perché ieri mentre lo cantava in bagno ho sentito chiarissimo un fidelis, NEANCHE LA TERZA DECLINAZIONE ACCIDENTI A LUI NEANCHE LA TERZA, ‘la classe dirigente del futuro’, dicevano sul depliant, certo”.
“No, mamma, non è questo, è che…”.
“Zitto c’è il cameriere, non ti fare sentire che poi ti ci sputano, nella pizza, e farebbero bene perché ti ci sputerei anch’io”.
Il giorno dopo, in coda dietro a una signora con addosso un vestitone di canapa, a pensare ancora a mia madre, e al mio attuale guaritore. Un visionario, ha scalzato l’ultimo operatore olistico, a sua volta subentrato dopo un paio di trimestri al quarto psicoterapeuta gestaltico, trapassato per un sovraddosaggio di allucinogeni – la conversione once > litri un macello, mica l’enneagramma. Con le provocazioni, suggerisce il guaritore, l’unica è lasciare correre. Fluire fluire fluire. Rispondere, invece, o mettersi sullo stesso piano, cercare di vincere lo scontro: tutto stress, modi per annacquare l’omeostasi.
“Buongiorno, un’informazione: fate anche le serali?”. La segretaria mi guarda. Scalza, in piedi alla scrivania, segna gli iscritti su un taccuino giallastro. “No, solo la mattina”. “Ci sono limiti d’età?”. “Limiti?”. “Appunto. Segni: Ubaldo Berti. Quando cominciano le lezioni?”. “Domani”. La classe dirigente del futuro. Come no. À la guerre.
La mattina dopo arrivo, e subito un primo errore: il “Bosco” nel nome della scuola non è allusivo. Non “la selva dell’apprendimento”, non “impariamo a orientarci nella cultura”. Le metafore le lasciano al liceo classico. Qui il letterale. E ci volevano gli chantilly. Io, invece, pensando di calarmi meglio nel contesto, ho optato per una mise dalemiana: polo a maniche corte, pulloverino, scarpe da barca. E pantaloni, anche, ovvio. Così slitto verso l’appello.
Il gruppo classe sta vorticando intorno a una delle maestre, che segna le presenze gettando dei ciottoli in un cesto di vimini. “Barni”, urla. E il Barni scocca una freccia. “Belli”. E la Belli emerge dal fango. Berti. “Presente”, urlo convenzionalissimo. “Fascio”, mi risponde un bambino biodinamico, appeso a un ramo a due metri dalla mia testa. Ottimo: si fa amicizia.
Finito l’appello cominciamo la passeggiata. E subito stimoli, stimoli ovunque. Altro che sussidiario. Nell’ordine: un paio di zecche attaccate al pullover, una frasca che mi sferza l’occhio destro, colpi di tosse, starnuti, unghie nere, le grida felici di due studenti che alla passeggiata hanno preferito la corsa e ora provano a raggiungere le coclee della maestra dal fondo di un mezzo burrone. “Sarà il caso di aiutarli?”. “Come no, e magari poi li interroghiamo pure”, fa in tempo a redarguirmi una bambina, prima di raggiungerli. Madonna che figura da zotico. Ancorato alla didattica tradizionale.
E zotico mi confermo anche durante i laboratori. Mentre i miei compagni si danno chi alla falegnameria chi alla cura dell’orto, io mi accomodo sanguinando su un sasso e provo a improvvisare una garza sfogliando un kleenex 4 veli. Mi raggiunge la maestra. “Ubaldo”. Mi accarezza la testa, suo malgrado perché prima di uscire ho provato una nuova cera modellante applicando – come da istruzioni – una noce di prodotto. Cerca di pulirsi senza farsi vedere e continua. “Ubaldo, che ti va di fare?”. La guardo. “Non saprei, maestra. C’è qualche lezione?”. Compassione. “Ubaldo, ti ho chiesto: che ti va di fare?”. Non capisco. Sembra irritarsi. “Che cosa ti va, Ubaldo?”. Continuo a non capire. Intanto un calabrone le sorvola la spalla. Mi allungo per scacciarlo, lei scoppia di entusiasmo. Mi abbraccia. “Ecco, Ubaldo, ora ci siamo. IL CONTATTO. Relazionale, sensoriale, emotivo. Tocca, Ubaldo. TOCCA”. Mi scaraventa contro una pila di oggetti abbastanza angolosi. Cubi e cilindri di legno, lettere smerigliate, tavolette piene di rughe. “Tocca”, ripete. E io comincio a strofinare il palmo su una piccola scala, senza smettere di guardarla. “Così”, mormora allontanandosi. Mi lascia solo.
Tocco per una mezz’ora, variando quanto possibile. Struscio, picchietto, titillo. Massaggio, gratto, strizzo. Per un attimo penso pure di leccare, ma un bambino – lo stesso dell’appello – mi coglie mentre avvicino un cilindro alla punta della lingua e mi blocca. “Non lo farei”, perentorio. Così torno a tamburellare. E proprio quando sento che l’apprendimento sta per cominciare – lì, mentre mi sfrego il ginocchio con un parallelepipedo – la maestra ci chiama. È ora di mangiare. Peccato.
Altra gaffe, per fortuna questa non verbalizzata. Avvicinandomi alla mensa mentalizzo infatti grandi contenitori in polistirolo, cuochi con la cuffia, un civilissimo self service. Sciocco elettore di centrodestra. Qui il cibo lo preparano gli studenti, e lo servono in gamelle di alluminio. Adocchio i cucinieri, e all’imbarazzo subentra la speranza. Occasione di riscatto: perché il ragazzo magari non saprà manipolare i cilindri, ma ha in repertorio una maionese alla curcuma clamorosa. Mi addentro tra i giovani cuochi e acchiappo tre uova. Chiedo un minipimer. “Come no, e magari gli mettiamo anche un voto”, mi risponde la bambina che sta affettando i pomodori e parte delle sue falangi. Vado di forchetta. Il polso mi duole un pochino perché a forza di strofinare e picchiettare sono al limite della resistenza muscolare ma non demordo. Perfetta. Raggiungo gli altri e la presento con – non mi vergogno a dirlo – una certa boria. “L’hai pastorizzata?”, chiede un bambino. “No”, ammetto colpevole. Mi strappa di mano la ciotola e la tira contro un albero. “Ma con chi pensi di avere a che fare, con delle bestie?”. Sono irrecuperabile. Le suore mi hanno rovinato, ha ragione mia madre.
Mi allontano avvilito. Prendo da una cesta un cubo di Rubik e mi metto a sedere su una panchina. Dopo un paio di minuti, mi raggiunge un bambino. “May I?”, mi chiede con perfetto accento dell’Oxfordshire. Annuisco. Si chiama Gionata, ha 7 anni, è al secondo anno di montessoriana. Dopo le presentazioni torno al cubo, mentre lui resta a guardarmi. Una, due, tre girate. Fallisco. Riprovo. Fallisco meglio, come direbbe quel debosciato di Beckett. Ma fallisco comunque. Alzo gli occhi a Gionata, che intanto ha acceso una Marlboro. “Vedi, Ubaldo”, mi dice. “Il guasto vero è che la gente pensa davvero che la scuola conti qualcosa. I vecchi borghesi con la fissa del liceo classico, le mamme fricchettone coi deodoranti in pietra d’allume gli approcci pedagogici alternativi. Ma la verità è che l’appalto educativo è tutto in carico alla famiglia. Che non lo cederebbe mai, pure fingendo di non volerlo. E d’altronde sarebbe follia pensare che 5 ore settimanali di latino o di laboratori nel bosco possano fare il pari con il lento e incessante lavorio della quotidianità domestica, delle cene babbo mamma fratelli, dei fine settimana noiosi. Tutti i discorsi sulla scuola – la scuola dovrebbe, la scuola potrebbe – sono diversivi, modi per scaricare la responsabilità dei danni irreparabili, anzi – concedimi l’anastrofe –, degli irreparabili danni causati dalle aspirazioni, dalle repressioni, dalle preoccupazioni che si respirano in casa. La scuola, ma anche il calcio, o il corso di danza, o l’ora di chitarra, nel migliore dei casi sono parcheggi, quando non – nel peggiore – rinforzi calibratissimi per corroborare il progetto familiare ideato intorno al figlio, che dovrà dimostrarsi ora un cacasenno che ha saputo leggere in metrica e oggi dirige con orgoglio l’azienda di famiglia, ora un anarchico insurrezionalista che ha imparato a non rispettare neanche i sensi unici dando libero sfogo alla sua sensorialità ciucciando pastelli già ciucciati in un bosco, proprio come noi, sciagurati senza speranza di salvezza”. Lo guardo. Spenge la sigaretta, sospira, si alza e si incammina. Attraversa gli altri bambini, le maestre, le gamelle con le posate di cartone, affonda un piede scalzo su un dodecaedro di legno ma senza dare a intendere dolore continua a camminare. Entra nella boscaglia, sparisce. Gionata ha capito. Vorrei rincorrerlo, raggiungerlo, abbracciarlo, dirglielo, ringraziarlo, chiedergli salvami, portami con te. Ma non posso. Non posso, perché questo cubo di Rubik m’è venuto un’altra volta metà giallo e metà blu e ora come Beckett provo ancora e se non mi riesce neanche stavolta dio santo lo tiro in un albero e poi prendo uno di quei tizzoni con cui stanno cucinando e vado ad appiccare il fuoco alla Fondazione Montessori.