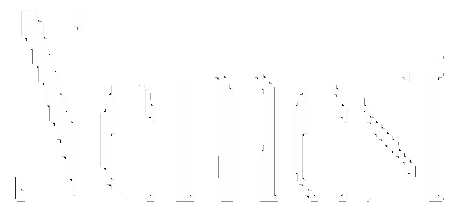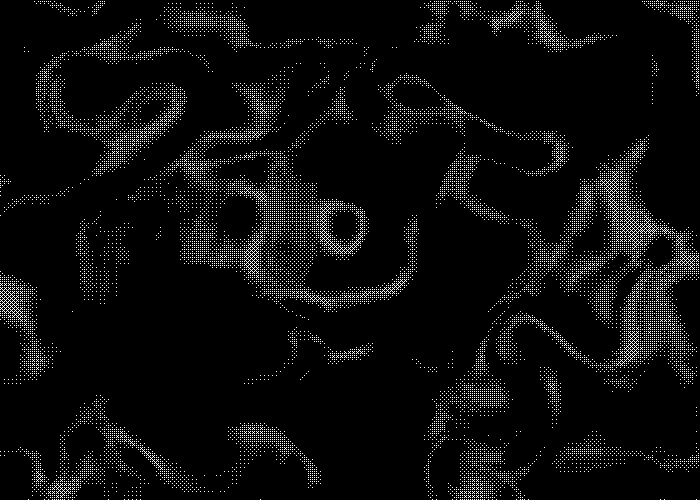Teheran. In Iran sta per concludersi un anno di disordini. Sul quadrante della politica, la lancetta si è a malapena spostata. Il governo semiliberale di settembre a novembre è stato rimpiazzato da un governo per metà militare. Di fatto, è colpito tutto il Paese: città, campagne, centri religiosi e regioni petrolifere, bazar, università, funzionari, intellettuali. Anche i topi privilegiati abbandonano la nave. Tutto un secolo di Iran è rimesso in questione: lo sviluppo economico, la dominazione straniera, la modernizzazione, la dinastia, la vita quotidiana, le abitudini. Rifiuto generale.
Non so fare la storia del futuro. E sono un po’ maldestro a prevedere il passato. Vorrei tuttavia cercare di cogliere quello che sta accadendo, perché in questi giorni niente è concluso e i dadi stanno ancora rotolando. Forse è questo il lavoro del giornalista, ma è pur vero che sono solo un neofita.
L’Iran non è stato colonizzato, mai. Nell’Ottocento inglesi e russi l’hanno diviso in zone di influenza, secondo una modalità precoloniale. Venne il petrolio, vennero le guerre mondiali, il conflitto del Medio Oriente, i grandi scontri dell’Asia. Con un balzo, l’Iran è passato a una situazione neocoloniale nell’orbita degli Stati Uniti. Una lunga dipendenza senza colonizzazione diretta: vale a dire che le strutture sociali del Paese non sono state distrutte radicalmente. Non sono state nemmeno completamente stravolte dall’afflusso di rendite petrolifere, che avranno anche arricchito i privilegiati, favorito la speculazione, permesso i sovra-equipaggiamento dell’esercito, ma non hanno creato nuove forze all’interno della società. La borghesia dei bazar è stata indebolita; le comunità dei villaggi sono state intaccate dalla riforma agraria. Ma entrambe sono sopravvissute, abbastanza da soffrire della dipendenza e dei cambiamenti che ha apportato, ma anche abbastanza da resistere al regime che ne era responsabile.
Sui movimenti politici questa stessa situazione ha prodotto un effetto contrario. All’ombra della dipendenza, anche questi sono sopravvissuti, ma non hanno potuto mantenersi come forze reali – a causa della repressione, ma anche a causa delle loro stesse scelte. Il Partito comunista? È stato legato all’Urss, compromesso nell’occupazione dell’Azerbaigian sotto Stalin, ambiguo nel suo sostegno al «nazionalismo borghese» di Mosaddeq. Quanto al Fronte nazionale, erede dello stesso Mosaddeq, ha atteso per quindici anni, senza muoversi, l’ora di una liberalizzazione che non credeva possibile senza l’accordo degli americani. Intanto, alcuni quadri impazienti del Partito comunista diventavano tecnocrati del regime: sognavano un governo autoritario per portare avanti una politica nazionalista. Insomma, i partiti politici sono stati vittime di quella «dittatura dipendente» che era il regime dello Shah; in nome del realismo, gli uni puntavano all’indipendenza e gli altri alla libertà.
Assenza di un colonizzatore-occupante e presenza, in compenso, di un esercito nazionale e di una notevole polizia: per questo non si sono potute formare le organizzazioni politico-militari che altrove hanno animato le lotte di decolonizzazione e che, al momento opportuno, si sono trovate in condizione di negoziare l’indipendenza e imporre la cacciata della potenza coloniale. In Iran, il rifiuto del regime è un fenomeno sociale di massa. Questo non significa che sia confuso, affettivo, poco cosciente di sé. Al contrario, si diffonde in modo particolarmente efficace, dagli scioperi alle manifestazioni, dai bazar alle università, dai volantini alle prediche, tramite commercianti, operai, religiosi, professori e studenti. Ma al momento nessun partito, nessun uomo, nessuna ideologia politica può vantarsi di rappresentare questo movimento. Nessuno può pretendere di mettersene alla testa. Non ha nessun corrispettivo e nessuna espressione a livello politico.
Il paradosso è tuttavia che questo movimento costituisce una volontà collettiva perfettamente unificata. È sorprendente vedere questo immenso Paese, con una popolazione sparsa su due grandi altopiani desertici, questo Paese che ha potuto permettersi le ultime sofisticatezze della tecnica accanto a forme di vita immobili da mille anni, questo Paese stretto dalla censura e dall’assenza di libertà civili e che nonostante tutto dà prova di una così incredibile unità. È la stessa protesta, la stessa volontà che viene espressa da un medico di Teheran e un mollah di provincia, da un operaio del petrolio, da un impiegato delle poste e da una studentessa sotto il chador. Questa volontà ha qualcosa di sconcertante. Si tratta sempre di una stessa cosa, una e ben precisa: la partenza dello Shah. Ma per il popolo iraniano quest’unica cosa vuol dire tutto: la fine della dipendenza, la scomparsa della polizia, la ridistribuzione delle rendite petrolifere, la caccia alla corruzione, la riattivazione dell’Islam, un altro modo di vita, nuovi rapporti con l’Occidente, con i Paesi arabi, con l’Asia ecc. Un po’ come gli studenti europei degli anni Sessanta, gli iraniani vogliono tutto; ma questo tutto non è quello di una «liberazione dei desideri»: è quello di un’emancipazione da tutto ciò che nel loro Paese e nella loro vita di ogni giorno segna la presenza delle egemonie planetarie. Per questo i partiti politici – liberali o socialisti, di tendenza filoamericana o di ispirazione marxista – o, meglio, la scena politica stessa sembra loro ancora e sempre un’agente di queste egemonie.
Di qui, il ruolo di quel personaggio quasi mitico che è Khomeini. Nessun capo di Stato, nessun leader politico, anche con l’appoggio di tutti i media del suo Paese, può oggi vantarsi di essere l’oggetto di un attaccamento così personale e così intenso. Questo legame dipende forse da tre cose: Khomeini non è qui: da quindici anni vive in un esilio dal quale non vuole tornare se non dopo che lo Shah sia partito; Khomeini non dice niente, nient’altro che «no» – allo Shah, al regime, alla dipendenza; infine, Khomeini non è un politico: non ci sarà un partito di Khomeini, non ci sarà un governo di Khomeini. Khomeini è il punto in cui si fissa una volontà collettiva. Che cosa cerca quindi quest’ostinazione che niente viene a distrarre? La fine di una dipendenza in cui, dietro gli americani, si riconosce un consenso internazionale e un certo «stato del mondo»? La fine di una dipendenza di cui la dittatura è lo strumento diretto, ma di cui i giochi della politica potrebbero anche essere il tramite indiretto? Non si tratta di una sollevazione spontanea a cui manchi un’organizzazione politica: è un movimento per liberarsi tanto dalla dominazione dall’esterno quanto dalla politica all’interno.
Quando ho lasciato l’Iran, la domanda che mi veniva sempre posta era ovviamente: «È questa la rivoluzione?» (è a questo prezzo che in Francia tutta un’opinione acconsente a interessarsi di quello che «non è un affare interno»). Non ho risposto. Ma avrei voluto dire: non è una rivoluzione nel senso letterale del termine: un modo di alzarsi e rimettersi in piedi. È l’insurrezione di uomini a mani nude che vogliono sollevare l’enorme peso che grava su ognuno di noi, ma più in particolare su di loro, su questi lavoratori del petrolio, questi contadini ai confini degli imperi: il peso dell’ordine del mondo intero. È forse la prima grande insurrezione contro i sistemi planetari, la forma più moderna della rivolta e la più folle.
È comprensibile l’imbarazzo dei politici. Escogitano soluzioni, più facili a trovarsi di quanto non si dica; vanno dal puro e semplice regime militare a una trasformazione costituzionale che porti dalla reggenza alla repubblica. Tutte passano per l’eliminazione dello Shah. Che cosa vuole il popolo, quindi? Non desidera in fondo niente di più? Lo sanno tutti che vuole ben altro. È per questo che si esita tanto a proporgli solo questo ed è per questo che si è in un vicolo cieco. In effetti, che posto si può fare, nei calcoli della politica, a un movimento come questo? Un movimento che non si lascia disperdere in scelte politiche, un movimento attraversato dal soffio di una religione che più che dell’aldilà parla della trasformazione di questo mondo.