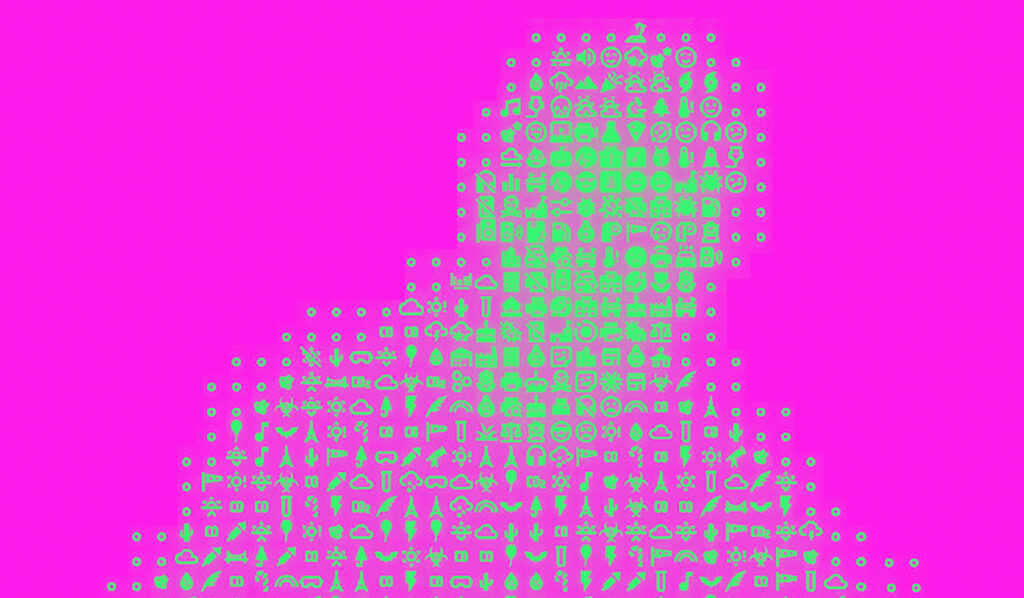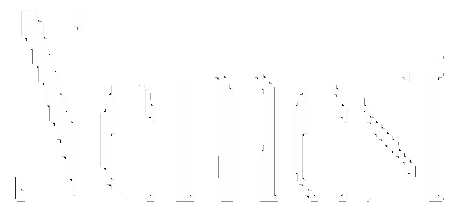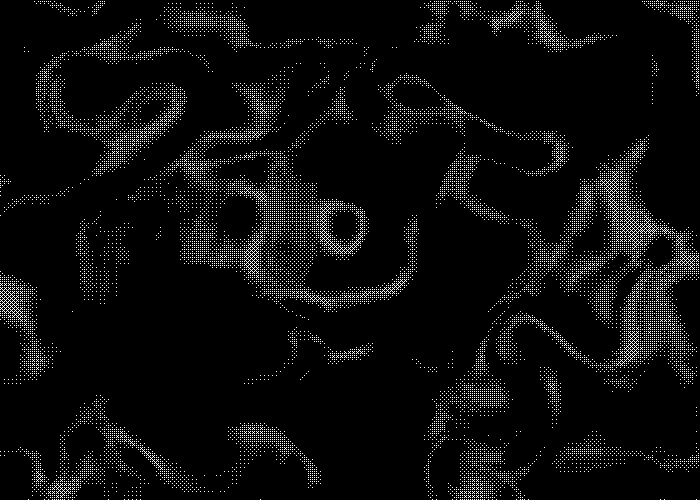Oggi si ha l’illusione di essere liberi. Un’illusione dolce, narcotica, che penetra attraverso ogni notifica, ogni like, ogni scroll. Siamo convinti di scegliere: cosa guardare, cosa ascoltare, cosa pubblicare. Ma è una libertà addomesticata, una libertà messa al guinzaglio. Il guinzaglio non è più visibile come un manganello o una censura ministeriale: è una formula matematica, un calcolo di compatibilità.
È qui che entra in gioco l’algoritmo: non come semplice strumento tecnico, ma come dispositivo ideologico. Non ci limita dall’esterno, ma ci guida dall’interno, sostituendosi ai nostri criteri. Non censura, ma orienta. Non vieta, ma premia ciò che è conforme: ciò che funziona, ciò che viene accettato, replicato, monetizzato. È il trionfo dell’aderenza come virtù, della compatibilità come valore.
L’algoritmo non impone contenuti. Impone forme. Ritmi, estetiche, toni. Omologa senza obbligare. E in questo senso si comporta come una nuova forma di potere culturale, più efficiente dei vecchi modelli autoritari, perché non deve più imporre la regola: gli basta rimuovere tutto ciò che non è compatibile col sistema di visibilità. È un potere che opera non per divieto, ma per assorbimento. Un potere senza volto, che non si dichiara mai come tale.
Chi oggi si discosta dalla logica del contenuto – chi non semplifica, chi non si adatta, chi non si rende riconoscibile o spendibile – viene neutralizzato. Non escluso in senso classico, ma semplicemente non calcolato. Invisibile. Scartato dall’algoritmo come un dato irrilevante. Il dissenso non è represso, è ignorato. Ed è proprio qui che si manifesta l’aspetto più subdolo del controllo digitale: non la violenza dell’oppressione, ma quella dell’indifferenza.
Questo non avviene per censura, ma per una forma più raffinata di controllo: la misurazione costante del valore sociale attraverso l’attenzione. Non sei visibile? Allora non esisti. Non sei performante? Allora non sei rilevante. È il mercato della presenza. L’attenzione non è più solo un bene scarso: è la nuova unità di misura dell’esistenza pubblica. Un like vale più di un’idea. Un engagement più di una posizione politica.
Pensate a TikTok, Instagram, YouTube: sono spazi apparentemente orizzontali, democratici. Tutti possono parlare, tutti possono “essere”. Ma a quale prezzo? Il prezzo è la forma. Devi avere il ritmo giusto, la faccia giusta, il tono giusto. Devi stare nei 60 secondi. Devi piacere subito. Devi funzionare. È il dominio della performatività. L’esistenza stessa si misura in click, in views, in engagement. Una ragazza può parlare di femminismo, purché lo faccia con il filtro giusto. Un ragazzo può fare satira politica, purché non ecceda, non approfondisca, non spaventi.
Anche la trasgressione è prevista. È già parte del piano. L’algoritmo è pronto a monetizzare anche il dissenso, purché sia elegante, ironico, “condivisibile”. Non c’è niente che non possa essere inglobato. L’antagonismo diventa un’estetica, una nicchia, un brand. La ribellione è prevista nel palinsesto. Così l’oltraggio diventa contenuto virale. Il grido si trasforma in entertainment. Il dolore si fa storytelling. Non esiste più lo scandalo, solo l’attenzione. È la nuova estetica del potere: ciò che non attira, decade.
Ed è qui che il fascismo rinasce. Non come nostalgia del Ventennio, ma come logica dell’adesione. Non c’è più un partito, non c’è più un duce, non ci sono divise: ma c’è una forma di dominio che orienta senza comandare. Che plasma senza costringere. Che ottimizza l’individuo per renderlo performante. Si partecipa non per scelta, ma per non scomparire. È la dittatura della presenza.
Una volta la repressione si esercitava con la violenza. Oggi si esercita con la misura. Ogni nostro gesto è tracciato, valutato, trasformato in dato. E il dato viene trasformato in profitto. Non siamo più soggetti, ma estrattori involontari di valore. Ogni emozione è una moneta. Ogni like è una confessione. Ogni scroll è una scelta politica, travestita da svago.
La scuola non educa più, suggerisce. La cultura non forma, intrattiene. Il dissenso non resiste, si adatta. È la fine della coscienza critica. È il trionfo della compatibilità.
E allora la resistenza, oggi, non è romantica né clamorosa. Non è spegnere il cellulare o chiudere l’account. È rifiutare l’idea che l’esistenza debba essere visibile per essere vera. È accettare l’irrilevanza come atto politico. È parlare in un linguaggio che non converte. È creare contenuti che non funzionano. Che disturbano. Che non fanno community. Che non monetizzano.
Non per nostalgia. Non per moralismo. Ma per restituire dignità all’umano che sfugge al calcolo. Alla parola che non serve. Al gesto che non performa. Alla fragilità che non si mostra. Alla verità che non si vende.
Perché il potere oggi non ti comanda: ti seduce. E non c’è niente di più pericoloso di un potere che non ha più bisogno di farsi odiare per farti obbedire.