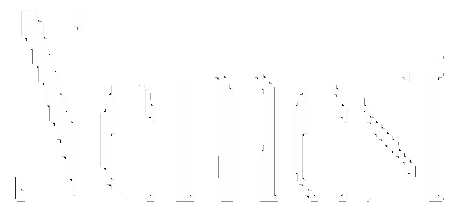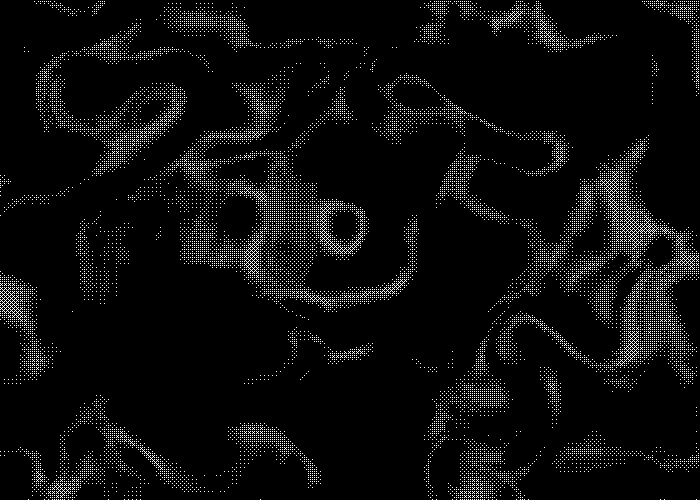Viviamo un tempo in cui tutto ciò che accade non accade veramente: viene mostrato.
Non si è più, si appare. Non si pensa, si pubblica.
Ed è così che è nato, e si è imposto, il nuovo dio della nostra epoca: l’influencer. Ma chi è, davvero, l’influencer?
Non è un artista, non è un intellettuale, non è un politico, non è un maestro. Eppure prende da ciascuno ciò che gli conviene: il pubblico dell’artista, la voce dell’intellettuale, l’autorità del politico, il fascino del maestro.
Senza prendersi mai la responsabilità di nessuno di questi ruoli. È il nuovo gerarca dell’apparenza, il funzionario del consenso mascherato da spontaneità.
È il soldato del mercato che non ha bisogno di armi, perché ha lo sguardo: seduce, plasma, addestra.
E la società — che da tempo ha smesso di amare la profondità — non lo guarda con sospetto, come si guarda un trucco, ma con invidia, come si guarda un privilegio.
Ed è proprio qui, in questa invidia muta, che si consuma la più silenziosa delle tragedie.
In questa bolla di pixel, filtri e luci LED, l’influencer emerge come figura centrale: la macchina perfetta che addestra a consumare invece che a pensare.
Una creatura nata dal ventre del capitalismo più raffinato: quello che non reprime, ma seduce. L’influencer è il volto umano della pubblicità, il contenitore ammiccante del nulla. Vende la propria vita come prodotto, ogni gesto confezionato per piacere, ogni frase ottimizzata per la condivisione, ogni emozione pronta a diventare contenuto.
La tristezza? Monetizzabile.
Il corpo? Strategicamente esibito.
Il pensiero? Purché non disturbi.
Ci raccontano che è “un nuovo lavoro”. Ma cosa comunica, esattamente? Non la realtà. Non la complessità. L’influencer comunica desiderabilità, e cioè conformismo. Ripete ossessivamente gli stessi codici visivi, gli stessi sogni da acquistare, le stesse parole svuotate. Non mette mai in discussione nulla, perché è parte integrante di tutto ciò che dovrebbe essere messo in discussione.
Saturare, non censurare: ecco la nuova strategia. E allora scorrono senza sosta contenuti “inspirational”: pubblicità camuffate da vita vera, storytelling motivazionali, emozioni da algoritmo.
Anche la rivolta è stata addomesticata. L’influencer può dirsi impegnato, attivista, consapevole… ma solo finché non tocca i nervi scoperti dei suoi sponsor. Ogni lotta è trasformata in estetica. Anche il disagio, anche la rabbia, anche la denuncia: se funziona sui social, tutto è spendibile.
La rivoluzione è diventata un trend stagionale.
Il dolore, se ben montato, può fare numeri.
Il silenzio, invece, non converte.
E allora eccoli, milioni di ragazzi che non vogliono più essere, ma funzionare. L’autenticità è sostituita dal “personale vendibile”. Ci si costruisce un volto compatibile con l’algoritmo, si vive nella fame costante di attenzione, nella paura dell’invisibilità.
Il like è diventato moneta emotiva. L’unfollow, una ferita.
Ma l’influencer non è il problema. È il sintomo.
È il figlio prediletto di una società che ha perso la capacità di riconoscere la verità. Il sistema che lo ha creato è lo stesso che ci ha convinti che essere visti è più importante che essere capiti. Che la felicità è una questione di immagine, e che tutto ciò che non può essere venduto… non vale.
L’influencer è il volto moderno del potere.
Non impone: seduce.
Non ordina: suggerisce.
Non ti proibisce di pensare: ti distrae dal farlo.
È la forma estetica dell’obbedienza. Obbedisce ai codici del consumo, alle leggi del mercato, alla grammatica dell’algoritmo. E così, mentre mostra la sua vita, viene vissuto dalla vita degli altri.
L’influencer non ha visione, ma visibilità. Non cerca verità, ma viralità. Non crea coscienza, ma dipendenza. È il modello perfetto per un mondo che ha sostituito la speranza con l’intrattenimento.
E chi lo guarda, non lo critica. Lo invidia.
L’invidia è il contrario del pensiero: non vuole capire, vuole ottenere. Così, ogni giorno, milioni di persone non si chiedono che senso ha quella vita, ma come si fa ad averla.
Un tempo, gli intellettuali disturbavano il potere. Lo smascheravano. Gli strappavano la maschera.
Oggi non disturbano più. Sono diventati silenziosi o si sono ibridati al nuovo ordine: alcuni fingono ancora di pensare, ma lo fanno in modo accettabile, ottimizzato, social friendly. Senza dolore. Senza rischio.
I politici stessi sono diventati influencer: non convincono, piacciono. Non progettano, promettono. Non parlano ai cittadini, ma agli utenti. E mentre fanno dirette su TikTok e postano meme, la realtà sociale — quella vera, quella che non si filma — sprofonda.
Tutto ciò che dovrebbe formare coscienza è stato sostituito da ciò che genera traffico. La coerenza è diventata un ostacolo. La profondità è vista come lentezza, e viene punita dagli algoritmi. La verità è diventata irrilevante.
L’influencer è un modello replicabile, desiderabile, vuoto. È il simulacro perfetto: ciò che tutti vogliono essere, senza sapere davvero perché. Questa figura non esiste da sola. È il prodotto della nostra rinuncia collettiva alla complessità. È il frutto di una società che preferisce apparire felice piuttosto che essere libera.
Ecco perché il vero orrore non è la figura dell’influencer in sé — ma il nostro desiderio di diventarlo.
E allora — che fare? Che pensare? Come uscirne?
Forse dovremmo tornare a sospettare di ciò che piace troppo, a chiederci perché qualcosa funziona così bene, chi ci guadagna dalla nostra attenzione costante, chi decide ciò che vediamo — e ciò che non vediamo più.
Forse dovremmo tornare ad ascoltare chi non ha followers, ma visione. Chi parla piano, ma dice cose che feriscono — e salvano. Dovremmo interrogarci sul fatto che oggi un adolescente conosce le routine di un influencer, ma non sa cosa sia un dubbio morale. Che sogna di “diventare qualcuno” senza sapere per fare cosa.
Non si tratta di fare una crociata moralistica. Non è questione di demonizzare gli influencer come individui. Il problema non è la singola persona: è il sistema che premia l’apparenza e punisce il pensiero.
Siamo noi il terreno fertile. Siamo noi che accettiamo che ogni spazio umano venga convertito in marketing. Che applaudiamo alla vetrina anche quando ci toglie profondità. Che scambiamo la popolarità per significato, l’approvazione per amore.
La vera ribellione oggi non è farsi notare. È sottrarsi.
Non urlare, ma scegliere il silenzio.
Non postare, ma pensare.
Rivendicare il diritto all’ombra, alla complessità.
Perché essere sé stessi non dovrebbe mai significare diventare un brand. Dovremmo tornare a esigere — e a costruire — una nuova funzione dell’intellettuale. Non come nostalgico profeta, ma come voce che rompe l’incantesimo. Che ricorda ciò che abbiamo dimenticato. Che ridà peso alle parole. Che torna a vedere.
Perché, in fondo, ogni epoca ha gli idoli che si merita.
Ma ogni epoca può ancora scegliere se inginocchiarsi o aprire gli occhi.