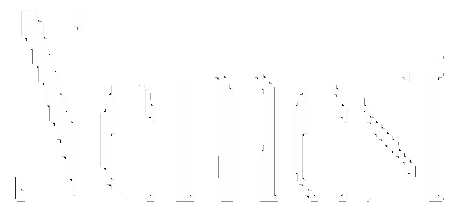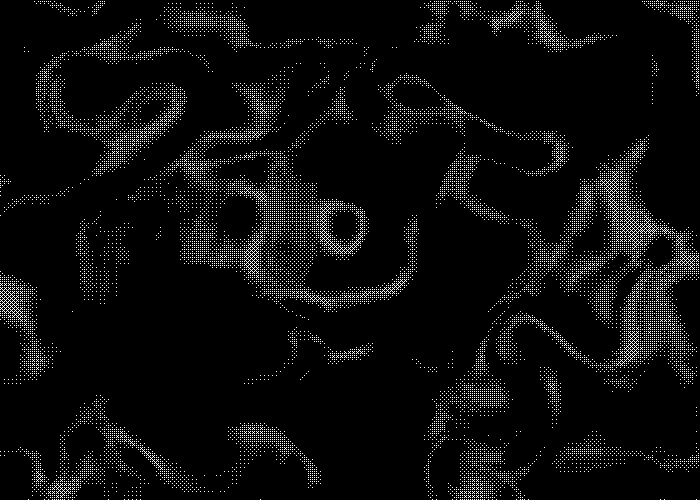Luca Rossi lo evochi online e ti appare come notifica: è un’entità fantasma che ti scrive in caps lock, un guru che parla una lingua di formule e meme, con la faccia del critico Enrico Morsiani. Savonarola 2.0 dell’arte contemporanea con un account Instagram. La liturgia del museo come linguaggio digitale è il suo stile comunicativo, una serie di mantra e formule critiche ripostate e ripetute ossessivamente: Ikea evoluta, giovane Indiana Jones, nonni e genitori foundation, altermoderno.
Chi lo incontra per caso in rete, non incontra una persona, ma un dispositivo razionale di critica applicato all’arte: un algoritmo umano che ti riflette addosso la tua stessa ricerca isterica, un po’ ego un po’ critica elevata ad arte. Rossi è il glitch sacro, il bug che diventa vangelo, angelo vendicatore, artista satirico, critico e gallerista di se stesso. È l’oracolo dell’arte contemporanea che dà i voti agli artisti del momento, in barba agli odi ed alle pubbliche relazioni, e si inventa seminari e performance per imparare a vedere l’arte; la sua è sempre minimale ed invisibile, sembra che si sottrae ma è in bella mostra come tutto.
Luca Rossi non esiste, o forse è più reale di chi espone a Basilea o alla Biennale, esiste anonimamente, ma basta Google per trovare tutto su di lui. È un’entità diffusa, una maschera virale, un collettivo che oscilla tra l’artista e il profeta, la poesia visiva ed il critico d’arte, il troll e il curatore dj, per una post-verità dell’arte contemporanea vivente.
Vincenzo Profeta: Tu dici sempre che l’artista non dovrebbe aggiungere ma togliere: smontare anziché produrre, che produrre contenuti ormai lo fanno tutti. In un mondo che misura tutto in like, views, oggetti venduti, come può il gesto di “togliere” risultare comprensibile, avere, come dicono oggi, hype, aura, essere desiderabile, ed essere desiderato e quindi comprato, non ti sembra un po’ un atteggiamento da nichilismo snob, da hipster fuori tempo massimo?
Luca Rossi: Serve una SLOW ART, una forma di ecologia. Il simulacro che chiamiamo artista deve cambiare pelle e inocularsi nelle reti che ci soffocano. Non è solo questione di togliere, come diceva Alda Merini “basta poco per essere felici basta vivere come le cose che dici”.
VP: Secondo una tua teoria, l’arte è una sorta di etica e pulizia della visione proprio-oculare, insomma l’arte contemporanea ti insegna a vedere le cose belle, a decontestualizzarle. Immagina che una nonna entri in un museo contemporaneo: che cosa vede? E cosa invece non vede, perché non le è concesso? Forse la nonna capisce più di noi, perché non si fa fregare dal linguaggio dell’apparato contemporaneo, che ormai pervade tutto e non è più esclusiva degli artisti, e distrae da tutto?
LR: Bambini e nonni sono i migliori. Sicuramente c’è più arte in un prato in Irlanda a picco su una scogliera all’imbrunire che alla Biennale o ad Art Basel. Ma allora l’artista deve portare le persone su quel prato, diversamente è meglio stare a casa. Attenzione perché molte persone non vogliono vedere, non vogliono “allenare nuovi occhi” perché vedere sarebbe per loro una tragedia. Vorrebbe dire cadere giù da quella scogliera.
VP: Ma tu, Rossi, di fatto produci arte. Le tue operazioni digitali, le tue intrusioni critiche: sono opere travestite da opinioni, aldilà del marketing low cost, quanto influiscono poi realmente? Non pensi che lo stile da professorino, anche ironico, sia un po’ datato.
LR: A me sembra che tutti stiano improvvisando, dai capi di Stato fino a tutti noi, fino al signor Rossi qualsiasi. Anche qui bisogna ripensare da zero la formazione artistica. Dal 2009, prima di tutto, punto contro me stesso l’arma della critica. Luca Rossi ha ucciso quello che ero prima. Prima di realizzare un’opera da appendere c’ho messo 10 anni, non so in quanti possano vantare questo lusso.
VP: Spiegaci in breve i concetti critici, di giovane Indana Jones, nonni e genitori foundation, Ikea evoluta, altermoderno.
LR: Il più grande ammortizzatore sociale dell’arte italiana e non solo (direi di tutto il substrato economico e produttivo italiano), è la Nonni-Genitori Foundation. Ossia i risparmi e la ricchezza accumulati dai nostri nonni e genitori, mantengono economicamente – e in ostaggio – le generazioni successive. Questo aiuta ma rende anche arrendevoli, deboli, imprigionati in gabbie dorate. Ecco i giovani artisti che, per compiacere nonni e genitori, sono costretti a scavare nei cimiteri per trovare valori sicuri, una forma di “archeologia generazionale” che nel 2012 ho chiamato la Sindrome del Giovane Indiana Jones. Negli anni ’90 con il postmoderno avanzato l’arte è uscita dai musei, e da 25 anni vive nella realtà. Se non ci occupiamo di arte contemporanea la peggiore arte contemporanea si occuperà delle nostre vite. Nella Società dei Polpastrelli e delle Informazioni, la fase che Nicolas Bourriaud definisce “altermoderna”, l’artista comunemente inteso deve resistere alle degenerazioni e ai problemi del suo tempo; quindi inocularsi nelle reti che lo soffocano. Ma gli artisti preferiscono, pagati da nonni e genitori, posture rigide e nostalgiche e quindi fare ancora i quadretti nel proprio studio quello che spesso ho definito “Ikea evoluta”. Pretenzioso decoro da interni. Questo tipo di arte non mi interessa, ed è proprio quel tipo di arte che vuole disinnescare il pensiero critico e divergente.
VP: L’arte, oggi, è a mio modesto parere è il tentativo disperato di restare indietro con eleganza, o al massimo come dici anche tu stesso un luna park per adulti. Quindi il museo diventa la cattedrale del ritardo, del sottrarsi in fondo a un reale noioso, proprio perché ha assorbito totalmente i meccanismi dell’avanguardia?
LR: Hai ragione, oggi c’è molta più arte di qualità dove non cerchiamo l’arte. Solo però se ripensiamo completamente la formazione e la divulgazione, ma per fare questo ci vuole senso critico, ci sono delle autostrade da percorrere. Quindi sì, se guardiamo mostre fiere e biennali l’unica cosa che vediamo è una sovraproduzione di oggetti noiosi, inutili e anacronistici.
VP: Altro tuo mantra, se non ti occupi dell’arte contemporanea un giorno l’arte contemporanea si occuperà di te, ci spieghi cosa intendi?
LR: Se guardiamo l’arte prodotta negli anni ’90 vediamo un postmoderno avanzato dove l’arte cercava realmente di impattare con la realtà. Progetti come Facebook, Amazon, Apple, i social network sono progetti che hanno germi creativi e artistici. Ma da vent’anni anche tutta la politica e la “generazione Tinder” – ossia l’arte contemporanea – si è assorbita nelle nostre vite, quindi se non abbiamo la capacità di allenare nuovi occhi non la possiamo vedere e non ci possiamo difendere. Se non ti occupi di arte contemporanea, l’arte contemporanea si occuperà della tua vita e saranno guai. Esattamente come sta succedendo.
VP: Anticipi l’ipocrisia, la metti in scena prima che loro possano recitarla. È un teatro preventivo: mostri il vuoto prima che diventi moda?
LR: “Luca Rossi” è un ruolo sclerotico che veste tutti i ruoli del sistema dell’arte, come se il signor Rossi si fosse svegliato una mattina e abbia deciso di fare tutto lui. Una parodia estrema, sincera e radicale.
VP: Come si può campare d’arte, l’arte può avere un suo specchio economico degno? In fondo è un lavoro anche faticoso. Cosa pensi del fatto che l’arte antiborghese è solo un mito borghese, e che quindi bisogna tornare ad un sistema di mecenati e botteghe, per tornare ad avere una dignità. Quali saranno poi le applicazioni dell’intelligenza artificiale in tutto questo, sarà un medioevo cyberpunk per gli artisti, per il mondo, per tutti?
LR: Gli oggetti dell’arte sono solo testimoni di modi, atteggiamenti, visioni e attitudini, una nuvola di valore da cui precipitano quelle che chiamiamo opere d’arte. Se l’artista saprà individuare queste modalità di lavoro e trasferire ad una comunità il valore di queste modalità, è assolutamente plausibile che gli oggetti testimoni di queste modalità vengano venduti e permettano la sussistenza dell’artista.
Ma appunto l’artista deve ripensare completamente se stesso, questo significa ripensare la definizione di opera d’arte e di museo. Io ho iniziato a farlo 16 anni fa quindi non è facilissimo. Bisogna applicarsi, e per questo abbiamo anche creato un Academy e delle Masterclass per aiutare artisti, spettatori attenti, collezionisti e curatori.
VP: Questa tua critica radicale per un periodo ti ha creato isolamento nel mondo dell’arte, ne hai sofferto? Te ne sei accorto?
LR: Ad oggi, anche se sempre meno, questa critica radicale mi ha isolato e mi ha creato una condizione di ostracismo. Vedo questa condizione come una quarantena salutare, un modo per stare lontano da persone e percorsi tossici, come se la mia visione critica radicale mi avesse salvato, sia tenendomi distanti le persone sbagliate, sia uccidendo quello che di sbagliato ero prima.
VP: Questo perché in Italia si è allergici alle critiche?
LR: Per me è sempre colpa della “Nonni Genitori Foundation” che fin da piccoli c’ha fatto credere di essere speciali, fantastici e intoccabili; è un po’ la cultura della famiglia italiana che scivola anche nella cultura mafiosa italiana per cui i miei figli sono i migliori a prescindere. Quando critichi i loro figli, non lo accettano e diventano profondamente nervosi e permalosi, non solo gli artisti ma anche i curatori, i collezionisti e i direttori di museo. Che poi nel campo dell’arte hanno dovuto fare molta fatica per raggiungere piccoli orticelli di potere, quindi non accettano alcun inciampo e alcuna critica ulteriore.
VP: Chi sono i tuoi artisti preferiti a parte le tue interviste, non si capisce quanto vere, a Maurizio Cattelan.
LR: L’intervista a Maurizio Cattelan è assolutamente autentica non potrei diffondere un’intervista senza che fosse reale. Apprezzo alcune cose di moltissimi artisti soprattutto moderni ed emersi negli anni ‘90. Ma anche Sehgal o MSCHF.
VP: Non pensi che l’arte sia come tutto il settore culturale, un settore sgonfiato e parassita, ormai? Tutti oggi possono produrre contenuto e cultura con i social ma non solo.
LR: Senza dubbio, questo è uno dei grandi temi della mia Academy e delle Masterclass. Ci sono, proprio per questo motivo, grandi spazi di manovra. Siamo tutti artefici e vittime di una sovraproduzione di contenuti, una sorta di creatività diffusa che però rischia di soffocare tutto: la nostra capacità di approfondire e di fare esperienza profonda delle cose. Ma proprio per questo c’è tanto da fare e tanto a cui resistere e opporsi. Dammi i miliardi di euro che hanno buttato via su tanti progetti di artisti italiani negli ultimi anni e poi vediamo quello che il progetto di Luca Rossi può fare. Noi da 16 anni lavoriamo praticamente a budget zero in un sistema che ostracizza e che pone solo ostacoli. Un “sistema mafioso” che non ti uccide fisicamente, ma ti uccide professionalmente.
VP: Hai delle soluzioni? In conclusione, c’è una via di fuga, dalla noia, e dall’hobbistica a cui è relegato gran parte di questo mondo?
LR: La soluzione è resistere e sviluppare progetti con quello che hai, se hai limoni fai progetti con i limoni; ma ovviamente bisognerebbe scardinare questo sistema clientelare e mafioso che sottrae risorse e opportunità fondamentali a progetti che potrebbero avere enorme impatto. Nei prossimi appuntamenti in presenza a Roma e Torino cercheremo di fare proprio questo.