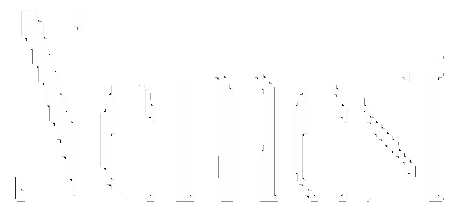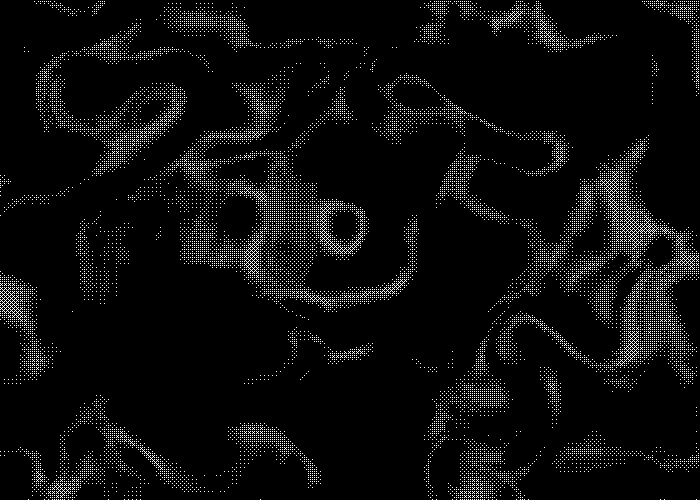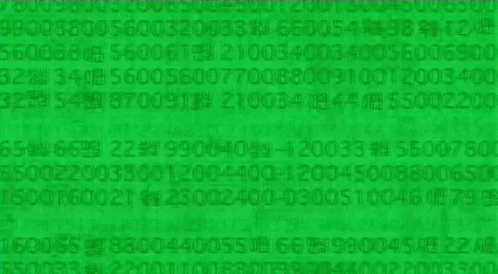Ho sempre creduto che il vero scandalo non sia il peccato, ma l’ipocrisia. Che la vera violenza non sia quella visibile, ma quella che si nasconde nei gesti di chi mente mentre sorride, nei comunicati istituzionali, negli slogan da talk show.
Osservando la ministra Roccella e il ministro Valditara pronunciare con spocchia due parole gravissime — “censura” e “boicottaggio” — ho avuto la sensazione netta di trovarmi di fronte a quella che potremmo definire la pornografia del linguaggio del potere.
Sì, pornografia. Perché è osceno un potere che finge di essere vittima. Una classe dirigente che ruba al dissenso i suoi strumenti semantici per usarli contro chi dissente.
La ministra Roccella, contestata da un gruppo di ragazze e ragazzi, ha parlato di censura. Censura.
Una parola enorme, una parola che ha fatto morire scrittori, esiliare poeti, bruciare giornali. Una parola che puzza di fascismo, di bavagli, di leggi speciali, di fogli strappati. Una parola che — mi si perdoni l’insistenza — non può essere usata da chi governa contro chi protesta. Perché la censura, nella sua struttura ontologica, è verticale, discende dall’alto verso il basso, mai il contrario.
Roccella non è stata censurata. È stata contestata. Le è stato ricordato, con le voci e con i cartelli, che il suo potere non è neutrale, che le sue politiche — in tema di aborto, maternità, donne — non parlano a tutti, ma parlano contro alcuni. Non le è stato impedito di parlare. È stata costretta ad ascoltare.
E questo, nel vocabolario politico, non si chiama censura. Si chiama conflitto.
Il suo vittimismo è un’operazione chirurgica e fredda, ideologica. Serve a delegittimare il dissenso, a dipingerlo come violenza, a ridurre ogni forma di opposizione a un disturbo dell’ordine pubblico. È lo stesso meccanismo che negli anni Settanta definiva gli operai teppisti, le femministe isteriche, i giovani provocatori.
Il potere, oggi, si sente autorizzato a definirsi censurato solo perché non è più abituato ad essere interrotto.
E poi c’è Valditara. Il maestro dell’ordine e della disciplina, l’ultimo baluardo di un’idea di scuola come apparato di controllo. Ha definito “boicottaggio” la scelta di alcuni studenti — pochi, fragili, arrabbiati — di restare in silenzio durante l’orale di maturità.
Ora, boicottare significa agire consapevolmente per colpire un sistema, danneggiarne i meccanismi. Ma qui non c’è organizzazione. Non c’è sabotaggio. Non c’è calcolo. C’è una protesta grezza, disperata, disarmata. Una protesta adolescenziale, forse ingenua, ma onesta.
E invece, il ministro la punisce come si punisce un crimine. Il silenzio, per lui, è provocazione. È inaccettabile. Merita la bocciatura. Ma cos’è, davvero, l’orale della maturità? Un sacramento? Una liturgia dogmatica in cui lo studente deve inginocchiarsi davanti al sistema che lo giudica?
Se un ragazzo sceglie di non parlare, se si rifiuta di partecipare a quella messa secolare, non sta sabotando lo Stato: lo sta interrogando. Sta chiedendo se valga ancora la pena obbedire a un sistema che lo ha formato come esecutore e non come pensatore.
E Valditara, con la severità di un parroco offeso, decide di colpirlo. Di bocciarlo. Di insegnargli che il silenzio non è concesso se non è sottomesso.
Questi due casi, presi insieme, ci raccontano una cosa semplice e terribile: questo governo ha paura del dissenso, soprattutto se viene dai giovani. Non perché sia pericoloso — lo sa bene che non lo è — ma perché è incontrollabile.
Un ministro può negoziare con un sindacato, può reprimere un corteo, può manipolare i giornali. Ma non può zittire una classe che fischia. Non può punire il pensiero che rifiuta di esprimersi.
E allora lo ridicolizza. Lo criminalizza. Lo svuota. Lo definisce censura. Lo definisce boicottaggio.
Perché se un governo chiama “censura” ciò che è protesta, e “boicottaggio” ciò che è disagio, allora non sta più solo esercitando il potere: lo sta sacralizzando. Sta dicendo che è intoccabile, che ogni opposizione è eresia. Che ogni voce che non è in coro è una bestemmia.
Ed è qui, cari lettori, che sta la vera urgenza. Non solo nella politica, non solo nella scuola. Ma nel vocabolario. Perché il primo passo della repressione non è la legge: è la nominazione sbagliata. È l’atto sacrilego di chiamare censura la contestazione, boicottaggio il silenzio.
È così che si chiude lo spazio politico: non impedendo di parlare, ma facendo finta che chi urla sia il carnefice e chi comanda la vittima.
E allora tocca a noi — studenti, cittadini — custodire il significato delle parole, come si custodisce un bene sacro. Non per nostalgia, ma per necessità. Perché se perdiamo il senso delle parole, perdiamo anche la capacità di resistere.
E se c’è una cosa che ci è rimasta da difendere, in questo paese pieno di bugie, è la verità che abita nel linguaggio.