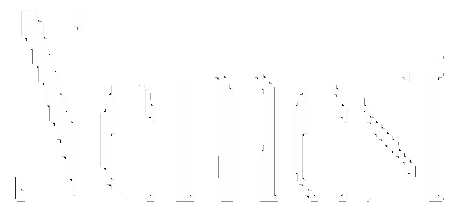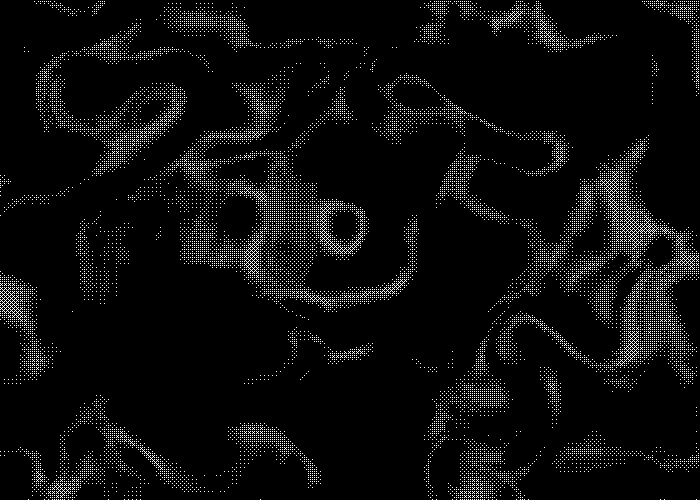In una società industriale che confonde lavoro e produttività, la necessità di produrre è sempre stata antagonista del desiderio di creare. Quale scintilla umana, ossia quale creatività possibile, può restare in un essere strappato dal sonno ogni mattina alle sei, sbattuto sui treni suburbani, assordato dal fracasso delle macchine, torchiato, spremuto dalle cadenze, dai gesti privati di senso, dal controllo statistico, e rigettato alla fine della giornata nelle sale di stazione, cattedrali di partenza per l’inferno delle settimane e l’infimo paradiso dei weekend, quando la folla si comunica nella fatica e nell’abbrutimento?
Dall’adolescenza all’età della pensione, i cicli di ventiquattrore si susseguono con il loro uniforme macinare del vetro spezzato: incrinatura del ritmo congelato, incrinatura del tempo-che-è-denaro, incrinatura della sottomissione ai capi, incrinatura della noia, incrinatura della fatica. Dalla forza viva dilaniata brutalmente alla lacerazione sempre aperta della vecchiaia, la vita barcolla da ogni parte sotto i colpi del lavoro forzato. Mai una civiltà ha raggiunto un tale disprezzo della vita; allevata nel disgusto, mai una generazione ha provato fino a questo punto il gusto rabbioso di vivere. Coloro che si assassina lentamente nei macelli meccanizzati del lavoro sono gli stessi che si trova a discutere, cantare, bere, ballare, fare l’amore, tenere la strada, prendere le armi, inventare una poesia nuova. Già si costituisce il fronte contro il lavoro forzato, già i gesti di rifiuto modellano la coscienza futura. Ogni appello alla produttività, nelle condizioni volute dal capitalismo e dall’economia sovietizzata, è un appello alla schiavitù.
La necessità di produrre trova così facilmente delle giustificazioni che quel parvenu di Fourastié ce ne infarcisce dieci libri senza fatica. Disgraziatamente per i neo-pensatori dell’economismo, queste giustificazioni sono quelle del XIX secolo, di una epoca in cui la miseria delle classi lavoratrici fece del diritto al lavoro il corrispettivo del diritto alla schiavitù, rivendicato all’alba dei tempi dai prigionieri destinati al massacro. Si trattava prima di tutto di non scomparire fisicamente, di sopravvivere. Gli imperativi di produttività sono degli imperativi di sopravvivenza, senonché gli individui vogliono ormai vivere, non solo sopravvivere.
Il tripalium è uno strumento di tortura. Labor significa «pena». Vi è qualche leggerezza nel dimenticare l’origine delle parole «travaglio» e «lavoro». I nobili conservavano almeno la memoria tanto della loro dignità quanto dell’indegnità dei loro schiavi. Il disprezzo aristocratico del lavoro rifletteva il disprezzo del signore per le classi dominate; il lavoro era espiazione alla quale le condannava eternamente il decreto divino che, per impenetrabili ragioni, le aveva volute inferiori. Il lavoro si prescriveva, tra le sanzioni della Provvidenza, come la punizione del povero, e poiché su di essa si reggeva anche la salvezza futura, tale punizione poteva assumere i caratteri della gioia. In fondo, il lavoro importava meno della sottomissione.
La borghesia non domina, sfrutta. Essa sottomette poco, preferisce usare. Come si è potuto non vedere che il principio del lavoro produttivo si sostituiva semplicemente al principio di autorità feudale? Perché non si è voluto comprenderlo?
È forse perché il lavoro migliora le condizioni degli uomini e salva i poveri, illusoriamente almeno, dalla dannazione eterna? Senza dubbio, ma appare oggi evidente che il ricatto del domani migliore subentra silenziosamente al ricatto della salvezza nell’aldilà. Nell’uno come nell’altro caso, il presente è sempre schiacciato sotto il peso dell’oppressione.
È forse perché esso trasforma la natura? Sì, ma che cosa me ne farei di una natura regolata in termini di profitto, in un ordine di cose in cui l’inflazione tecnica serve a coprire la deflazione subita dal senso della vita? Del resto, così come l’atto sessuale non ha per funzione di procreare ma molto accidentalmente genera dei bambini, è per sovrappiù che il lavoro organizzato trasforma la superficie dei continenti, per prolungamento e non per motivazione. Lavorare per trasformare il mondo? Ma via! Il mondo si trasforma nel senso in cui esiste un lavoro forzato; ed è per questo che si trasforma così male.
Si realizzerebbe forse l’uomo nel suo lavoro forzato? Nel XIX secolo, sussisteva ancora nella concezione del lavoro un’infima traccia di creatività. Zola descrive un concorso di chiodaioli nel quale gli operai rivaleggiano in abilità per perfezionare il loro minuscolo capolavoro. L’amore del mestiere e la ricerca di una creatività per quanto ardua permettevano incontestabilmente di sopportare quelle dieci o quindici ore alle quali nessuno avrebbe potuto resistere se non vi si fosse introdotta qualche forma di piacere. Una concezione ancora artigianale nel suo principio lasciava a ciascuno la cura di assicurarsi un qualche precario comfort nell’inferno della fabbrica. Il taylorismo diede il colpo di grazia a una mentalità gelosamente custodita dal capitalismo arcaico. Inutile sperare da un lavoro alla catena foss’anche una parvenza caricaturale di creatività. L’amore del lavoro ben fatto e il gusto della promozione nel lavoro sono oggi il contrassegno indelebile dell’avvilimento e della sottomissione più stupida. Per questo, dovunque si esige la sottomissione, il vecchio peto ideologico prende slancio dall’Arbeit macht frei dei campi di sterminio fino ai discorsi di Henry Ford e di Mao Tse-tung.
Qual è dunque la funzione del lavoro forzato? Il mito del potere esercitato congiuntamente dal capo e da Dio traeva la sua forza di coercizione dall’unità del sistema feudale. Infrangendo il mito unitario, il potere parcellare della borghesia inaugura, sotto l’insegna della crisi, il regno delle ideologie, che mai potranno raggiungere, né da sole né insieme, un quarto dell’efficacia del mito. La dittatura del lavoro produttivo giunge opportunamente a prenderne le consegne. La sua missione è di indebolire biologicamente il più gran numero di uomini, di castrarli collettivamente e di abbrutirli al punto da renderli ricettivi alle ideologie meno pregnanti e meno forti, alle più senili ideologie nella storia della menzogna.
Il proletariato dell’inizio del XIX secolo conta una maggioranza di minorati fisici, di uomini sfibrati dalla tortura sistematica dell’officina. Le rivolte vengono dai piccoli artigiani, dalle categorie privilegiate o dai disoccupati, non dagli operai massacrati da quindici ore di fatica. Non è inquietante constatare che l’alleggerimento del numero delle ore lavorative interviene nel momento in cui lo spettacolo di diverse varietà ideologiche messo a punto dalla società di consumo sembra essere tale da rimpiazzare efficacemente i miti feudali abbattuti dalla giovane borghesia? (Della gente ha veramente lavorato per un frigorifero, per un’automobile, per un televisore. Molti continuano a farlo, «invitati» come sono a consumare la passività e il tempo vuoto che la «necessità» di produrre «offre» loro).
Statistiche pubblicate nel 1938 indicano che mettendo in opera le tecniche di produzione contemporanee, la durata delle prestazioni necessarie si sarebbe ridotta a tre ore al giorno. I conti non tornano non solo rispetto alle nostre sette ore di lavoro, ma anche perché dopo aver logorato intere generazioni di lavoratori promettendogli il benessere che oggi vende loro a credito, la borghesia (e la sua versione sovietizzata) prosegue la distruzione dell’uomo al di fuori del lavoro. Domani renderà appetibili le cinque ore richieste di usura quotidiana con un tempo dedicato alla creatività aumentato proporzionalmente dall’impossibilità di creare realmente (la famosa organizzazione degli svaghi).
Si è scritto giustamente: «La Cina deve affrontare dei problemi economici giganteschi; la produttività è per essa una questione di vita o di morte». Nessuno si sogna di negarlo. Ciò che mi sembra grave non riguarda gli imperativi economici, ma il modo di assolverli. L’Armata Rossa del 1917 costituiva un tipo nuovo di organizzazione. L’Armata Rossa del 1960 è un esercito come se ne trovano nei paesi capitalisti. Gli avvenimenti hanno provato che la sua efficacia restava molto al di sotto delle possibilità delle milizie rivoluzionarie. Allo stesso modo, l’economia cinese pianificata, rifiutando di accordare a dei gruppi federati l’organizzazione autonoma del loro lavoro, si condanna a raggiungere una forma di capitalismo perfezionato, chiamato socialismo.
Ci si è presi la briga di studiare le modalità del lavoro presso i popoli primitivi, l’importanza del gioco e della creatività, l’incredibile rendimento ottenuto con dei metodi che l’apporto delle tecniche moderne renderebbe cento volte più efficaci? Non sembra. Ogni appello alla produttività viene dall’alto. Senonché solo la creatività è spontaneamente ricca. Non è dalla produttività che bisogna attendersi una vita ricca, non è nella produttività che bisogna riporre la speranza di una risposta collettiva ed entusiasta alla domanda economica. Ma che dire di più quando è noto con quale culto viene onorato il lavoro a Cuba come in Cina, e con quale facilità le pagine virtuose di Guizot potrebbero ormai passare in un discorso del 1° maggio?
Via via che l’automazione e la cibernetica lasciano prevedere la sostituzione massiccia dei lavoratori con degli schiavi meccanici, il lavoro forzato mostra di rientrare semplicemente nei procedimenti barbarici di mantenimento dell’ordine. Il potere fabbrica così la dose di fatica necessaria all’assimilazione passiva dei suoi diktat televisivi. Per quale esca lavorare ancora? L’inganno è evidente; non c’è più niente da perdere, nemmeno un’illusione. L’organizzazione del lavoro e l’organizzazione del tempo libero e degli svaghi: le due lame delle forbici della castrazione, per migliorare la razza dei cani sottomessi. Si potrà un giorno vedere i lavoratori in sciopero, rivendicando l’automazione e la settimana di dieci ore, scegliere, per aprire le ostilità, di far l’amore nelle fabbriche, negli uffici e nelle case della cultura? Non ci sarebbero che i burocrati, i manager, i dirigenti sindacali e i sociologi a stupirsene e a preoccuparsene. A ragione forse. Dopo tutto, ne va della loro pelle.