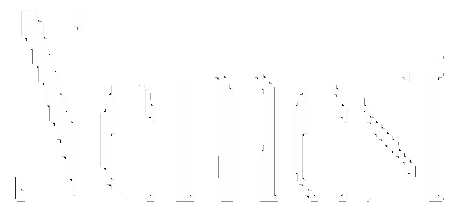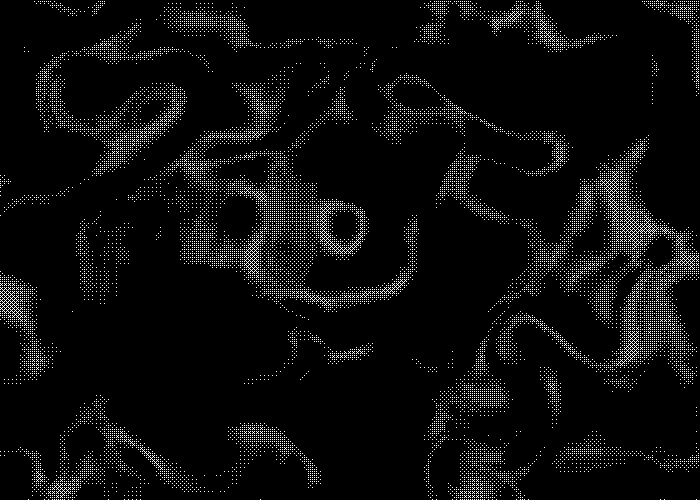Paura per la brevità
di cui ogni momento si dipinge
vagare senza casa né luogo
nel mare presagio
di abbandonare
l’ansia che tutto vada a perdersi
al di là di quanto amai
volersi
e poi riprendersi.
L’individuo alla deriva ha un rapporto frammentario con la memoria dei propri luoghi: la sua stessa memoria è un insieme di frammenti. L’individuo alla deriva non ha rapporti con nessuna tradizione in particolare, né dialetto, né usanza: la migrazione lo ha condotto allo smarrimento. Nel caso in cui fosse costretto a viaggiare (e non lo facesse quindi per flânerie) o a trasferirsi per lunghi periodi, sarebbe al contempo costretto ad abbandonare delle usanze per acquisirne delle altre. Ma il vero individuo alla deriva mescola le due tradizioni, la vecchia con la nuova, in un pastiche culturale che lo rende unico. Questo individuo odia l’omologazione culturale; non s’interessa né del paese, né del comune, né della città, né della regione, né della nazione: non appartiene a niente ma appartiene a tutto. Per questo può attraversare crisi esistenziali come provare sensazioni di libertà e gioia. L’individuo alla deriva è destinato a “perdersi”. Ha però l’opportunità (e il diritto) di riprendersi.
Dalla flânerie baudelairiana alla deriva situazionista, il vagare e il perdersi nello spazio urbano sono diventati col tempo un’arte. L’arte del perdersi e del ritrovarsi. Ma poco si parla del “perdersi” in senso più ampio e non solamente legato a quelle strade di quelle città.
La periferia è il luogo comunemente riconosciuto “della perdita”; mentre il centro è il luogo tipicamente riconosciuto “del ritrovo”. “Centro” e “periferia” possono ambire a una grande polisemia.
“Centro” solitamente è visto come luogo di apparizione, caotico, sociale e per nulla intimo; è luogo di rigore, di ordine, di controllo indiretto, di potere…
“Periferia” è invece visto come luogo di indecisione, d’incertezza, di perdita, di degrado, antisociale; luogo di repressione diretta, ma al contempo di grandi libertà…
Perciò, l’unione delle due definisce un equilibrio che potremmo definire, per ora, “sano”. Su un piano prettamente geografico e urbanistico, infatti, è risaputo che vivere non esattamente in centro e non esattamente nella periferia di una città o di una regione, ovvero in una via di mezzo fra l’uno e l’altra, è la soluzione più “equilibrata” e socialmente accettata.
Centro e periferia – sempre su un piano geografico e urbanistico – sono appunto costruiti con due scopi diversi. Il centro è usato come concentramento dei flussi provenienti dalle periferie (e dal centro stesso); come concentramento – s’è detto – delle masse nella piazza pubblica. La periferia è usata invece come scioglimento delle masse: senza il “centro”, le masse sarebbero sciolte e basta.
Andando oltre un senso propriamente “cittadino” (e quindi urbanistico), per passare ad una significazione di “centro” e “periferia” come spazi del mondo esterno o interno, si potrebbe dire che una sintesi di “centro” come luogo di accoglienza e controllo, e di “periferia” come luogo di turbamento e smistamento, rappresenti l’equilibrio psicofisico dell’individuo moderno.
Ma anche “centro” come luogo simulacro di tradizione – e, di fatto, luogo di concentrazione del capitalismo – e “periferia” come tradizione effettiva, meglio radicata e più autentica.
Quello che avviene poi all’interno di questi due luoghi è altrettanto significativo (e spesso determinante per le scelte di vita degli individui). Tralasciando ogni stereotipo, molto spesso il centro funge da espositore, mentre la periferia è produzione. Nel centro, ad esempio, la tradizione viene esposta, cristallizzata. Nella periferia la tradizione è integrata.
È ugualmente interessante rintracciare gli spostamenti e i dialoghi che avvengono fra questi due luoghi. Spesso accade che la periferia migri verso il centro con l’obiettivo di giungere a un’esposizione, pur criticando sovente il centro (sul perché la periferia entri in conflitto con il centro è bene non entrare ora nel merito, poiché solo per questo tema servirebbe un discorso interamente dedicato. Basterà ribadire alcune caratteristiche già dette: il centro delle volte perde l’autenticità che contraddistingue la periferia. Nonostante ciò, è notevolmente più in mostra di quest’ultima. La periferia rivendica la sua autenticità e accusa il centro di superficialità, ma delle volte con torto: il centro è anche luogo di accoglienza e per tale ragione contenitore di una pluralità di visioni). È vero anche che la periferia, proprio perché meno esposta e più autentica, ha il vantaggio di poter sviluppare delle proprie elaborazioni a volte significativamente più importanti di quelle dei modelli centrali. Nei casi in cui è invece il centro ad insinuarsi nella periferia (caso ben più raro, a mio avviso), lo fa per decentrarsi, per ritirarsi o – nei casi più “moralisti” – lo fa per una sorta di mea culpa. Ma avviene anche che il centro s’introduca nella periferia con l’intento di colonizzarla.
Ecco che l’individuo alla deriva si accorge di queste variazioni, o quantomeno ne fa esperienza. Se questo individuo si trova geograficamente situato in un centro, non avrà modo di vivere la periferia, e viceversa. Eppure, vivere in piena periferia non è necessariamente indice di squilibrio e così nel pieno centro (l’equilibrio “sano” di cui sopra è in realtà un vezzo borghese, una scelta sociale).
Essere invece manchevoli di un centro o di una periferia in termini più ampi significa perdersi. Dunque essere manchevoli di un centro come punto nevralgico di snodi periferici, significa essere carenti di un riferimento importante, geograficamente o interiormente situato. Così come essere manchevoli della periferia come luogo di tradizione effettiva o anche di rapporto memoriale con lo spazio, significa essere carenti di un altro tipo di sicurezza e riferimento.
Entrambi sono fondamentali per determinare l’identità dell’individuo.
E si ritorna al vagare e al perdersi. Nella migrazione geografica, ad esempio, si arriva a perdere quell’equilibrio tra centro e periferia, per cui si perde il contatto con il luogo in cui si vive, con la tradizione, con un’eventuale “memoria”.
Perdersi e finire per decidere di continuare a farlo. Questa è una soluzione.
Vi sarebbero vari motivi per cui conviene abbracciare questa filosofia (che peraltro è adattabile, se non si fosse capito, anche a chi vive sempre nel medesimo luogo). Certo, va riconosciuto che percepirsi come radicati in uno spazio (pur essendo liberi di spostarsi e di perdersi) è appagante; sentirsi in qualche modo rappresentati, rappresentanti o cose simili…
Tuttavia, qui l’idea del perdersi sposa anche un’idea di categorica non-appartenenza ad alcuna società (quando, nel vagare perpetuo per l’Italia, m’accorgo addirittura di sentirmi italiano, è festa), se non a quella del (de)genere umano, che vive nel mondo intero e non solamente in queste o quelle città/regioni/nazioni.
Ma questo non vuole essere un attacco al provincialismo e al campanilismo, nossignore (forse, al massimo, al patriottismo, che già è diverso). Piuttosto, una lode a quel senso di smarrimento, a cui segue il desiderio di fuga, che è risaputo essere parte del carattere di molte persone.
Quel desiderio di perdersi e non ritrovarsi. O di ritrovarsi solamente per continuare, come in una giostra infinita, a riperdersi.
I punti di riferimento allora finiscono per essere molteplici. Non uno, non una sola “campana” alla quale enunciare il proprio servilismo da cittadino.
Nel vagare e nel perdersi, di centri e periferie ne esistono a migliaia. Ogni piazza può essere il centro; ogni vicolo periferia.
La necessità di trovare un equilibrio finisce in realtà per permettere all’individuo alla deriva di espandersi e conoscere una realtà più ampia.