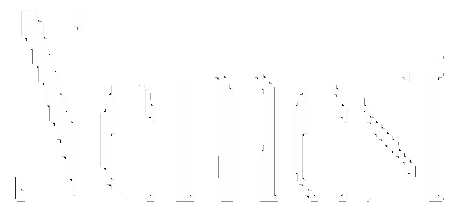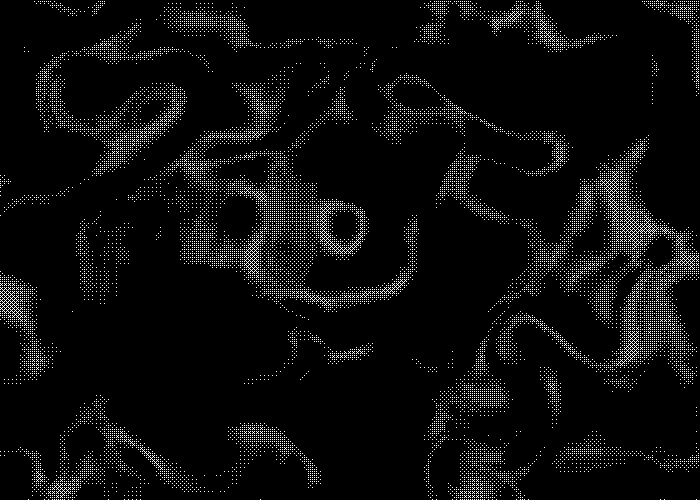1.
In un mondo editoriale basato sull’iper-visibilità, dove ogni libro viene raccontato prima ancora di essere letto, dove ogni cosa viene riassunta in tre aggettivi (che sono sempre gli stessi utilizzati per il “libro-caso-dell’anno” dell’anno precedente) Geminga sceglie il silenzio, l’anonimato, il buio. Tu come hai vissuto la libertà (e forse il rischio) di lavorare senza etichette, trame, fascette, senza neanche sinossi e quarte di copertina?
Enrico Ferratini:
L’ho vissuta con sentimento ambivalente. Da una parte temevo che fosse una formula troppo “estrema” e che (facendo un discorso terra-terra) rischiasse di auto-sabotarsi da sola, di allontanare troppi potenziali lettori. Scommettere sull'”irragionevolezza” delle persone anziché sul loro buonsenso (perché questo di fatto fa Geminga) mi sembrava un’operazione bella dal punto di vista concettuale, ma troppo azzardata sul piano pratico. Eppure c’era qualcosa che mi risuonava profondamente in questa formula, e che ho messo bene a fuoco solo dopo aver cominciato a lavorarci. Ed è che, con questa idea della collana invisibile, si va a recuperare una dimensione “magica”, “sacrale” di un testo scritto. Ricevere a casa un libro misterioso, di cui non si sa nulla, in una busta d’argento, scevro di tutte quelle cose che richiamano la realtà pratica dell’oggetto-libro (il suo essere, banalmente, merce: l’avere un codice isbn, un prezzo in copertina, ecc.), sono tutte cose che vanno a creare una specie di “aura” attorno ai testi, che consente poi ai lettori di predisporsi a leggerli con un grado di attenzione particolare. Questo secondo me è fondamentale, perché il nostro rapporto con la letteratura (lasciami dire: il futuro della letteratura) si gioca tutto qui. Oggi siamo talmente assuefatti dalla vertiginosa quantità di testi che ci circondano, che stiamo perdendo la capacità di dare “spazio mentale” a ciò che leggiamo. Ma la letteratura non è altro che questo, e l’editoria di oggi, io credo, dovrebbe innanzitutto trovare delle formule per preservare, anche attraverso operazioni folli come Geminga, questo spazio mentale in pericolo. La qualità letteraria di un testo, di per sé, non basta. È inutile avere nelle nostre Feltrinelli scaffali pieni di romanzi di Dostoevskij e Balzac se non siamo più davvero in grado di trarre nutrimento da quelle pagine. La letteratura non si salverà così. Si salverà se sapremo ritrovare una connessione mentale profonda con il linguaggio scritto: che noi diamo per scontato, ma non dobbiamo dimenticarci che esso è davvero, nella sua essenza, un’antica forma di magia. Non guardarmi così: una combinazione di segni in grado di far viaggiare una parola attraverso i secoli e i millenni, da una parte all’altra del mondo, come la vuoi chiamare se non magia? Ecco, nel dare forma a questi volumi sto cercando di tenere innanzitutto questo come concetto guida. Chi ha già letto i primi due sa di cosa parlo.
2.
Lavorando su questa collana invisibile, anche tu hai scelto di stare al buio. Eppure per questa edizione hai selezionato testi che definisci “luminosi”. Che cosa significa per te la luminosità in uno scritto?
EF:
Io direi che da una parte questa “luminosità” di cui parli ha effettivamente a che vedere con delle sensazioni precise che mi trasmettono i testi che ho scelto: una specie di distaccata serenità, un piacere sensuale per la bella scrittura, un certo gusto per la trasfigurazione, il sogno, il simbolo, per le immagini leggere che riescono a connetterci nel profondo con un “altro io”, lontano da quello contingente alle nostre emozioni del momento. Ma c’è anche un’altra questione, che ha più a che vedere con il rapporto fra questa collezione di testi e l’atmosfera culturale in cui si inserisce. Ogni iniziativa culturale d’oggi sembra dover per forza rifarsi a qualche tema politico o sociale per legittimare la sua esistenza. Cosa che di per sé non sarebbe un male, se non fosse che vi è una totale assenza di alternative a questa specie di obbligatorio “impegno” nel fare cultura. Ora, io ho un’istintiva avversione verso qualsiasi forma di omologazione, anche quelle apparentemente più innocue: a spaventarmi è sempre la mancanza di varietà nelle cose, e credo che, banalmente, ci sia sempre bisogno di quello che non c’è. Allora mi pare che non ci sia oggi in Italia, soprattutto fra le spinte più giovanili, un approccio alle arti e alla letteratura che sia (passami il termine) puramente estetico-edonistico e non politico. Potrei spingermi oltre e dire che questa onnipresenza di riferimenti politici nei contenuti culturali che proponiamo è mossa sotto sotto dalla necessità diffusa di sentirsi la coscienza a posto dal punto di vista civico, cosa che va di pari passo con una progressiva rinuncia a una vera e propria azione politica (e con azione politica intendo: qualcosa che comporti davvero, per chi la attua, l’andare incontro a serie rinunce, pericoli e sfide). Insomma questo per dire che con Geminga ho voluto consapevolmente voltare le spalle a tutto questo, offrire ai lettori un piccolo spazio in cui poter spostare lo sguardo su altro. Dimenticarsi, per il breve momento della lettura, di tutto ciò che pertiene il presente, e trovare un contatto con altri mondi, altre dimensioni, con un’altra parte di sé: per me la luminosità di un testo sta anche in questo.
3.
Hai seguito un itinerario preciso, una mappa mentale, o ti sei lasciato guidare da un’idea più grande, un’intuizione, qualcosa che sfugge ai generi e alle classificazioni? Il tuo è un mosaico dove ogni tessera è slegata da quella precedente, ma facendo un passo indietro il senso appare nitido e chiaro. Insomma: come hai selezionato i testi?
EF:
Eh, anche qui devo darti due risposte. (Le buone domande richiedono sempre almeno due risposte: si vede che sei un bravo intervistatore). Il primo criterio di selezione, il più ovvio, quello che avete anche comunicato al pubblico, è la rarità. Tutti i testi che ho scelto sono, in un qualche modo, testi absconditi, nascosti. Del resto, che motivo avrebbe un lettore di abbonarsi alla cieca a questa collana, se non sapesse che in essa troverà dei testi che non conosce e che difficilmente potrà reperire altrove? Quindi, il senso complessivo di questo percorso si potrebbe riassumere con questa formula: frammenti di bellezza che rischiano di venire dimenticati. Va aggiunto che, nella scelta, anche per garantire una maggiore varietà interna, ho voluto dare un’accezione di volta in volta diversa al concetto di “nascosto”: in certi casi presento testi effettivamente mai tradotti in Italia; in altri, testi non più ristampati da molti anni; qualche volta riesumo grandi pagine di autori famosi (come Kafka, o Wilde, o Hofmannsthal) che, per un motivo o per l’altro, sono diventate quasi irreperibili. Altre volte presento passi da opere cinesi, persiane, indiane e via dicendo, che, nonostante la loro importanza nelle rispettive letterature, sono pressoché sconosciute in Italia. Eccetera. L’altro criterio di selezione è più complesso, e ha a che fare con quel misterioso senso d’insieme che tu hai individuato. Prima di trovare voi di Gog, ho proposto questa idea di collana a diversi altri editori, e l’obiezione che mi si faceva sempre era: «Ma quindi qual è il tema? Cosa lega insieme questi testi?». E io mi trovavo in imbarazzo, perché la vera risposta era che, nel dare forma a questo mosaico, io volevo seguire lo stesso tipo di processo creativo con cui si realizza un’opera d’arte: non voglio interrogarmi troppo sul perché un certo passo di Kalidasa sta bene nello stesso volume con un altro passo di Maria di Francia, o perché è bello che il primo volume si apra con una meditazione sulla morte e si chiuda con delle fluttuanti poesie cinesi sul paesaggio e l’amicizia. Io fin dall’inizio ero sicuro che, seguendo soltanto un criterio estetico e fidandomi del mio istinto, avrei creato un insieme unitario e armonico. Lo stesso vale per il rapporto fra i testi e le immagini che li aprono e li chiudono, come dei “mostri sulla soglia” fra un mondo e l’altro: il legame c’è, si sente, ma lo si coglie a livello intuitivo. Non è un criterio editoriale questo, lo so. Per questo è una follia, per questo è una collana unica nel suo genere.
4.
Qual è secondo te la “funzione” di questa serie di Geminga? Voglio dire, il senso profondo di questa operazione, in rapporto al mondo in cui ci troviamo? Insomma, cosa ti ha spinto in partenza a voler creare questi libri? Solo il piacere di condividere testi che ti piacciono? O c’è da parte tua un’urgenza diversa?
EF:
Allora. Diciamo che alla base di questi libri c’è da parte mia la sensazione che, senza accorgercene, ci troviamo in un mondo che sta progressivamente rimuovendo la memoria della letteratura. Geminga è, da questo punto di vista, una collana malinconica e disperata, perché, piccola com’è, vuole andare contro un processo che è, io temo, irreversibile. Che io sappia sono l’unico ad avvertire questo pericolo. Molti altri intellettuali lamentano, già da decenni, un sistema editoriale che sta creando una “selezione sbagliata” nella narrativa contemporanea, filtrando sistematicamente opere poco meritevoli e condannando altre di maggior valore all’oblio. Questo fenomeno è noto, ma si tende in tutto ciò a considerare la grande letteratura del passato salva per definizione, archiviata al sicuro nella memoria collettiva. Per me non è così. Il pericolo più grave che io vedo è anzi che stiamo dando il via a una progressiva rimozione delle opere del passato. Anche qui, si tratta spesso del risultato di una vera e propria “selezione sbagliata”. Il nostro cattivo gusto si riflette nella scelta di quelle opere del passato che stiamo tramandando a discapito di altre. Pensa alla poesia: ormai in tutte le librerie i poeti che si trovano più facilmente sono quelli da Baci perugina, da scuole elementari, che scrivono frasette edificanti e univoche sul senso della vita, buone per le storie di Instagram: Merini, Hikmet, Neruda, Kavafis… questi ormai sono stati fatti diventare il nuovo “canone” poetico, e diffondono un’idea di poesia per me assolutamente sbagliata, immatura, adolescenziale. Fuori da questo piccolo cerchio, il resto sta diventando quasi introvabile (salvo, certo, il canone propriamente scolastico: Dante, Petrarca ecc. per ora sono salvi). Tendiamo a pensare che la qualità nell’arte si selezioni da sola, come per un processo automatico della storia, una scrematura che avviene secondo una spontanea, miracolosa giustizia artistica. Ma non è così. Siamo noi che selezioniamo le cose che verranno ricordate. Ora, se nei secoli passati (dal Rinascimento al Novecento, diciamo), pur con tutte le inevitabili lacune del caso, l’arte e la letteratura che sono state tramandate sono effettivamente di grande valore, questo si deve soprattutto al fatto che in Europa le classi più ricche ed educate (le più “colte”, quindi) hanno coltivato un attento studio delle discipline artistiche, hanno perseguito la ricerca di un gusto, portando avanti una riflessione incessante sulla natura del “bello artistico”. Ora tutto questo è stato spazzato via nel giro di pochi decenni: per almeno due ragioni secondo me, molto complesse e di cui sicuramente non possiamo parlare oggi. A questo aggiungi che le nuove generazioni hanno sempre meno tempo, e soprattutto, com’è noto, meno attitudine a leggere testi complessi: quindi anche i pochi romanzi che costituiscono il canone dei “classici” dell’Ottocento e del Novecento, nel giro di poco tempo diverranno praticamente introvabili, per il semplice fatto che non li comprerà nessuno: verranno studiati solo da pochi accademici, come avviene oggi per i poemi eroicomici del Cinquecento. Ma non faranno più parte del sapere condiviso. La memoria della letteratura si ridurrà sempre di più, sopravvivrà ben poco di ciò che oggi, con una retorica alquanto vuota, consideriamo “immortale”. In questo quadro, Geminga vuole puntare la sua lucina su splendide pagine dimenticate, o che sono sulla via per esserlo, e al contempo suggerire dei modi nuovi per accostarsi alla letteratura… anche allargando le definizioni di “testo letterario”, e proponendo un approccio all’atto stesso della lettura non convenzionale.