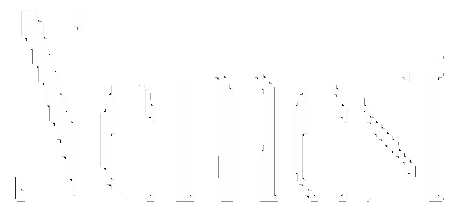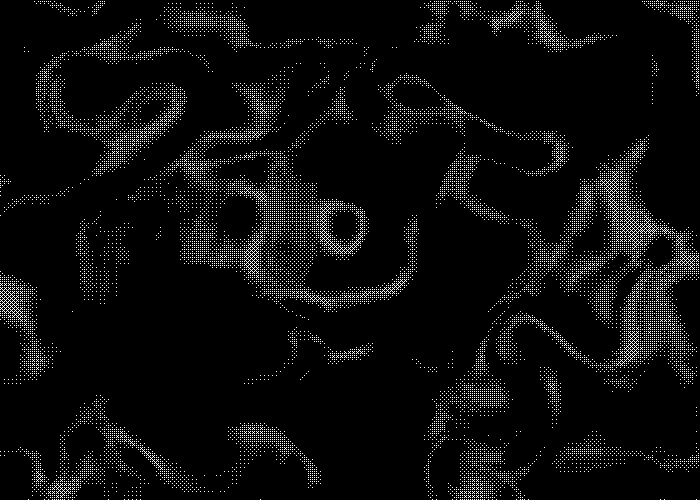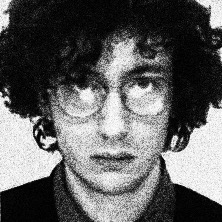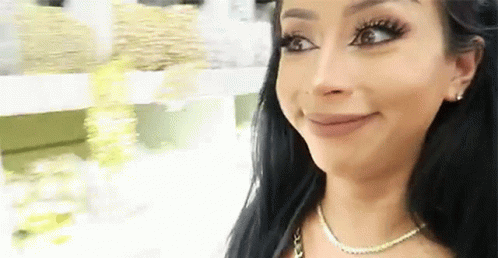Apro Instagram. Una ragazza bionda racconta la fatica di crescere un figlio da sola mentre beve un cappuccino fatto in casa e condivide consigli per non sentirsi una madre inadeguata. Chiara Ferragni si proclama World’s Best Sottona e regina del Club degli Illusi dopo il divorzio con Fedez e la bufera mediatica causata dalla scoperchiatura del vaso di Pandori. Una donna americana piange in macchina mentre trasporta le ceneri del suo giovane marito defunto. Un uomo con una polo blu e un piccolo microfono attaccato al colletto racconta che, grazie alle sponsorizzate, il suo business cresce da solo e riesce finalmente a passare del tempo con i suoi figli.
Un brivido si propaga dalla pancia fino alla pelle, sottile ma insistente. Sento puzza di marcio, ma mi colpevolizzo. Hanno sofferto, si stanno mostrando nella loro vulnerabilità, come posso essere così insensibile? Eppure, aumenta in me il bisogno di allontanarmi veloce, velocissimo. Smetto di seguire, chiudo tutto. Cosa sta succedendo?
Viviamo in un’epoca in cui sembra essere “Tutta colpa di Freud”. Ci hanno addirittura fatto una serie TV e una canzone. Soffriamo? Abbiamo sicuramente avuto un trauma, parola greca che deriva dal verbo greco τραῦμα, che significa “danneggiare”, “ledere”, “rovinare”. Non è colpa nostra, qualcosa o qualcuno ci ha danneggiato, ma la bella notizia è che possiamo trasformare la nostra ferita nella nostra più grande forza. Questa è la narrazione, oggi. Ce lo dicono i terapeuti, gli algoritmi e persino Kelly Clarkson con “What doesn’t kill you makes you stronger”. Poi Tiziano Ferro l’ha messa in versione pop con il suo “Se non uccide fortifica”.
La vulnerabilità è diventata un linguaggio e, come ogni linguaggio, ha le sue regole: ti puoi mostrare fragile, ma solo se hai una visione, puoi piangere in pubblico se serve ad attirare consensi, puoi raccontare i tuoi fallimenti, solo se aumentano il fatturato.
Online, il trauma non è più solo un’esperienza intima, da proteggere e di cui prendersi cura, ma è una nicchia di mercato. Bisogna parlare alle persone che hanno lo stesso trauma per aiutarle e convincerle che sì, siamo proprio noi la soluzione che stanno cercando. Allora c’è chi racconta le proprie ferite senza filtri, chi costruisce un podcast, chi un videocorso da guardare mentre il figlio è a lezione di nuoto.
È il capitalismo terapeutico: soffro, dunque monetizzo. Un tempo si diceva “Trasforma il dolore in arte”, oggi basta trasformarlo in contenuto, possibilmente con un titolo che attiva corde emotive e qualche centinaio di euro di sponsorizzata.
Il trauma, in questo contesto, non è più ciò che ti accade, ma ciò che ti definisce.
Diventa un marchio, un posizionamento, un modo per sentirsi speciali. Non sei solo una persona ansiosa: sei una persona ansiosa capace di raccontare l’ansia. Hai avuto un burnout? Ottimo, adesso puoi insegnare agli altri a evitarlo. La narrazione della ferita funziona perché rassicura. Perché ci fa sentire tutti un po’ disagiati, ma insieme, guidati da anime affini che ci capiscono, che sentono il nostro trauma e a cui siamo felici di dare i nostri soldi.
E così, tra una seduta di psicoterapia e un reel motivazionale, impariamo a performare il dolore con grazia, a monetizzare il trauma con leggerezza, a raccontare la vulnerabilità come fosse una competenza trasversale. Il risultato? Siamo tutti imprenditori del nostro trauma, testimonial di un dolore che non deve più far male, deve solo fatturare.
A questo punto la domanda sorge spontanea: “Ma allora online è tutto finto?” No. O almeno, non sempre. Ci sono anche persone come Bianca Balti che torna sui social dopo tre mesi di silenzio per parlare di depressione post-cancro, senza però identificarsi in essa, con pudore, senza retorica e con la grazia ruvida di chi non deve dimostrare niente. Il problema non è la vulnerabilità in sé, ma la sua gestione in pubblico. C’è chi condivide una vulnerabilità strategica, con un secondo fine, ma c’è anche chi riesce davvero a trasformare il proprio dolore in arte, in storie che fanno riflettere, sorridere o entrambe le cose. La differenza è sottile, ma si sente, come quando metti il dolcificante nel caffè al posto dello zucchero.
Un contenuto autentico non chiede di essere compreso, non cerca like né empatia: esiste e basta. È quello che ti lascia qualcosa anche senza spiegare nulla, senza dare soluzioni, senza CTA a scaricare l’ennesima guida gratuita su come essere un padre presente. È un contenuto intenso, ma silenzioso, in cui il dolore c’è, ma non è sbandierato per suscitare reazioni. L’autenticità, quando è reale, non ha l’urgenza di piacere, né paura di non piacere. La vulnerabilità strategica, invece, se esasperata, può portare una donna che ha ucciso suo marito a pubblicare un libro per bambini su come superare il lutto del padre. Capite cosa intendo? È agghiacciante.
Imparare a distinguere è un atto politico. Abitare gli spazi online significa accettare che ci siano più livelli di verità, che non tutto è manipolazione, ma nemmeno tutto è confessione. Significa fermarsi prima di condividere, o prima di empatizzare, e chiedersi: “Perché lo sto dicendo? Cosa spero di ottenere? Che sensazione suscita in me quello che sto leggendo/vedendo? È zucchero o è dolcificante?” Insomma, si sente. Forse la vera autenticità non è solo raccontarsi, ma stare nelle domande scomode senza la pretesa di avere (e dare) sempre una soluzione monetizzabile. Imparare a dimorare nel silenzio, prima di trasformare tutto in messaggio, storia o contenuto.
Certo, in qualche modo dobbiamo pur mangiare e se la nostra vulnerabilità funziona, perché non parlarne? Non c’è niente di male nel voler trasformare il dolore in qualcosa di utile. D’altronde, la società in cui viviamo ce lo chiede continuamente. Forse la soluzione non c’è. Bisogna solo farsi domande, ogni volta, prima di parlare o di ascoltare. Seguire un po’ di più le proprie urgenze e un po’ meno le strategie. Condividere non per convertire, ma per capire. E imparare ad ascoltare quella sensazione di pancia che arriva mentre leggiamo, guardiamo, scorriamo.
Perché, se ci fermiamo un attimo, la pancia sa sempre la verità: quando è zucchero, quando è dolcificante, quando è marcio.