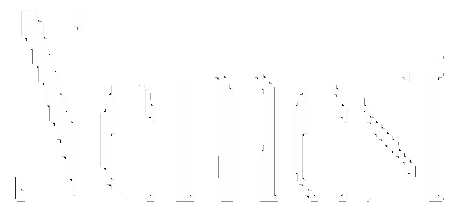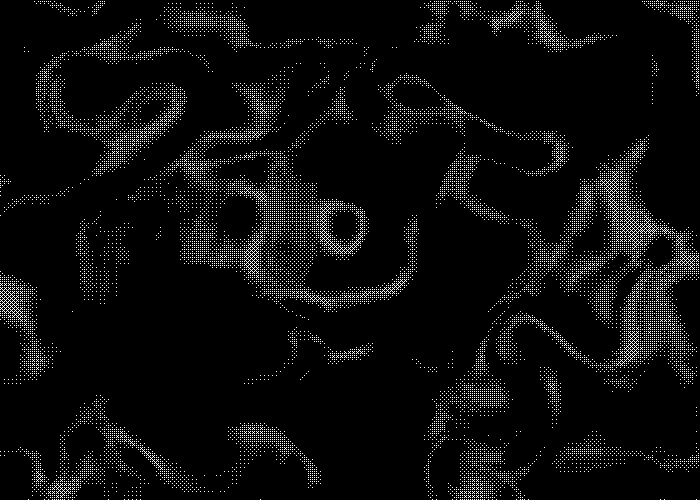In La Caduta, Albert Camus descrive i canali concentrici di Amsterdam come i gironi danteschi. Più ti avvicini al centro più scendi verso gli inferi luciferini. Io, se all’inferno piovesse così tanto, smetterei di dire la parola “dio” invano o a trastullarmi sul divano. Amsterdam; sesso droga e rock and roll, gli anni ’70, la liberazione sessuale, Anna Frank, la libera droga il libero stato. Amsterdam; la Venezia del Nord, la Gerusalemme Europea, la Nuova Londra, la Piccola San Pietroburgo, Amsterdam per me provinciale, Comacchio in maggiore.
In ogni caso,
un acquitrino.
“Perché siamo al fondo, ha notato che i canali concentrici di Amsterdam assomigliano ai gironi dell’inferno? L’inferno borghese, naturalmente, popolato di brutti sogni.”
(Albert Camus)
Se al liceo hai fatto una scuola internazionale. Se possiedi un International Baccalaureate. Se sei cresciuto a Doha. Se in quarta hai fatto l’anno all’estero. La Scuola Steineriana. Se hai fatto il College in Inghilterra e sei uscita di casa a 16 anni, per tua scelta… Se tua madre è Stefania nella Grande Bellezza. Se sei Tommaso in Ovosodo. Se ti piacciono le cannette, ma non così tanto da andare a pinzare da Faruk, tuo amico d’infanzia che vende il fumo sempre nello stesso cespuglio da quando avevate quindic’anni. Un giorno ti sveglierai e avrai voglia di andar da qualche parte, per fare un esempio: in Olanda.
Io, tondelliano e figlio del gran troiaio, triangolo delle Bermuda Bologna-Modena-Ferrara, sulla mia ronzinante Fiat Qubo a metano imboccato l’autobahn più meravigliosa che c’è parto verso il nord, destinazione Amsterdam: triennale in Analisi Letteraria e Culturale, chi mi fermerà più?
“Correggio sta a cinque chilometri dall’inizio dell’Autobrennero di Carpi, Modena che è l’autobahn più meravigliosa che c’è perché se ti metti lassù e hai soldi e tempo in una giornata intera e anche meno esci sul Mare del Nord, diciamo Amsterdam, tutto senza fare una sola curva. Entri a Carpi ed esci lassù. Sono sulla strada amico, son partito, ho il mio odore a litri nei polmoni, ho fra i denti la salsedine aaghhh e in testa libertà. Sono partito, al massimo lancio il motore, avanti avanti attraversare il Po, dentro ai tunnel tra le montagne di Verona, avanti sfila Trento sulla destra e poi Bolzano e poi al Brennero niente frontiere per carità, non mi fermo non mi fermo, verso Innsbruck forte forte poi a Ulm, poi via Stuttgart e Karlsruhe e Mannheim, una collina dietro l’altra, da un su e giù all’altro, spicca il volo macchina mia, vola vola, Frankfurt, Köln, forza eddai ronzino mio, ormai ci siamo, fuori Arnhem, fuori Utrecht, ci siamo ci siamo ostia se ci siamo senti il mare? Amsterdam Amsterdam! Son partito chi mi fermerà più? […]”
(Tondelli)
Avevo letto del Tondelli di “Altri Libertini”, al Vondelpark, degli anni ’70. Che s’accendevano i fuochi, si dormiva all’agghiaccio, con le pere e la maria e i trip savanici. Poi di quello di “Camere Separate” negli anni ’80, del non c’è più nessuno al Vondelpark, solo i gruppi per la protezione degli uccelli del parco. Niente musica, droga, fuochi o sacco a pelo. Gli anni ’70 sono tramontati, e il grande parco, polmone della città, ne è testimonianza.
Io sono arrivato ad Amsterdam ad inizio settembre del ’23, ho incontrato un greco che assomigliava a Tondelli, gli ho tradotto i passaggi ambientati in quel parco e, prese due birre in lattina, montati sulle biciclette (“cigni funebri che girano senza tregua”, secondo Camus) ci siamo diretti verso il parco, romantici, nostalgici, analisti letterari e culturali. Ci siamo seduti sull’erba fracica e abbiamo aperto le birre. Ed ecco l’immaginazione prendere la deriva, il parco delle libertà, dell’amore, il celebre Vondelpark era ancora lì, quelle stesse querce che avevano fatto ombra all’Amsterdam degli anni ’70 erano ancora lì, e noi eravamo appena arrivati, pronti per l’avventura. Da dietro sento qualcosa che mi tocca la spalla. Subito penso alla storia che quello stesso pomeriggio m’aveva raccontato Maia, che mentre guardava un film in un cinema della città si era trovata un topo sulla spalla. Mi giro, vedo una camionetta della polizia, due agenti si ergono impettiti dietro di noi. Il roteare della mia testa fa da interruttore a un’intensa sbraitata in olandese. “English please”, gli dico io. “Volevamo gentilmente comunicarvi a titolo informativo che il Vondelpark è morto”, era stata un’ordinanza del sindaco, dicevano. Che non era vietato stare lì, ma che forse avremmo preso freddo, dicevano. Dopo gli hippies e i gruppi di protezione uccelli, al Vondelpark eran rimasti i poliziotti. Che nessuno lo dica a Tondelli, per l’amor del cielo. Io e Dimitris ci alziamo, prendiamo le biciclette e ci dirigiamo in silenzio verso l’uscita, sembrava fare più freddo di prima. Magari il signor agente aveva ragione, ma secondo me, era solo una sensazione.
Gli italiani ad Amsterdam sono tantissimi, come poi in qualsiasi altro angolo del mondo. Si riconoscono dalla smorfia sofferente che fanno nei bar al momento del pagamento del caffè (in media 3 euro a espresso), dalle occhiaie e dai trattenuti colpi di tosse, sintomo di un perpetuo raffreddamento che accompagna inevitabilmente la permanenza al nord. Un olandese del tipo Vondelpark
[“Forse è piuttosto un Vondelpark. Nel suo aspetto fisico, infatti, c’è la sopravvivenza del tipo nordico degli anni settanta. Il Vondel ha sempre qualcosa che sfugge, qualcosa di leggermente corrotto e vissuto, un che di délabré. Tanto per fare un esempio: i polpastrelli anneriti dalle sigarette rollate con il tabacco.”
(Tondelli)]
mi raccontava di aver scritto un’operetta satirica sulla risibile comunità di espatriati italiani nella sua città, città che – diceva lui – non avremmo mai afferrato, né compreso, e nella quale non avremmo mai messo radici. Partendo dalla nostra ridicola gestualità, dalla nostra ridicola smorfia alla cassa del bar, dal nostro soffrire il meteo. Per non parlare dell’italianissimo ridicolo rapporto col sesso, dettato, inutile dirlo, da una morale cattolica che lui, calvinista-giudaico, riteneva patetica. Era stato con ben più di una italiana, proclama orgoglioso, deludenti nell’atto: era colpa del Papa. Io gli ho chiesto di leggerla, tale brillante commediola (analista letterario e culturale), lui mi aveva detto che per farlo avrei dovuto imparare l’olandese. Io gli avevo detto “col cazzo” e l’avevo mandato a fare in culo. Lui mi aveva detto che lui, a noi, non ci sopportava proprio. Che poi l’avevo incontrato il giorno dopo, alla manifestazione, mentre gridava a squarciagola “siamo tutti antifascisti” – e viva l’Italia.
In un bar di Bruxelles (non si può negare ad Amsterdam il merito di essere vicinissima a Bruxelles) un professore di letteratura italiana mi aveva chiesto come mi fosse venuto in mente di studiare letteratura ad Amsterdam. Una domanda che per ovvie ragioni escludeva, nell’enunciazione, una risposta nemmanco lontanamente intelligente. Ho quindi ripiegato sulla supercazzola della retorica etimologica: “Ma no, non ci siamo capiti: è un corso principalmente basato sugli studi culturali, un corso unico nel suo genere, capace di mescolare letteratura e studi culturali, innovativo, progressista, rivoluzionario, un corso all’olandese”, gli avevo detto. E ancora, che dopo la Brexit Amsterdam era la Nuova Londra, che essere li aveva senso, che era al centro. Lui mi aveva guardato scuotendo la testa: “Potevi stare a Bologna”.
In questa permanenza in Olanda, mi è capitato di vedere, uno a uno, tutti i carissimi amici della sopracitata comunità di italiani espropriati ad Amsterdam (Italians in Amsterdam, su Facebook), sbiancarsi alla semplicissima domanda “Perché Amsterdam?”. La risposta è chiara a tutti noi (mistero della fede): l’università non prevede selezioni, il processo burocratico di iscrizione è semplice, la deadline dell’application tardi. Oppure volevi soddisfare gli investitori e far fruttare l’educazione bilingue. Oppure il sito-cartomante a cui ti eri affidato per la scelta della triennale ti aveva spedito lì, e tutto sommato avevi pensato che fosse inutile essere scettici. In ogni caso questa domanda, in qualche modo, colpiva tutti. Tutti a parte uno, il mio primo coinquilino, il caro Francesco. Classe 2003, s’era formato e aveva sul curriculum quasi un decennio di spaccinaggio a Torino, la sua città natale, e aveva deciso di seguire il proprio sogno, di trasferirsi ad Amsterdam e aprire un coffee shop. Passava le sue giornate a rollare canne da vendere (200 a settimana) al coffee shop dietro casa, di cui era diventato fornitore. Essere ad Amsterdam per lui aveva senso. Amsterdam, la Gerusalemme del Nord (per la grande comunità ebraica), era la sua Mecca. Gli ho mandato un messaggio recentemente, mi ha detto che s’era rotto, era tornato a fare lo spaccino a Torino che tanto cambiava poco e si mangiava meglio.
Quest’estate ero in Sicilia, in un’isoletta, a strinarmi giorno dopo giorno per poter conservare un poco di sole nel sottopelle per affrontare un altro anno di perpetuo inverno. Come quando fai la doccia bollente perché sai che dopo un’ora dovrai uscire e avrai freddo, allora quelle ustioni di primo grado sono – tutto sommato – un investimento per il futuro. Finisci per soffrire sia il caldo prima che il freddo dopo.
Mi era stato riferito che un tal Riccardo sarebbe venuto a cena da noi quella sera, e che avrebbe portato del pesce fresco che aveva pescato quel pomeriggio. Avevano aggiunto che anche lui – come me – abitava ad Amsterdam.
Ecco, quando incontri qualcuno che abita ad Amsterdam è fondamentale capire il prima possibile se siete dalla stessa parte. È sempre brutto trovarsi a elencare le motivazioni per le quali vivere ad Amsterdam – per te – non ne vale mica la pena. Soprattutto non vuoi avere questa conversazione con Riccardo, cinquant’anni, pescatore, in un’isoletta siciliana.
Quando s’arriva ad Amsterdam ci si perde in un loop vorticoso, nel quale si parla sempre e costantemente di tre argomenti: la registrazione al comune, l’assicurazione sanitaria privata e la crisi abitativa. Delle conversazioni sempre uguali e alla lunga svenanti. Per l’insofferenza mi ero inventato di aver scritto un Manifesto in 10 punti che esponeva in maniera completa e strutturata i difetti che rendevano – a mio avviso – la capitale olandese mediocre. Questo documento fittizio portava il titolo: “Ho provato ad accendere un fuoco ad Amsterdam, ne sono uscito fradicio”. Il proto-manifesto contro Amsterdam era ovviamente provvisorio e lacunoso, dopo due anni i punti son cambiati, s’è affinato, ha perso la nomea di manifesto e grazie a dio ha perso il pretesto sociale nel quale esporlo. Solo il titolo ha ancora valore, mi era venuto in mente una notte, quando passando da Leidseplein (la Corso Como di Amsterdam) in bicicletta, sotto una fitta pioggia, avevo visto un senzatetto nel donchisciottesco tentativo di accendere un fuoco – due cartoni della pizza – sotto la pioggia scrosciante. Alla fine, avevo pensato, quella immagine era – e rimane – rilevante per la mia esperienza.
Insomma, mi trovo a tavola con Riccardo e un’altra decina di persone intento a ponderare ogni parola per cercare di restare neutro sulla faccenda, per evitare il discorso. Lui aveva smesso di parlarmi quando gli era stato detto che vivevamo entrambi sotto Re Willem-Alexander, e io avevo capito che stavamo facendo la stessa cosa. Poi, al secondo boccone del barracuda che aveva pescato e cotto, con i pomodorini al forno e le patate, aveva sbottato senza neanche guardarmi: “Ma come cazzo si fa a vivere in una città dove i pomodori sanno di cetrioli e i cetrioli di mele e tutto alla fine sa di acqua, e ti guardi intorno c’è solo acqua, dal cielo vien giù sempre acqua”.
Dopo lo stupore generale e gli attimi di teso silenzio che, da copione, lo incorniciano, io gli avevo detto: “Vecchio mio, allora siam d’accordo”. E mi era balenata l’immagine, di quel pomeriggio di marzo quando mi ero fermato a prendere un caffè in un bar di piazza di Waterlooplein, in un silenzio surreale. Pioveva, faceva un freddo cane, tutto era grigio e buio e, – come sempre – non volava una mosca. Dal nulla era sbucato un losco figuro in bicicletta, con una cassa bluetooth grande come un djembé e a tutto volume, come un arrotino, d’improvviso nella piazza rimbombava la voce di David Parenzo che a La Zanzara si sgolava per qualche stronzata. E io l’avevo capito che quello era un atto di sfregio, che non poteva esserci dalle 6:45 alle 8:45 dal lunedì al venerdì quel disgraziato silenzio, in quella piazza. Avevo fatto una sonora risata, lui si era girato, e ora che ci penso assomigliava proprio a Riccardo quello là, chissà. Mi aveva fatto un segno con la mano, io avevo continuato a ridere e lui aveva continuato la sua processione. Ma ride bene chi ride ultimo: il giorno dopo mi ero svegliato con la broncopolmonite, come ogni maledetto mercoledì.
Mi sono accorto, in Francia, di quanto lo statuto di studente in Olanda valga poco. Essere uno studente in Olanda non ti dà nessun tipo di agevolazione, se non degli irrisori sconti ai musei e ai cinema. Non esiste un abbonamento ridotto per i trasporti, le caffetterie dell’università sono in appalto a privati quindi costano caro, le case ad affitto controllato per studenti hanno una coda di circa un triennio e spesso devi aspettare la magistrale prima che arrivi il tuo turno. Tutto cambia se sei uno studente-lavoratore. L’università ti incoraggia a lavorare. Si innesca il meccanismo tardo-neoliberal secondo cui la qualità e la mole degli studi è minore per permettere allo studente di lavorare. Di base l’Olanda, patria-natale del capitalismo, crede – come mio zio – nell’importanza pedagogica della lezione di umiltà che ti dà spillare una birra appena uscito dal liceo. Imparare a stare al mondo, abituarti ad essere sfruttato, ad entrare nel meccanismo subito, al posto di stare stravaccato sul divano a leggere Gramsci. O come dice, sempre mio zio: “Mica stai ad Harvard, spilla birre e impara a vivere”. A quanto pare il sistema universitario olandese ha deciso di sacrificare l’interesse accademico in funzione di un interesse economico.
Lo studente (internazionale) -lavoratore ha il diritto a trasporti gratis, e ad un generoso bonus a fine mese se ha conseguito un numero minimo di ore. Motivo per il quale pagare la retta universitaria diventa un investimento per le spese quotidiane: è come fare la tessera della Coop. Carmine è da un anno che ha messo da parte gli studi, però sta lavorando e ha comunque pagato la tassa universitaria per avere i trasporti gratis e per andare, ogni venerdì – gratuitamente – in Germania a comprare le sigarette. Più che pagare 12 euro di sigarette, conviene pagare l’università. O ancora, David è fuori corso da un paio d’anni, deve solo consegnare la tesi, ma per restare nello studentato in cui abita – il più economico della città – ha bisogno del certificato di iscrizione dell’università. Per mettere un po’ di soldi da parte e, in un secondo momento, continuare a studiare ha bisogno del bonus dello studente-lavoratore e dei trasporti gratis. Gli conviene quindi essere uno studente-lavoratore, anche se di fatto, da più di due anni non è affatto uno studente. Ecco quindi che per le istituzioni, la tua triennale in Analisi Letteraria e Culturale vale meno di un contratto a chiamata a PizzaSlurp. Per usar le parole di Mark Fisher, nel suo Realismo Capitalista: “Un particolare che vorrei sottolineare è che nessuno degli studenti a cui ho insegnato aveva alcun obbligo di frequentare l’università: se avessero voluto, avrebbero benissimo potuto andarsene. Ma l’assenza di opportunità di lavoro interessanti, assieme al cinico incoraggiamento da parte delle istituzioni, fa sì che l’università appaia come l’alternativa più facile e sicura.”
Nel parlare di questa città ho sempre raccolto un certo tipo di insofferenza. Amsterdam ti chiede tanto e ti da poco. Cerca di essere romantica ma non ci riesce mai pienamente. Cerca di essere scenografica ma non ha una vera e propria geografia letteraria. Una città che a livelli di spazi sociali e culturali è povera e quello che c’è va via via sfumando. Sarà forse una città che soffre la condanna che s’è imposta, ma io dal primo giorno che c’ho vissuto ho avuto l’impressione di non condividerne i valori fondamentali. Ho l’impressione che in Francia, o in Italia, gli altri due paesi in cui mi è capitato di abitare, le cose siano più complesse, magari funziona tutto peggio, ma si è anche più vicini. Il protagonista di Camus evita di passeggiare di notte ad Amsterdam per paura di imbattersi in qualche disgraziato caduto in un canale, e di trovarsi davanti alla decisione tra il buttarsi col rischio di prendere una broncopolmonite o allontanarsi in silenzio e soffrire un meno tangibile senso di colpa. Ecco, secondo me, in altre città questo dubbio sarebbe più facile da risolvere. Ad Amsterdam è così, ci si sfreccia appresso sulle biciclette sotto la pioggia, ci si guarda con poca empatia, ci si fa fatica a compatire. Non si parla con gli sconosciuti, e dalla finestra si vedono le case perfettamente ordinate degli olandesi, che come in una vetrina, si lasciano osservare mentre in camicia e cravatta guardano la televisione. E due strade più in là ci sono le puttane e i tossici, che portano insieme a tantissimi soldi, il turismo più becero d’Europa. La vedete l’autocondanna?
Da un lato ci sono le case, e dietro le grandi finestre del pianterreno, simili a vetrine di negozi, ci sono le stanzette delle puttane che siedono, in mutandine e reggiseno, accanto al vetro, in poltrone piene di cuscini. Sembrano grosse gatte annoiate. L’altro lato della strada è formato da una gigantesca cattedrale gotica del quattordicesimo secolo. Tra il mondo delle puttane e il mondo di Dio, come un fiume che separa due regni, si stende un’intensa puzza di urina.
(Milan Kundera)
Hemingway non riusciva a scrivere di Parigi mentre era a Parigi. S’è trovato a scrivere Festa Mobile, il racconto della sua Parigi, a Cuba. Perché coi posti importanti è così, bisogna guardarli con una certa prospettiva. Amsterdam è stata per me un grande laboratorio, un calderone dove c’ho cacciato dentro di tutto e di più. Io ci cercavo l’avanguardismo del movimento Provo, ci cercavo il porto, i pirati, il mare. Ci cercavo la creatività di Sweet Movie, il romanticismo di Turkish Delight, il pessimismo ironico di Gerard Reve. Ci cercavo Tondelli, la sottocultura, l’eccentricità del nord Europa. Ci volevo studiare ad Amsterdam, studiare tanto, studiare bene. E ora che mi trovo a trarre le somme, guardandola di prospettiva, mi rendo conto che Amsterdam rimane un luogo con cui ho un conflitto. C’ho dedicato anima e corpo, e mi ha – tutto sommato – deluso. Perché io il porto, ad Amsterdam, non l’ho trovato. E neanche l’avanguardismo Provo. Neanche Gerard Reve l’ho trovato. Se voi li avete trovati, fatemi sapere.
Su una cosa però non transigo, non si può ribattere. Amsterdam è la città con più biciclette del mondo. E questa cosa, c’è poco da dire, è carina.
“Come sono belli i canali di sera! Mi piacciono le esalazioni delle acque ammuffite,
l’odore delle foglie morte che macerano nel canale e l’altro, funebre, che sale dai battelli pieni di fiori. No, no, non è affatto un gusto morboso, mi creda. Anzi, in me è un partito preso. La verità è che io mi sforzo di ammirare questi canali. Più di tutto, a me piace la Sicilia.”
(Albert Camus)